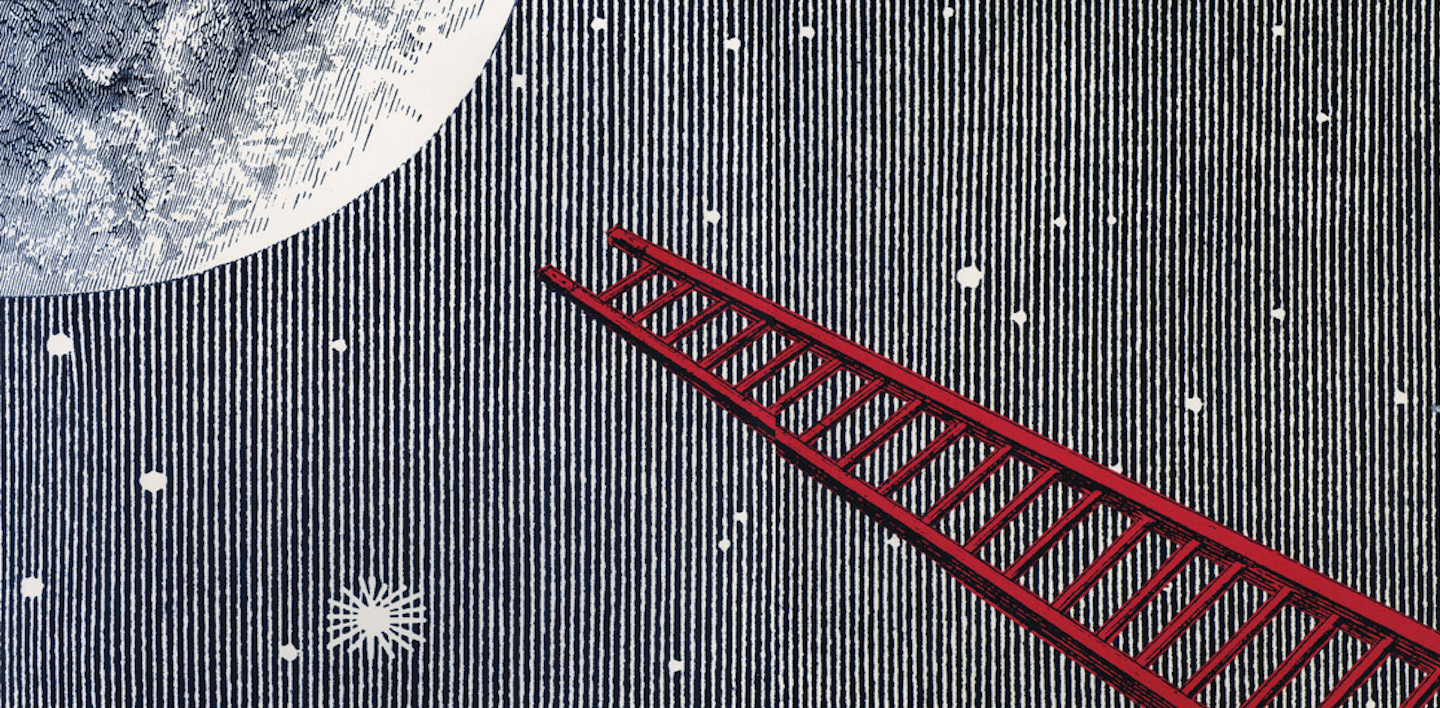
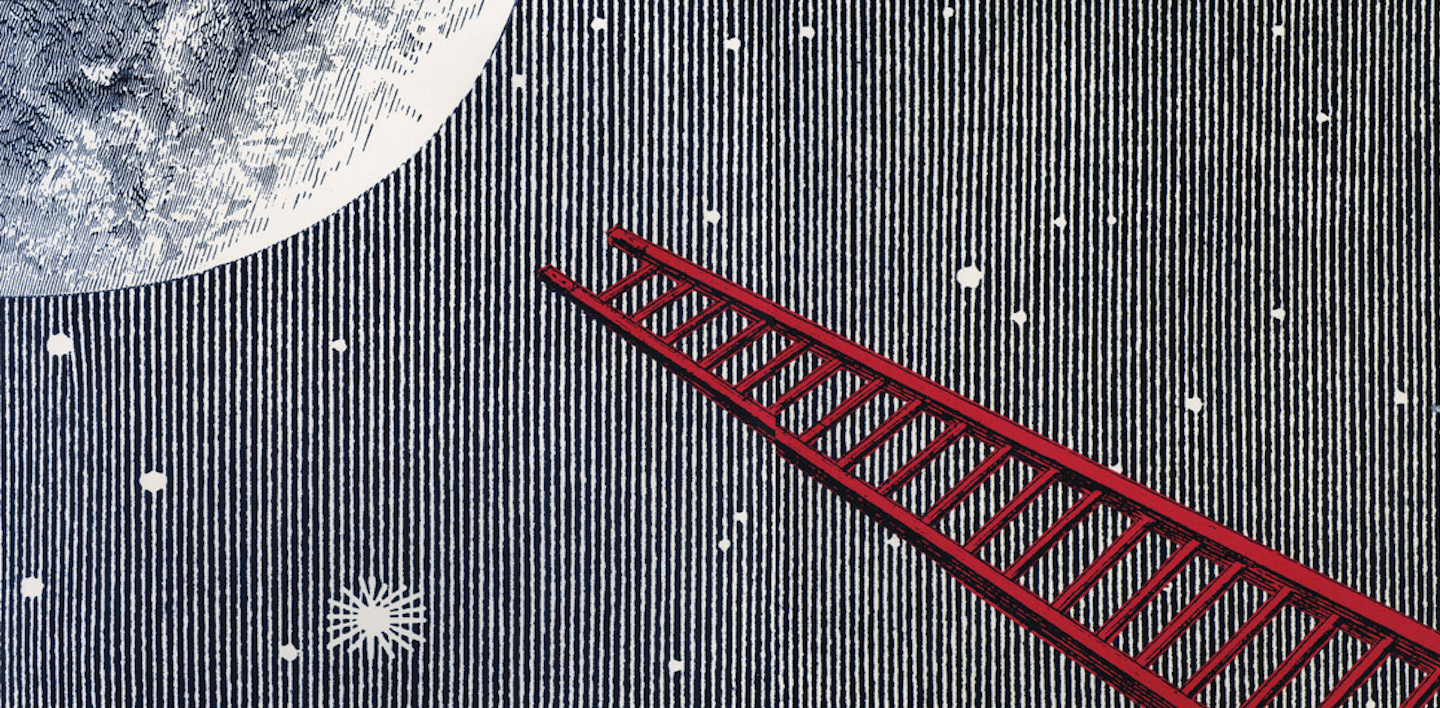
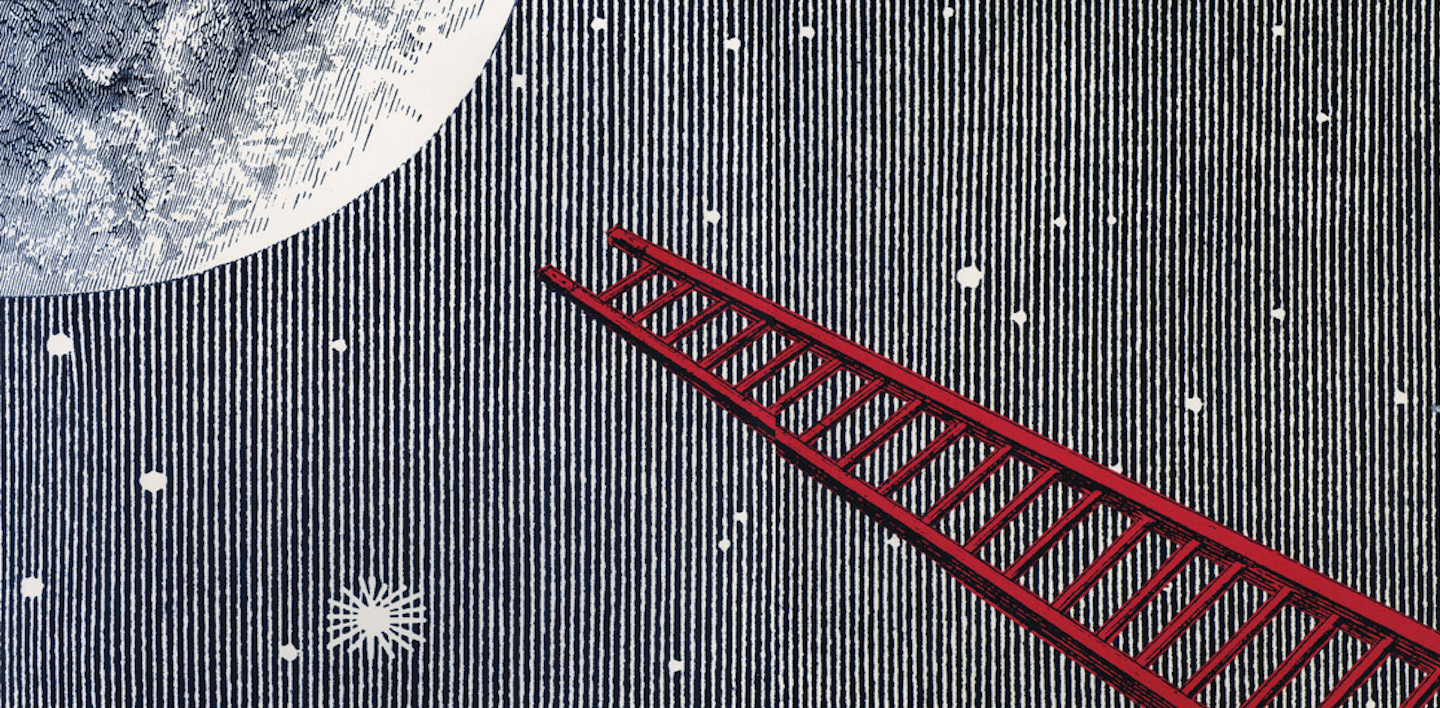
L
eggere la terra e il cielo di Francesco Guglieri, pubblicato in questi giorni per Laterza, è il diario delle letture scientifiche di un umanista: attraverso le pagine di diciannove saggi di divulgazione, Guglieri – post doc in Letterature comparate, editor di Einaudi – racconta perché la scienza ci affascina, ci incanta, ci spaventa, ci seduce e ci sovrasta; un sentimento contraddittorio e straniante che, partendo da Kant, ribattezza “il nuovo sublime scientifico”. I libri che Guglieri prende in esame sono diciannove, e a ognuno è dedicato un capitolo: I primi tre minuti di Steven Weinberg, Dal Big Bang ai buchi neri di Stephen Hawking, Buchi neri e salti temporali di Kip Thorne, La guerra dei buchi neri di Leonard Susskind, L’ordine del tempo di Carlo Rovelli, Viaggi nel tempo di James Gleick, Gödel, Escher, Bach di Douglas R. Hofstader, La quarta dimensione di Rudy Rucker, Origini di Jim Baggott, Il gene egoista di Richard Dawkins, La vita meravigliosa di Stephen Jay Gould, Plant Revolution di Stefano Mancuso, La scimmia nuda di Desmond Morris, Sapiens di Yuval Noah Harari, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sakcs, L’invenzione della natura di Andrea Wulf, Spillover di David Quammen, La sesta estzione di Elizabeth Kolbert e La grande cecità di Amitav Ghosh.
Leggere la terra e il cielo è stato lo spunto per questa conversazione tra Francesco Guglieri e Matteo De Giuli, senior editor del Tascabile, per parlare del rapporto tra divulgazione, cultura e mercato editoriale, di Philip Dick e Italo Calvino, di giornalismo e letteratura.
Matteo De Giuli: In Leggere la terra e il cielo parti dall’analisi culturale di una ventina di libri di scienza: fisica, matematica, biologia, evoluzione e cambiamenti climatici, e a quei racconti ne intrecci altri, riflessioni, citazioni letterarie, vicende autobiografiche. Quelli che analizzi sono libri anche molto diversi tra loro, ma mettendoli insieme crei subito un’estetica comune. Perché in effetti quelli di Oliver Sacks, David Quammen, James Gleick, Carlo Rovelli sono libri che vivono in una sorta di sotto-genere senza nome, ibrido, nell’area X tra saggistica, divulgazione scientifica e letteratura.
Francesco Guglieri: Può sembrare paradossale in un libro che, di primo acchito, sembra parlare di scienza, dire che la scelta che mi ha guidato è stata prima di tutto “sentimentale”. Ma in fondo la scommessa che mi ha convinto a scrivere Leggere la terra e il cielo era proprio provare a scompaginare le attese, i formati (anche editoriali) e le forme. I libri di cui scrivo non sono per forza i “più belli”, o i più importanti dal punto di vista storico, ma quelli che hanno contato per me: e già così aggiungi una certa dose di soggettività a qualcosa che dovrebbe stare sotto il regime dell’oggettivo. Quando non di casualità, perché così entrano in gioco gli accidenti dell’esistenza: ci sono libri che mi erano capitati in mano da adolescente, altri che mi hanno confortato in un momento difficile dell’età adulta, altri poi influenzati da passioni culturali diverse come la fantascienza… Insomma, entra in gioco la vita: perché il punto è “Cosa ne facciamo di tutto quello che leggiamo?”, che ricadute ha sulla tua vita, sulle tue scelte, sul tuo modo di vedere il mondo? Cosa te ne fai? È una domanda che mi ossessiona, capirai bene, avendo passato la quasi totalità della vita adulta a leggere, per passione o per lavoro: vale per la letteratura d’invenzione, ma vale anche per i libri di scienza. E adesso, che ci faccio? Posto che, per quanti libri di Rovelli, o chi per lui, io possa mai leggere, non diventerò mai un fisico delle particelle, o che se anche leggo tutto Sacks non mi trasformo in uno psichiatra neanche di striscio, cosa ne ricavo? Del resto se leggo Tolstoj non è che divento una fedifraga suicida – anche se per un certo tempo, mentre leggo Anna Karenina, ho questa impressione, si produce questa trasformazione – né un generale dell’Armata napoleonica. Allora perché lo facciamo?
Quindi l’idea alla fine è: prendiamo dei libri, e proviamo a fargli fare anche altro oltre a quello per cui sono stati scritti. Dirottiamoli, hackeriamoli e vediamo cosa viene fuori. E così li ho messi insieme in modo che, da una parte, raccontassero, uno dopo l’altro, ognuno per il suo pezzettino, la storia dell’universo, dal Big Bang all’antropocene, passando per l’infinitamente grande della cosmologia al piccolo della fisica fondamentale, la formazione della vita, l’evoluzione, il mondo dell’uomo. E, dall’altra parte, facciamoli reagire con qualcosa d’altro, lasciamogli dire delle cose che solitamente non ci aspetteremmo da loro: facciamoli parlare di memoria, rimpianto, bellezza, paura, nostalgia, fragilità, stupore.
MDG: Non a caso, nonostante il tuo sia un libro che gira attorno alla divulgazione scientifica, finisci per citare spesso Philip K. Dick, per esempio. Che è una cosa che può spiazzare perché Dick è uno scrittore molto poco scientifico, secondo me. Dagli altri grandi autori di fantascienza siamo abituati a storie a orologeria, piene di teorie, paradossi e alambicchi, da Asimov e Clarke fino a Chiang, sono spesso scrittori su cui si possono ricavare quei saggi del tipo “La scienza nei romanzi di…”. Invece Dick mi sembra un caso abbastanza raro di autore di fantascienza senza fascinazioni scientifiche, uno che era completamente disinteressato alla dinamica esatta dei viaggi nel tempo o ai paradossi della meccanica quantistica, uno che non si faceva in quattro per far finta che i calcoli tornassero. I libri di Dick si giocano tutti sul campo del misticismo, della religione, dell’umanità e delle sue falle. Nelle sue storie la realtà è una questione di percezione e pensiero magico, non c’è mai nessuno “spiegone” scientifico, nessuna pretesa di plausibilità.
FG: È un autore che amo molto. Uno di cui ho letto tutto tutto, e l’ho fatto negli anni più formativi, intorno ai venti. Certo, ci sono altri autori che amo e di cui ho letto tutto: solo per rimanere alla fantascienza ci sono Ballard e Gibson. Ma prendi Ballard, autore peraltro letterariamente più raffinato di Dick: nella sua dimensione critica, Ballard offre uno straordinario armamentario immaginativo e intellettuale per leggere e smontare la società di oggi, ad esempio. Ma mi sarebbe servito a poco per lo scopo per cui ho scritto Leggere la terra e il cielo. Alla fine Dick, invece, con la sua umanità, la sua emotività esasperata, folle e visionaria mi dava la possibilità proprio di gettare quel ponte tra due mondi, due sensibilità. Il sentimento di struggente nostalgia che promana dalle sue pagine quando parla di entropia nel mondo di Ubik, per dire.
MDG: Partiamo dai primi due libri che analizzi, perché secondo me ci possono raccontare qualcosa sul rapporto tra lettori, cultura e divulgazione. Sono libri difficili ma di grande successo: Dal Big Bang ai buchi neri di Stephen Hawking e I primi tre minuti di Steven Weinberg. Quando parli di Hawking citi la perfidia che si dice in giro, che quel libro lì sia “il libro più venduto e meno letto della storia”: la definisci una leggenda, ma secondo me è un’ipotesi plausibile, sia perché ha venduto davvero tanto sia perché in certe parti è piuttosto ostico, e non biasimo chi l’ha abbandonato a metà. Di Weinberg e del suo besteller scrivi invece che è “un libro controllato e allergico a qualsiasi spettacolarizzazione”. Ma come hanno fatto ad avere così tanto successo, in termini di vendite globali, libri che a sfogliarli sembrano così poco seducenti? La questione secondo me è che, di là di come erano scritti, avevano dietro un’idea di marketing vincente, un’intuizione geniale. A Weinberg in fondo bastava la frase: “molto poco di interessante è accaduto dopo i primi tre minuti” [dall’origine dell’universo a noi].
FG: Va fatta una premessa: quelli di Weinberg e Hawking sono anche due testi “vecchi”, usciti tra la fine degli anni Settanta e la metà degli Ottanta. Questo vuol dire almeno due cose. La prima è che il contenuto è, per alcuni aspetti, datato, superato dalle nuove scoperte (basti pensare che I primi tre minuti non contempla il modello inflazionario che sarebbe stato proposto da Alan Guth solo pochi anni dopo l’uscita del libro); e poi che sono meno influenzati dalle “mode” della divulgazione successiva, sia nel bene che nel male. Sono senz’altro meno “piacioni” ma anche meno sensibili alle esigenze del famoso “lettore comune”.
C’è un libro di Grace Paley che si intitola L’importanza di non capire tutto. Mi è tornato in mente quando il mio libro ormai era in stampa, altrimenti l’avrei senz’altro citato: è possibile, anzi è inevitabile, che il lettore non specialista alla fine di questi libri possa “non capire tutto”. Di certo è capitato a me. Del resto quello che volevo raccontare io è proprio quel momento in cui “smetti di capire tutto” e scatta qualcos’altro. Qualcosa di opposto all’ignoranza o alla superstizione, alla paranoia o alla paura. No, è qualcosa di più simile alla disponibilità all’ascolto. Smetti di incasellare il mondo nelle categorie e nelle maglie che già possiedi, ma ti apri all’imprevisto, all’avventura, all’inaudito, all’esorbitante. Al nuovo sublime. Nuovo perché è appunto quello a cui ci ha dato accesso la scienza contemporanea, le sue scoperte e le sue teorie. Il sublime di cui parlava Kant, gli esempi che faceva, come terremoti (per lui era fresco il ricordo di quello di Lisbona del 1775) o tempeste, per quanto distruttivi negli effetti oggi non appaiono più così sconcertanti: li conosciamo, sappiamo come funzionano. Buchi neri, entanglement quantistico, gli abissi del tempo geologico, la nascita della vita, l’idea stessa di antropocene dischiudono invece tutto un altro livello di sublime, di bellezza e terrore (“Il bello è del terribile ciò che riusciamo a sopportare” diceva Rilke), ma anche di potenziale trasformativo per la nostra mente, per la nostra sensibilità.
MDG: Però questo meccanismo determina anche un rovescio della medaglia non trascurabile, secondo me. E per questo parlavo di marketing. Mi spiego meglio: prendi Numeri, teoremi & minotauri di Roger Penrose, per esempio, che giustamente non è nella tua lista: è un libro che critica il successo mediatico di teorie affascinanti ma tutto sommato inconsistenti come la teoria delle stringhe, ed è un libro tecnico e contorto, impenetrabile, di 700 pagine, quasi totalmente incomprensibile per chiunque (io almeno non ho capito quasi nulla di quello che c’è scritto, nonostante abbia studiato fisica teorica all’università). E non so se si può definire un bestseller, ma mi ricordo che guardai le classifiche di vendita, all’epoca, ed era tra le prime posizioni; per qualche settimana lo è stato anche in Italia. Forse perché Penrose veniva citato in Inception, uscito più o meno in quel periodo? Per me comunque è ancora un mistero, in parte anche piuttosto inebriante, il fatto che libri così possano avere successo e vendere milioni di copie. Ma davanti a questi casi mi sembra che emerga un fatto: quello che, nel bene, rende i libri di scienza speciali, fonte di meraviglia e sublime, come scrivi tu, li rende anche, nel male, inevitabilmente distanti dagli altri libri. Ovvero i libri di scienza sono spesso trattati – sia da chi li scrive che da chi li compra – come opere senza una vera dignità culturale. Non riescono o non vogliono essere tasselli all’interno del dibattito intellettuale, rimangono come una sorta di strani dispositivi mistici capaci di creare meraviglia nel lettore, puri prodotti – marketing appunto –, magari utili a farci sentire più intelligenti e che compriamo a prescindere da quello che dicono e di come lo dicono, come fossero raccolte di sudoku o antologie di curiosità e fatti poco noti.
FG: Ciò che dici, sulla relativa separazione (autonomia? Marginalizzazione? Mercificazione?) dei libri di scienza, è vera. Anche qui, ci sono tanti fattori: storicizzare parlando delle “due culture” che, soprattutto in Italia, hanno tenuto separate scienza e letteratura, sarebbe lungo, noioso (perché l’hanno fatto già, e meglio, altri prima di me), ma alla fine sarebbe soprattutto inutile perché mi sembra che ne siamo fuori. Oddio, detta così pecco un po’ di eccessivo ottimismo della volontà, però, sì: in futuro, un futuro già iniziato secondo me, non ci sarà, non c’è più questa divisione, non ha più senso parlarne neanche per combatterla. Sia a livello di discussione pubblica che per quanto riguarda la creazione letteraria o la riflessione culturale nel suo complesso. Intanto perché a livello di discussione pubblica c’è una domanda diffusa e urgente di risposte da parte dei lettori (ma direi: dei cittadini), un desiderio di capire i fenomeni. Più il mondo appare (ed è) complicato, interconnesso, confuso, inconoscibile nella sua (sublime, appunto) totalità più cresce la voglia di capire di non accontentarsi di risposte semplici. So anch’io, ovviamente, che hanno molta più fortuna e diffusione le risposte semplici, semplificatorie, i capri espiatori. Ma se non ascoltiamo anche chi vuole risposte complicate, se non siamo i primi a volere risposte complicate, non andiamo da nessuna parte.
MDG: Naturalmente poi quando si parla di saggistica scientifica si mettono ingiustamente insieme tante cose diverse in un unico calderone, e lo sto facendo pure io. E invece c’è la divulgazione giornalistica, puramente informativa, e poi quella scolastica, e sono tutti approcci più che degni, addirittura utili anzi, ma in questo campo i libri più interessanti, almeno per i miei gusti – e mi sembra che siano anche quelli che incuriosiscono di più te –, sono altri. Lo dici benissimo per esempio quando parli dei casi dei pazienti neurologici raccontati da Sacks: “I racconti di Oliver Sacks hanno spesso questa struttura: in una scena apparentemente normale si insinua qualcosa di perturbante, scivola dai bordi della visione un elemento che non si riesce a riconoscere subito, a inquadrare dentro categorie conosciute, qualcosa di così alieno che è addirittura difficile identificarlo come tale. E poi, all’improvviso, quel piccolo dettaglio viene messo a fuoco, balza in primo piano e trasforma ciò che è noto in sconosciuto, ciò che è familiare in qualcosa di spaventoso, il quotidiano nella scena di un orrore senza spiegazione”. Più avanti dici che i libri di Sacks hanno la capacità di raccontare la vita che solitamente pensiamo esclusiva della letteratura.
FG: Ho volutamente scelto libri di autori molto diversi: ci sono scienziati (premi Nobel compresi) soprattutto, ma non solo. Anche science writers, giornalisti, uno scrittore come Amitav Ghosh. A un certo punto del progetto mi sarebbe piaciuto inserire anche altri scrittori, filosofi (come Timothy Morton ad esempio). In un mondo ideale – e non è detto che in futuro non ci si arrivi – ci potevano stare anche romanzi, opere di fiction: non avrebbero contraddetto o scalfito il progetto, anzi. L’unica regola che mi sono dato, d’accordo con l’editore, era di includere libri “leggibili”. Testi cioè fruibili da chiunque (non articoli scientifici specialistici quindi, o pubblicazioni accademiche), più o meno contemporanei e disponibili a un lettore italiano. Quelli scelti sono testi molto diversi anche per qualità letteraria, certo. Non credo di dire un’assurdità se dico che quelli di Sacks sono di gran lunga i più belli dal punto di vista letterario – al punto da far pensare che Sacks sia uno scrittore che usa la scienza, i casi clinici, per raccontare le sue storie e la sua visione delle cose più che il contrario. Al punto che dalla comunità scientifica e medica è spesso stato criticato per questo. Fatto sta che nei suoi libri è certo più facile riconoscere le categorie del “letterario”. Ma il bello era proprio provare a cercare quegli elementi, diciamo i geni di ciò che chiamiamo letteratura, anche là dove sarebbe meno scontati trovarli: ma per farlo bisognava prima liberare tutte le aspettative classiche che ci facciamo sull’idea di letteratura, come personaggi, intreccio, mimetismo. No, c’è qualcosa di più fondamentale, di più profondo che i racconti di scienza e quelli letterari condividono.
MDG: Un discorso simile vale anche per David Quammen, che può essere considerato un altro “vero scrittore”: quando in Spillover racconta dei suoi viaggi in giro per il mondo, dal Congo alla Cina, grazie ai quali ricostruisce la storia di virus e epidemie, in certi passaggi sembra di leggere una strana miscela di Faulkner e Crichton. Ed è un libro che ha fatto anche un grande lavoro informativo, di educazione quasi, su temi ancora poco noti – tant’è che oggi, in tempi di COVID-19, tutti lo citano. A questo punto però si apre forse una questione, cioè quella della non-fiction, e quindi se è davvero possibile fare letteratura e giornalismo insieme, perché in fondo è di questo che stiamo parlando. E se parliamo poi di giornalismo in ambito scientifico le cose si complicano ancora di più. Perché quando si scrive di scienza bisogna essere precisi, e invece lo spazio che divide giornalismo e letteratura è lo spazio della creatività, dell’ambiguità, e come fai ad essere ambiguo con la scienza?
Walter Siti, come sai, è molto critico su questo, ha scritto dei saggi bellissimi sul rapporto della letteratura con la verità, e quando li leggo mi sembra di essere d’accordo con lui, mi sembra impossibile che le due cose possano mescolarsi: il giornalismo deve avere i suoi codici e i suoi linguaggi mentre la letteratura deve averne altri. La verità fattuale (che per Siti è “storica” o “giornalistica”, appunto, ma possiamo aggiungere a maggior ragione “scientifica”) e la verità letteraria vivono in campi logici differenti. Eppure poi quando leggo Quammen, quando leggo Sacks, quando leggo Carrère che racconta Alan Turing (in uno dei saggi di Propizio è avere ove recarsi) o quando scopro libri come La vita segreta, di Andrew O’Hagan, mi sembra che invece questa unione possa funzionare.
FG: Discorso affascinantissimo e super interessante. Almeno per me, non so quanto per il resto del mondo… Ma insomma, andiamo avanti. Premessa personale: come sai, e come scrivo nel libro, io ho una formazione letteraria, in particolare ho studiato proprio il romanzo, il romanzo moderno, quel generone che è diventato, piaccia o no, la corazzata della flotta della letteratura da metà Settecento a oggi. E che ha nel romanzo ottocentesco, da Jane Austen, Stendhal, i russi, Flaubert e compagnia danzante il suo apice e canone. Quello del Novecento, in fondo, si potrebbe vedere come una reazione a esso, ma sempre lì stiamo. In questo contesto le osservazioni di Siti sono tanto acute quanto convincenti, e le condivido. Ma, sai, Kafka diceva “Nella guerra tra te e il mondo, scegli il mondo”. Per cui tendo sempre a contraddire o mettere in dubbio le convinzioni che sento più mie. Il punto è questo: il romanzo moderno è l’“imitazione seria del quotidiano”, diceva Auerbach, è il novel egemone e indicato come “alto”, contrapposto al romance, al fantastico, avventuroso, ridotto a narrativa di genere o di consumo. Il romanzo moderno, il romanzo borghese, è il racconto del quotidiano, della vita di tutti: è il racconto dell’avventura, dello straordinario (perché in fondo qualcosa lo devi raccontare) nascosto però, camuffato, nell’ordinario. Ecco – stiamo arrivando al cuore della questione, scusa la digressione – il romanzo contemporaneo sta capendo quanto quel modo di raccontare lì non funziona più. O meglio: non riesce più a rendere conto di un mondo in cui lo “straordinario è il nuovo ordinario”, non sa come maneggiare quello che, appunto, chiamo “nuovo sublime”. Dai cambiamenti tecnologici, nei rapporti di produzione, al cambiamento climatico. Pensa solo a quello che sta succedendo oggi con la pandemia globale di Coronavirus. Serve qualcosa che non nasconda più lo straordinario dentro l’ordinario. Per questo chiudo il mio libro parlando della Grande cecità di Amitav Ghosh che ragiona su temi simili. Come racconto il nuovo sublime?
Quindi, come ti dicevo nella risposta precedente, c’è – secondo me – un livello più profondo in cui racconto letterario e racconto scientifico si parlano, si legano. Accedere a questo livello, a questo terreno comune, è ciò che muove gli autori che citi, o che spingeva Calvino a usare la scienza come “riserva di caccia per le immagini”. Per raccontare il nuovo sublime, aggiungo io.
MDG: E Calvino lo disse per difendersi da alcune critiche di Margherita Hack. La storia la racconti anche tu nel libro: Calvino (come Primo Levi, tra gli altri) si appassionò di un articolo di Kip Thorne (tradotto in italiano su Le Scienze) che raccontava quelle che all’epoca erano le prime ricerche sull’esistenza di buchi neri attorno a una sorgente di raggi X nella costellazione del Cigno. Era il 1975. Calvino ne scrisse, romanzando un po’ le cose, nella sua rubrica “Osservatorio del signor Palomar”, sul Corriere della Sera. Margherita Hack gli fece cordialmente notare di aver preso qualche cantonata scientifica. Calvino rispose in quel modo lì: per uno scrittore la scienza è una “riserva di caccia per le immagini”. In altre parole: la letteratura non deve per forza caricarsi delle stesse responsabilità di correttezza della divulgazione.
A ogni modo ne abbiamo avuti diversi, in Italia, di romanzieri che si sono innamorati della scienza (e di scienziati-romanzieri). Forse abbiamo avuto più raramente grandi saggisti divulgatori. In inglese uno dei modi di chiamarli è science writers, un termine che non a caso è intraducibile qui, dove fai il giornalista scientifico o fai lo scrittore. Prima tu ti sei smarcato con grande agilità quando hai intuito che stava per arrivare la classica domanda sulla separazione tra cultura umanistica e cultura scientifica in Italia. È una domanda che inevitabilmente ogni tanto fanno anche a me, e a cui non so mai cosa rispondere, e in effetti speravo di poterla scaricare a qualcun altro per una volta. Non te la farò, però una cosa che salta comunque all’occhio scorrendo l’indice del tuo libro è che ci sono solo due autori italiani tra quelli che racconti, Stefano Mancuso e Carlo Rovelli – e in fondo anche Rovelli, secondo me, non possiamo prenderlo davvero come espressione della realtà italiana, fa caso a sé.
FG: Come per tutti i discorsi simili (ad esempio: perché in Italia ci sono così pochi autori di essay? Perché c’è una tradizione di “prosa d’arte”, ora in disuso, ma non una vera tradizione di essay?) bisogna ribaltare “le colpe”, secondo me. Non c’è una gran tradizione di science writers, mancano autori di narrative non-fiction intorno alla scienza, non certo perché agli italiani manca qualche cromosoma, ma perché mancano i contesti in cui questo tipo di scrittura possa crescere e far crescere un suo pubblico. Riviste, innanzitutto, che accolgano e richiedano pezzi lunghi su questi temi. E editori che ne pubblichino i libri con continuità. Ma anche qui voglio essere ottimista. Come per l’essay, il vero crinale è generazionale: c’è una generazione di under-40 che, per formazione cosmopolita, sa di cosa stiamo parlando e presto o tardi darà delle soddisfazioni anche in questo campo.