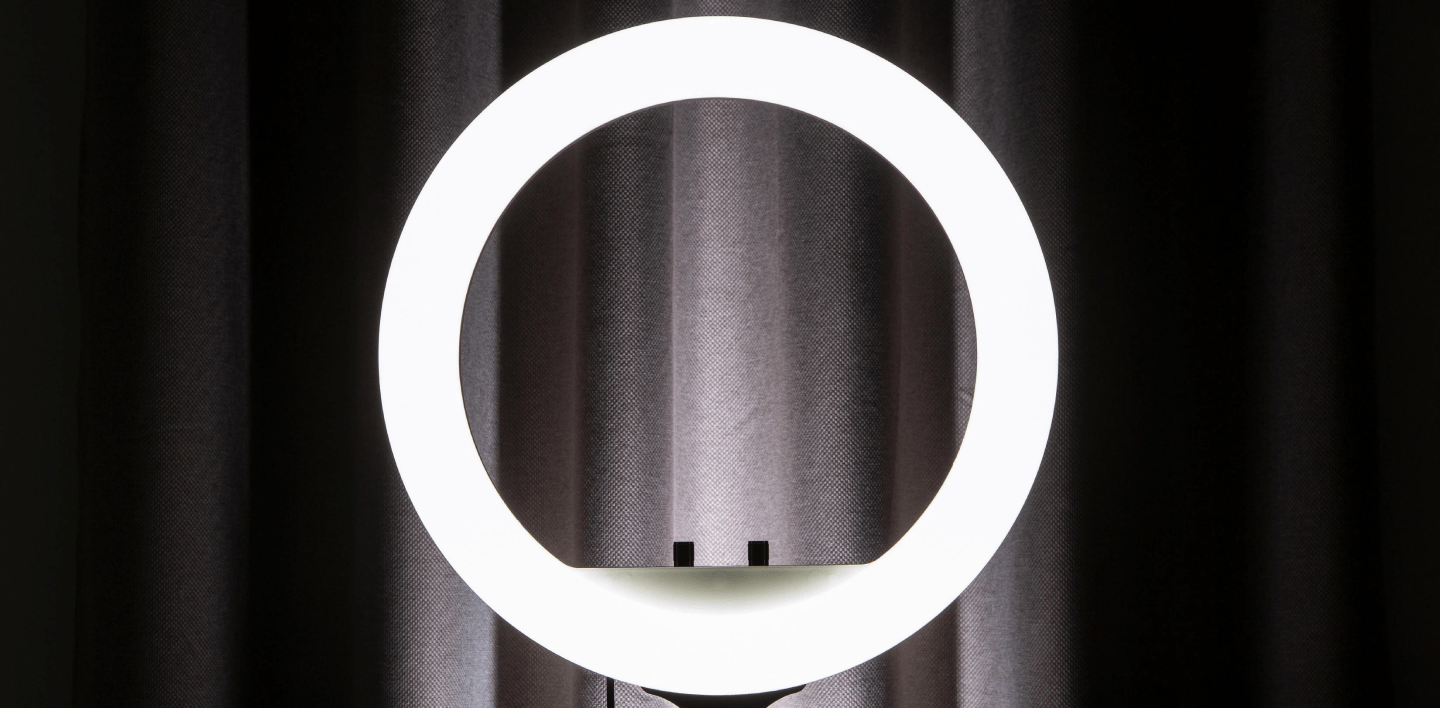
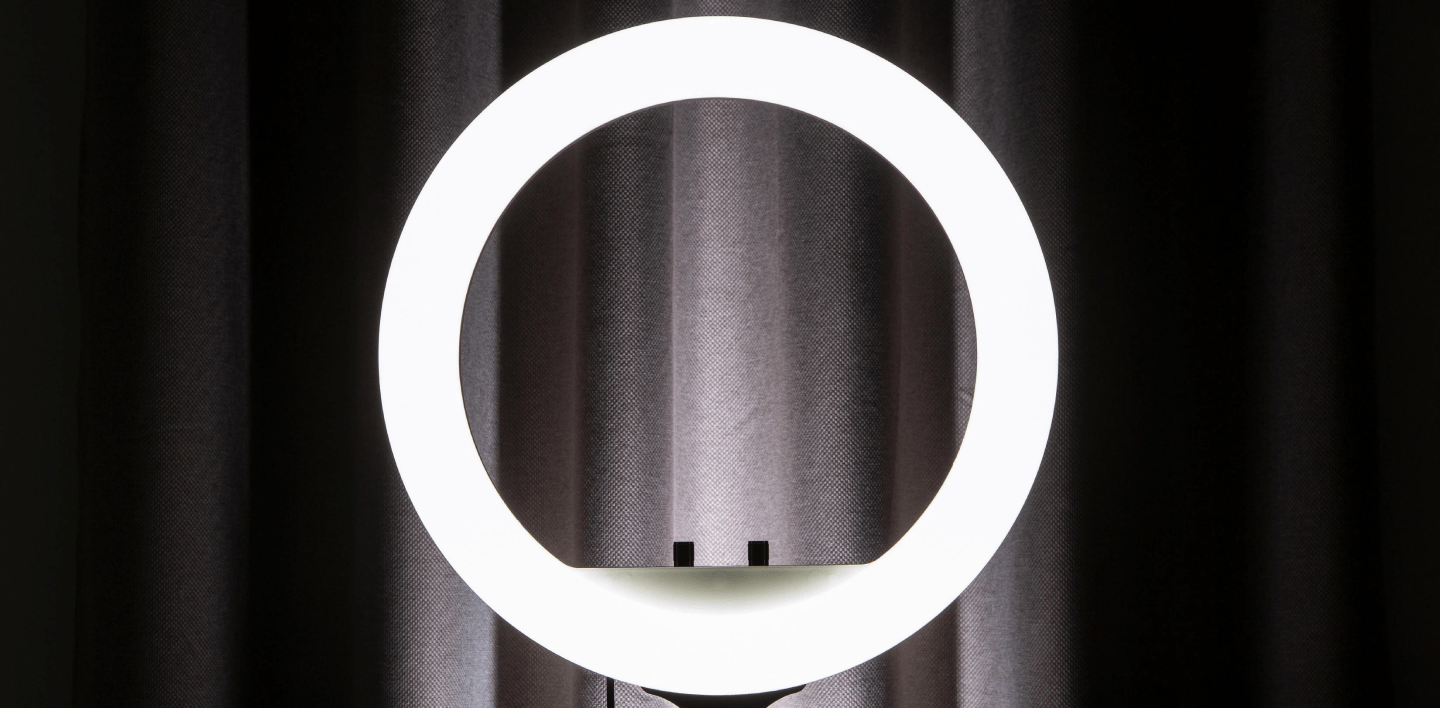
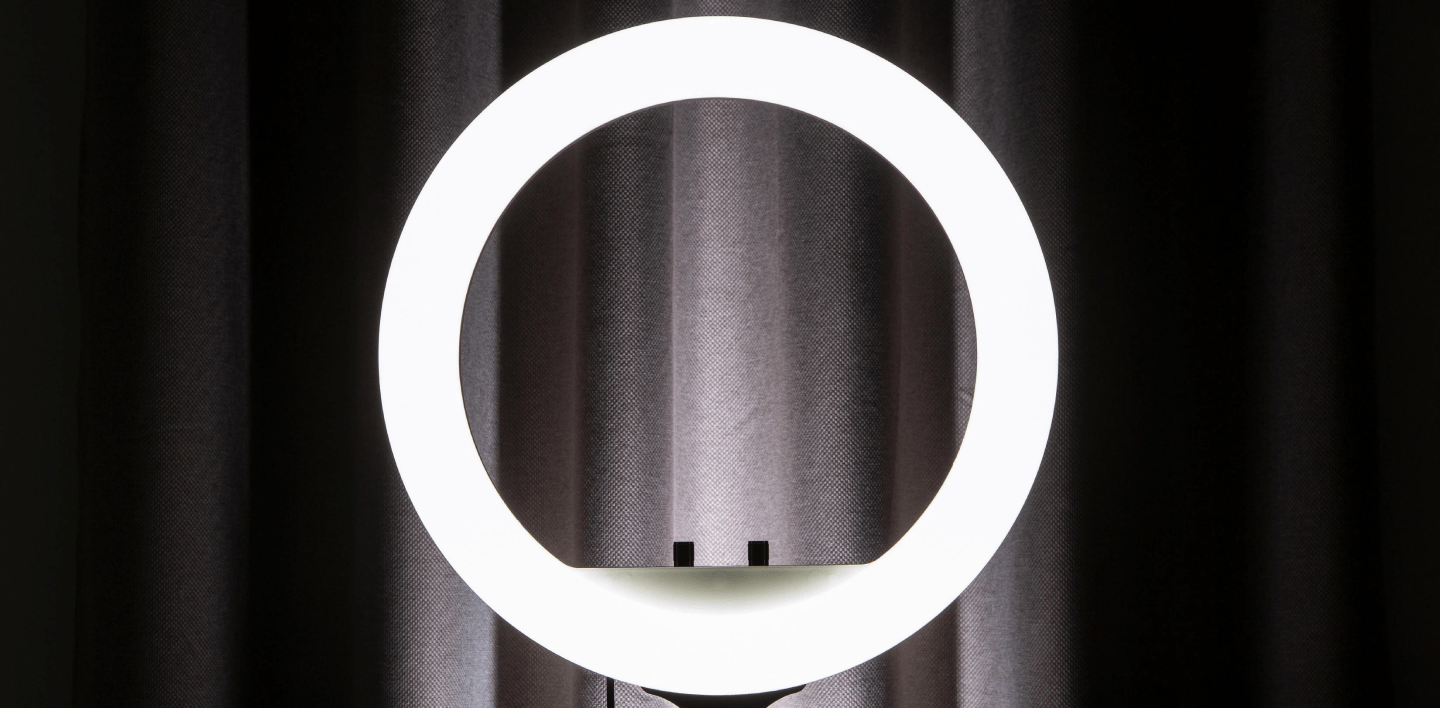
U ndici anni fa, alcuni critici letterari (Giancarlo Alfano, Cecilia Bello Minciacchi, Clotilde Bertoni, Federico Bertoni, Raoul Bruni, Alberto Casadei, Matteo Di Gesù, Daniele Giglioli, Claudio Giunta, Gabriele Pedullà, Pierluigi Pellini, Gianluigi Simonetti, Italo Testa, Antonio Tricomi, Paolo Zublena) chiesero ad altri critici letterari: “Il dominio assoluto della rete nel dibattito critico contemporaneo ha mutato secondo voi i metodi e i linguaggi della critica, o li ha perlomeno condizionati? E qual è secondo voi il rapporto della rete con il mercato?”. Sulle pagine di Allegoria, una delle riviste più autorevole in quanto a statuto – ontologico e deontologico – della critica letteraria, questi critici ragionarono su cos’è, cosa è diventata, cosa dovrebbe essere.
Tutti convergevano nel ritenere la rete come l’esplosione delle opportunità comunicative, un posto in cui la fruizione e la condivisione di informazioni e testi, sempre più forsennata, aveva in molti casi superficializzato i linguaggi e accorciato il tempo delle riflessioni.
Nel 2012 non c’era, quindi, grande fiducia nelle potenzialità della rete per quello che concerne la fioritura del discorso critico sulla letteratura. Lo spazio infinito, la possibilità di “fondare” blog con pochi clic e pochi euro, pagare un nulla i collaboratori con la promessa di una verde, infinita distesa di lettori e lettrici, la velocità di esecuzione e la ancora più velocità di fruizione dei contenuti, il culto della performance e della visibilità inestricabili dal culto della persona – Internet sembrava essere l’incarnazione dei peggiori incubi di chi temeva che ormai valesse molto di più una foto di un libro ben posizionato su un’ottomana che una dissertazione sulla varietà dei registri in Gadda.
E avevano – hanno – ragione: su Internet la foto della mia mano esangue che tiene in aria l’ultima fatica di Sally Rooney, con le dita che fanno giochi di ombra intrecciandosi con la tendina ricamata di mia zia e lo smalto rosso vermiglio, vale molto più del long-form che potrei mettermi a scrivere sempre io contro Sally Rooney e la sua prosa da quarta elementare che dobbiamo tutti fingere di trovare brutalmente onesta, in modo quasi disturbante, pena l’essere esclusa dai giri giusti – alcuni giri giusti.
Abbiamo dato un corpo al libro e dimenticato che esso è prima di tutto un prodotto dal valore incommensurabile.
Ma, dunque, la paura dieci anni fa era questa: che la rete portasse con sé critici raffazzonati, convinti che per analizzare un testo bastasse leggerlo dal capo ai piedi senza addurre una contestualizzazione di qualunque tipo – storica, stilistica, etc. E i loro incubi peggiori non solo si sono avverati ma nel frattempo siamo arrivati, sempre più velocemente, ai balletti con i libri, le foto provocanti con le saghe di Harry Potter, i video di unboxing dell’ultimo Stephen King.
Abbiamo dato un corpo al libro e dimenticato che esso è prima di tutto un prodotto dal valore incommensurabile. “Valore”, delizia e tormento: tutto si gioca su cosa intendiamo, perché da un lato prevale l’aspirazione a che il libro non venga abbassato alle logiche commerciali ma, dall’altra, come operatori culturali siamo ugualmente sottoposti alle classifiche dei libri che vendono di più settimana dopo settimana.
Siamo arrivati al libro snaturato, da testo a immagine auto-sussistente. Lo abbiamo reso definitivamente una merce: lo tocchiamo, lo mettiamo su un tavolo insieme ad altri oggetti. Lo oltraggiamo, lo ultra-oggettifichiamo, lo rendiamo oggetto tra gli oggetti. Se Internet è pensato a partire dalle idee di velocità e quantità, il primato delle immagini non dovrebbe disturbarci, vero? Dovremmo esserci un po’ abituati, no? Eppure c’è una questione impellente, una questione che rispetto a molti altri prodotti – anche culturali – non viene quasi mai sollevata ma in questo ambito sì: “Perché si parla tanto di libri sui social?”. La domanda giusta però sarebbe un’altra, ovvero: “Perché si parla tanto del fatto che si parli di libri sui social?”.
Fenomenologia sommaria del discorso pubblico sui libri
A livello mediatico, negli ultimi anni abbiamo conosciuto il tentativo, per l’invero un po’ bilioso, delle stroncature di Michela Murgia ospite del programma “Quante storie” condotto da Corrado Augias, delle sparate contro bersagli facili come Fabio Volo o Diego Fusaro. Integrazione perfetta dell’amichettismo dilagante che dà l’aria di una setta al circuito culturale e lo allontana da chi non ne partecipa, le stroncature facili divertono e intrattengono e ognuno va a coricarsi contento di trovarsi un po’ più cattivello. Il pasto perfetto per il finto pubblico di massa che segue un programma di cultura su Rai 3 condotto da Augias.
Poi, se ci troviamo nella condizione economica, ambientale e caratteriale di poterci dire “lettori forti” – bastano 12 libri all’anno –, a noi si rivolgono anche le penne delle riviste culturali, delle terze pagine dei quotidiani, dei supplementi della domenica. Se però, ahinoi, siamo lettori deboli – bastano 11 libri all’anno – e non abbiamo un rapporto di consolidata fruizione con l’oggetto-libro, abbiamo i social. Non è raro trovare le testimonianze di lettori – soprattutto tra i giovani e giovanissimi – che hanno rinverdito il loro rapporto di fiducia con i libri tramite i consigli di content creator e/o influencer, seguendo un personaggio talent che ha poi scritto un libro, o avendo apposto il “follow” a una pagina di divulgazione che poi è esplosa in brossatura fresata per Mondadori.
Siamo arrivati al libro snaturato, da testo a immagine auto-sussistente: lo abbiamo reso definitivamente una merce.
Avevano ragione, i critici; e quando nel 2012, con il discorso online sui libri ancora capitalizzato da blog, forum e riviste, parlavano della rete, non avevano visto arrivare la valanga latentemente nichilista delle possibilità social del libro. Attualizzando, ad oggi il panorama è ferocemente più variegato: abbiamo ancora le pubblicazioni cartacee e gli inserti culturali che, spesso, hanno una loro presenza digitale residuale, intendendo l’online come punto di approdo oramai indiscutibile ma non come fonte su cui fare un ragionamento a monte a tutto tondo; e abbiamo anche le riviste culturali native digitali, che nascono proprio qua, dove siamo ora.
E poi, da qualche anno, si sono manifestate quelle che chiamerei le opportunità primariamente social di trattare i libri – più che altro perché è venuta a esistere la possibilità prettamente social di parlare di qualunque cosa, dalla malattia della propria nonna alla vendita dello sturalavandini hi-tech in offerta lancio fino al 31 ottobre.
A questo livello si pone il fenomeno del bookinfluencing e le sue varianti, da Youtube a TikTok passando per Instagram. E mentre ci stracciamo le vesti perché questi social network inquinano il discorso pubblico sui libri, sembra di poter dire che il mercato delle recensioni non viva di grande salute – se uno ne scrive una davvero critica, a volte deve scusarsi e rettificare edulcorando. (Su questo ho un’idea bislacca: è forse notorio, infatti, come oggi una delle forme più in voga sia il saggio narrativo in prima persona, che potrebbe oggi o domani rivelarsi come il mix letale per mettere la critica alla porta: c’è il contenuto stringente, sì, ma assediato dall’autore o dall’autrice, dalla sua storia, dal vissuto – insomma, da tutte quelle cose che sembra sempre un po’ più difficile giudicare nel merito. Un libro condito da tanta me stessa non è un po’ più inattaccabile?). Ma andiamo avanti e torniamo, anzi, un attimo indietro.
Vita e omertà delle riviste culturali
La rivista culturale risente fortissimamente della filosofia dei favori, la sponsorizzazione incrociata, il darsi di gomito tra colleghi e colleghe. Prima regola del contesto culturale italiano: non si parla male del contesto culturale. Se proprio vuoi farlo, parlane male in astratto e salvaguarda la tua cerchia di contatti. Molti amici, meno rogne.
Prima regola del contesto culturale italiano: non si parla male del contesto culturale.
In un sistema in cui viene premiato chi ha più amicizie tese a fortificare l’estensione della propria presenza online e offline, è difficile capire quando si può agire non diplomaticamente. L’amica che ti offre di mandarti il suo libro in omaggio ma ti chiede di parlarne in un articolo; l’autore del saggio accademico che recensisci che però è anche interessato a farne qualche presentazione insieme in giro per l’Italia: questo mondo ha la forma di un intreccio continuo tra chi scrive e chi viene scritto, tra chi recensisce e chi viene analizzato, in una rutilante e orgiastica intercambiabilità di ruoli. Oggi sono autrice, domani critica, dopodomani redattrice, e il cerchio della fruizione culturale – gratuita o a basso costo – si avvantaggia di un sistema sociale in cui bisogna mai essere irrelati e giocare contemporaneamente a più tavoli, non far rattristare nessuno, non ostacolare la libera fioritura di percorsi intellettuali che pure non convincono – perché comunque dietro i percorsi ci sono le storie, i vissuti. “Si è inclini alla celebrazione in pubblico e al pettegolezzo in privato”: molti amici, meno critica possibile.
Quello che forse si vuole vedere è che la preferenza accordata al raccontare il libro al posto di analizzarlo non è solo in capo al fenomeno del bookinfluencing: c’è in atto un po’ dappertutto una tendenza all’appiattimento critico per tenersi buoni gli altri visto che, in men che non si dica, si passa in scioltezza da critico ad autore e viceversa.
La patria delle lettere in Italia è un posto in cui ci si rimbalza produzioni intellettuali da una parte all’altra, dove ci si annusa tra pari e ci si certifica a cerchio, in una endogamia asfittica. Spesso, troppo spesso, non ci sono terzi disponibili a venire a certificare lo stato dell’arte e fruirne dall’esterno. Questo cerchio magico del mutuale onanismo a vicenda viene a essere infranto dal fenomeno di massa del bookinfluencing che, in questo senso, si rivolge a una nicchia lasciata scoperta: i lettori da 11 libri l’anno, quelli deboli.
Cosa fanno le bookinfluencer
Di bookinfluencing si comincia a parlare un po’ di più nel gennaio 2020, quando Parente firma per Il Giornale un pezzo al vetriolo: Social, sessiste e “carine”. Ecco le influencer (modaiole) del libro, nel quale raccomanda alle vetriniste d’Italia di riciclarsi bookinfluencer. Di questo approccio da troll maschilista e reazionario fa sorridere soprattutto una cosa: ma Parente almeno lo sa quanto guadagnano le bookinfluencer? E quanto guadagnano le vetriniste? E lui quanto guadagna? È uno dei fortunati a campare del lavoro culturale?
Ça va sans dire, è stato bacchettato da molti e molte come anche in questo pezzo un filo moraleggiante di Wired – in cui si parla di lavoro culturale ma non di denaro e io, che sono una persona semplice, penso subito: “E i soldi?” –, postura che a uno come Parente, che ha il bisogno di sentirsi pericoloso e insieme vittima del politicamente corretto, fa solo un favore. Non voglio indulgere nell’aggressività destrorsa di questo autore, ma rimane lecita una domanda: come si svolge nei fatti il discorso social sui libri?
Insomma: avevano ragione i critici a temere le ripercussioni della rete nel 2012, avevano ragione anche nel 2019 guardando di sottecchi il bookinfluencing e, forse, dovrebbero essere terrorizzati dal #BookTok.
Le attività di bookinfluencing pertengono al libro secondo diversi “gradi di verità”: ci sono l’unboxing (letteralmente l’atto di scartare i libri), la segnalazione, la recensione, la live, la partecipazione alla presentazione. Non di rado le bookinfluencer, velleitarie o professioniste che siano, si prestano a una innocua displayzzazione dei libri: non li criticano, non li analizzano, li mostrano perché solo così non ledono i rapporti con autori, autrici, editori, colleghe. Soprattutto agli esordi, quando ci si deve ancora fare il nome e la reputazione, il meccanismo funziona fintantoché si evita il più possibile di entrare nel merito del libro per poter sperare di riceverne un altro in futuro dall’editore – un paradossale meccanismo per cui l’oggetto della transazione e la transazione stessa collimano; un lavoro culturale cannibale che si ripaga da sé mentre si consuma.
In presenza di volumi più significativi, a pagare è la piattaforma con la possibilità di monetizzare i propri contenuti (poca roba, e poi dipende pure molto dalla piattaforma su cui si insiste), mentre un’altra via ibrida è la sponsorizzazione (#adv) coadiuvata da un’azienda interessata a “circuire” la community dell’Internet persona.
Nel momento in cui parliamo, in ogni caso, è TikTok a presidiare l’immaginario del discorso pubblico online sui libri, con numeri difficili da raccogliere su altre piattaforme. In un’intervista su Linkideeperlatv, Ilenia Zodiaco, una delle più famose e seguite bookinfluencer italiane, alla domanda “Cosa differenzia un booktoker dai book influencer su Instagram e YouTube?”, risponde:
La differenza principale è che il booktoker non fa vere e proprie recensioni, non analizza i libri, anche perché non ne ha il tempo, almeno rispetto a un booktuber. Il booktoker intrattiene la community ma ha soprattutto lo scopo di andare nei “Per Te”. Per riuscirci, sfrutta i trend di TikTok, anche perché è la piattaforma che funziona così, o ti adegui o sei invisibile. La community di TikTok è più verticale sul singolo contenuto che non sul creator: i content scorrono e non c’è l’estetica del feed. Quindi, è il singolo contenuto che deve sfondare, motivo per cui ci si aggrappa a cose sicure, per esempio parlando di saghe che si appoggiano già a grandi fandom.
Insomma: avevano ragione i critici a temere le ripercussioni della rete nel 2012, avevano ragione anche nel 2019 guardando di sottecchi il bookinfluencing e, forse, dovrebbero essere letteralmente terrorizzati dall’odierno fenomeno #BookTok.
Quelli che non hanno nulla da temere
Sapete chi come al solito non ha nulla da temere, invece? Gli editori, il cui punto di vista commerciale può in qualche misura aiutarci a togliere il velo di ipocrisia nei confronti dei modi social di raccontare i libri e avviarci verso la fine.
L’idea generale riguardo a questo fenomeno – direi riguardo a tutti i fenomeni – è “Basta che funzioni”, come si rintraccia nella prima parte dell’intervista di cui sopra ad Alberto Gelsumini, responsabile editoriale di varia e narrativa young adult in Mondadori, che racconta come: “Il fenomeno ha colto abbastanza alla sprovvista le case editrici e si riesce a controllare davvero in minima parte. Gli editori ci hanno messo un po’ a cercare di capire cosa succedesse, ma sicuramente oggi sappiamo che è qualcosa di rilevante e di cui tener conto”.
Può darsi che la persona letterata abbia diritto a essere innocua, ma non sono sicura che esserlo sia un merito.
D’altronde, un’industria per funzionare deve intercettare i fenomeni che funzionano: e quindi perché dovremmo chiedere al direttore editoriale qualcosa di diverso dall’impegno per far funzionare le casse della propria azienda? Certo, potremmo chiedergli di pagare meglio dipendenti e collaboratori esterni, ma quello ci passa spesso di mente.
È che il bookinfluencing per gli editori funziona pure troppo, se così si può dire, e si nota da qualche anno un esito interessante anche sul lato lavorativo. Non è difficile, infatti, che alcune bookinfluencer partano con le proprie pagine e i propri canali rincorrendo il sogno di lavorare nell’editoria, puntando al cuore delle redazioni: accettare per mesi/anni rimborsi e libri a mo’ di pagamento, cos’è se non un investimento su di sé, un auto-stage del Sé preso in ostaggio dalla propria passione?
E in questa avanzata a ranghi serrati di queste persone legate ai social, i vari direttori editoriali e/o commerciali intravedono un felice incontro tra la capacità di questi di maneggiare gli ambienti digitali, la passione per il lavoro intorno ai libri, la golosa chance di impossessarsi di nuovi acquirenti possibili – la community. L’influencer che venga, a qualche misura, assorbita nell’organico di una casa editrice fa un tacito patto col diavolo: da quel momento, infatti, sarà difficile non reclamizzare in qualche modo i libri pubblicati dall’editore che le dà lavoro. La ricerca del lavoro è antiquata: sii tu stesso ad attrarre quel lavoro iniziando a farlo gratis, ingaggiati in quelle stesse mansioni per conto tuo senza essere pagato perché questa è la passione e devi iniziare a lavorare prima che sia troppo tardi, altrimenti chissà quando lo trovi il lavoro. Quando hobby e professione collimano, si generano interessanti fenomeni lavorativi.
Per conto mio, non sono un editore e sono anche piuttosto allergica al mantra “Basta che funzioni”, ma dovendo esprimere una preferenza tra intellò e book-tokers, ossia tra chi feticizza il libro, sa già come fare della propria passione un lavoro e si solletica l’ego nel fare il recensore per la propria ristretta cerchia di amici, e chi democratizza, desacralizza, riporta il discorso pubblico sulla materialità del libro, infonde linfa (se è vitale, lo vedremo poi) nel circuito editoriale, riporta alla lettura le persone tradizionalmente meno interessate e che forse hanno solo bisogno che qualcuno dica loro che non sono deboli, io scelgo di non avere paura del nuovo che avanza.
Il pezzo non era costruito per dare ragione a qualcuno o qualcosa: era teso a dimostrare che le caratteristiche di semplificazione ed estemporaneità che affibbiamo ai fenomeni social si ritrovano anche nei luoghi eletti. Anche se per parlare di libri si usano lunghi testi pieni di parole altisonanti ci si può rendere altrettanto innocui e neutralizzare il discorso critico; parafrasando una frase tagliente di Luca Rastello: “[…] Può darsi che il letterato abbia diritto all’ingenuità, ma non sono sicuro che l’ingenuità sia innocente, né che l’innocenza sia innocua”. Può darsi che la persona letterata abbia diritto a essere innocua, ma non sono sicura che esserlo sia un merito.
Nella società dello spettacolo, queste due categorie si assomigliano più di quanto gli intellettuali non vogliano far credere. Lasciamo aperta una porta per i critici che discussero la questione undici anni fa: chi sono oggi, come lavorano, che risposte cercano le persone che a molti e plurimi livelli parlano oggi di libri?