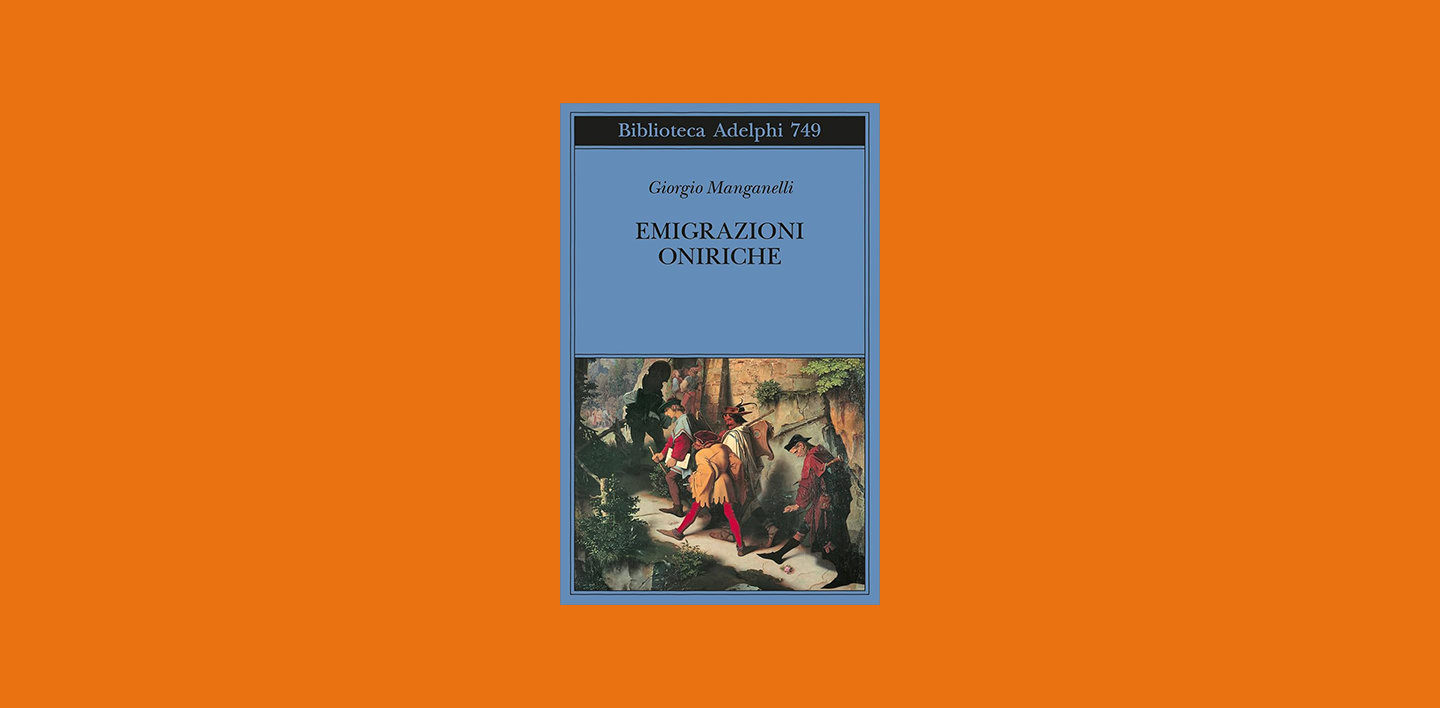
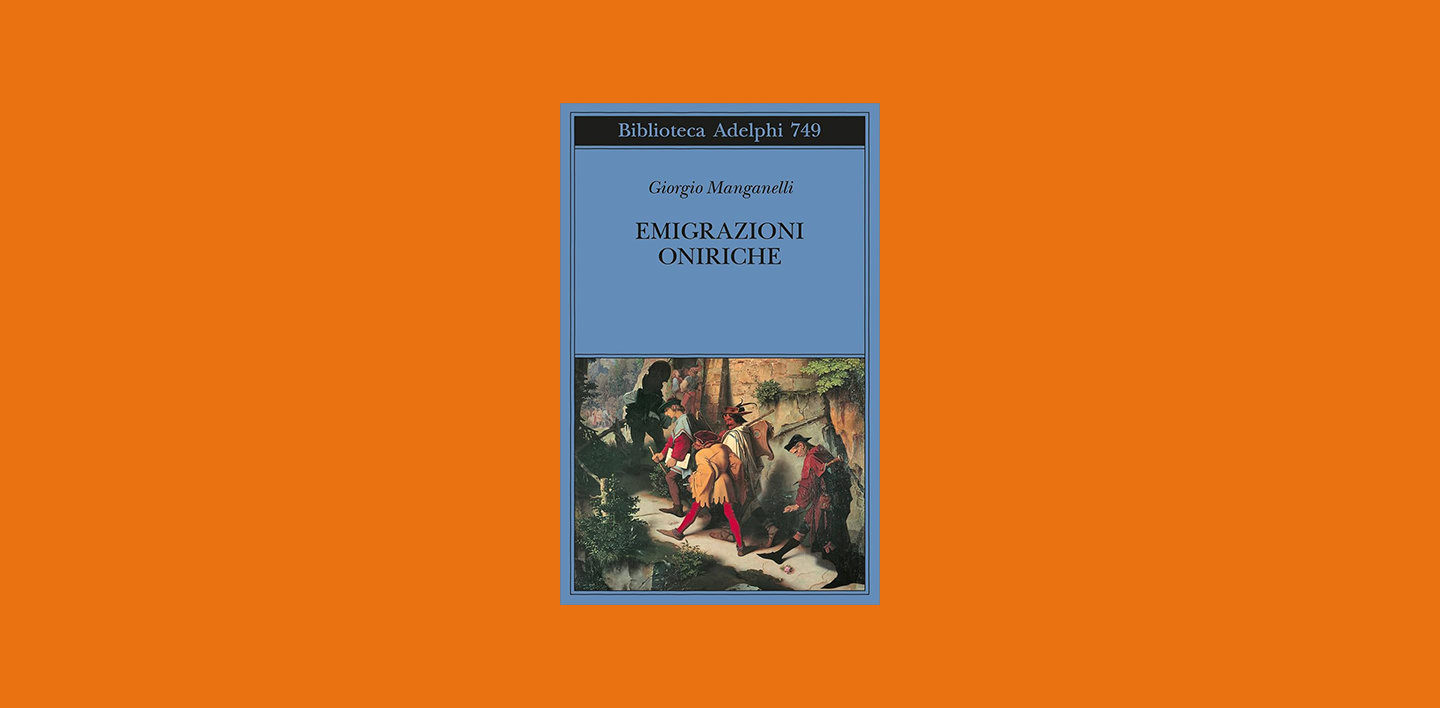
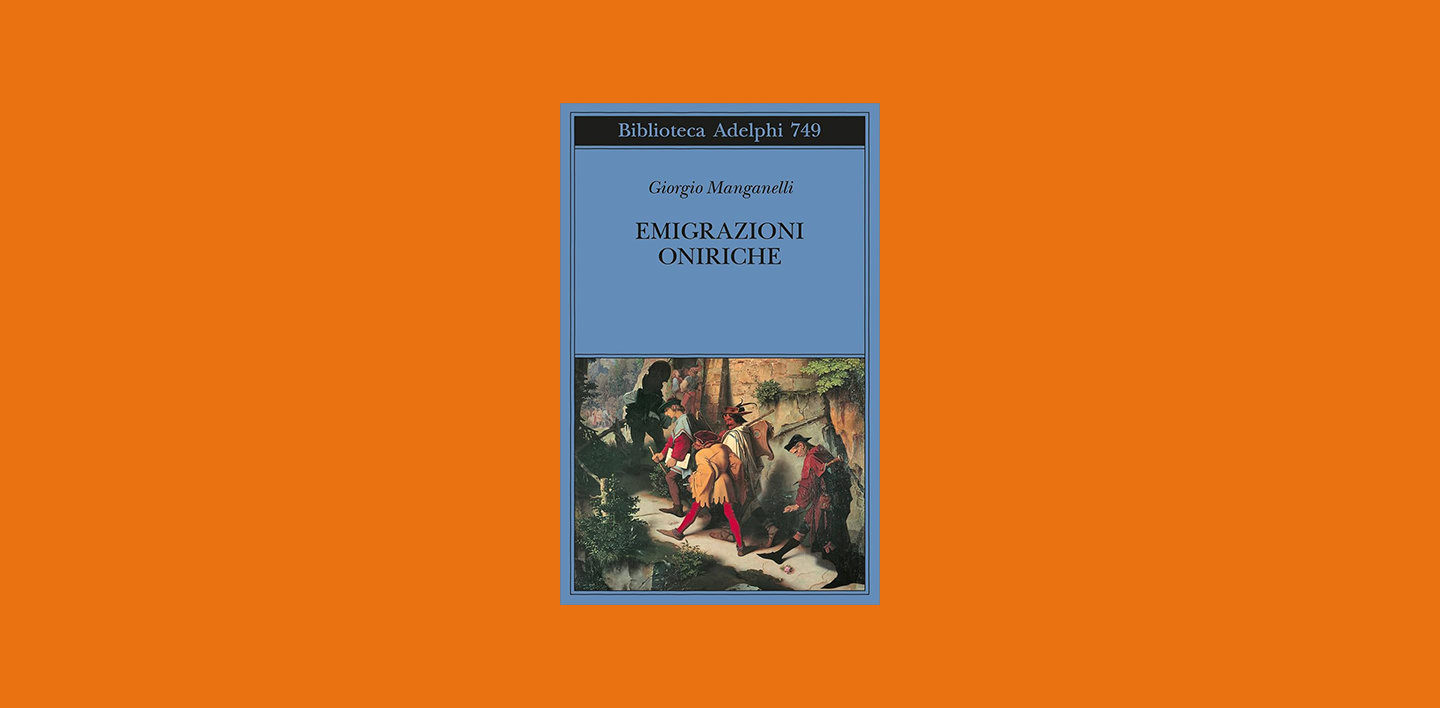
C ommentando una delle tavole attraverso cui Alberto Martini ha illustrato Hop-Frog di Edgar Allan Poe tra il 1906 e il 1907, Giorgio Manganelli estrae dalla figurazione, distillandola in parole, la pulsazione di una “dialettica di luce e tenebre” che “cerca infaticabilmente esiti”:
Se guardiamo senza nozione di orrore la splendida tavola, ci sentiamo irretiti, o forse adescati ad una cerimonia di festa, una danza che solo tradisce in taluni moti centrifughi, in un grazioso disordine la matrice sgomentevole. Ma Hop-Frog è “festa”, evento ilare e feroce, ardore di armoniose torce, ma quello è anche l’ardore del rogo – non le reggono forse due allusioni infernali – o non saranno maschere in qualche modo giulive? In primo piano ci assaltano immagini di decorativo orrore, figure che sanno simultaneamente di essere ad una festa, e che quella è festa di vendetta, di lampade e fuochi. Vi è nella maschera una compresenza di ridevole e sinistro, e dunque è congruo che a celebrare la vendetta di Hop-Frog si dia una mascherata.
[…] Al centro della Vendetta finale di Hop-Frog sta il viluppo dei corpi che bruciano; una grande, mirabile fiamma li avvolge come un manto nobilmente araldico; è fiamma corporea, sì che pare trattenere un corpo che cade, e sono, quegli arsi, il centro della festa, il luogo sommamente luminoso e sommamente letale. Ardono le vittime tra una delizia di luci artificiate, scherzi e giochi, spaventi e fughe.
La scrittura manganelliana – sprezzatura stilistica tra il soave e il barocchesco – rende possibile a distanza di poche righe osservare da un lato le profondità abissali, la quasi innominabile oscurità, l’inferno oltre lo specchio della finzione letteraria e figurativa; e dall’altro le altezze di una leggerezza festiva, le testimonianze di una luminosa, paradossale, indecifrabile consistenza e coesistenza di pienezza e vacuità. Nella scrittura di Manganelli è svelato il culmine danzante di quella dialettica tra luce e tenebre, e noi, di fronte al testo, di quella strana danza siamo spettatori.
Dell’artefatto letterario Manganelli è stato architetto e costruttore d’eccezione, e parrebbe, leggendolo, ch’egli abbia sempre sotto controllo una retorica perennemente in bilico. Eppure, allorché la parola manganelliana, mestierata e scaltra, si trova di fronte all’immagine, vi riconosce una forza espressiva assai più antica della propria, vi riconosce una genealogia fantasmatica, che dal magmatico oceano mentale si deposita e inabita il mondo, le rocce cavernose, le stele funerarie, le tele incorniciate, carta su carta, vetro, rame, celluloide: l’immagine sosta sulle innumere superfici, negl’incavi e nei concavi del visibile, l’immagine coesiste al mondo.
Di un tale riconoscimento siamo testimoni appena ci inoltriamo nelle Emigrazioni oniriche di Manganelli (Adelphi, 2023), raccolta dei suoi scritti dedicati alle arti visive a cura di Andrea Cortellessa, tra i quali compare il saggio su Martini sopra citato (intitolato Costanza del nero).
Notiamo, fin dall’inizio, che l’ammissione della potenza dell’immagine emerge anzitutto, nei brevi pezzi qui riuniti, laddove Manganelli non resiste alla tentazione di confrontare l’arte visiva con la letteratura. È il caso, tra i molti, delle “narrazioni sincroniche” e del “romanzo delle immagini” di Ghiberti; della “letizia apparente e tangibile di Donatello”, che sta nel “consegnarsi a sé stesso, a quella regione occulta e felice di sé in cui dalla pagina bianca del marmo nascono le ombre luminose, abbaglianti” (qui in Rissa con la luce). Potremmo parlare di vizio retorico, forse anche di automatismo stilistico. Eppure vi si celano le stigmate di una profonda presa di coscienza.
L’immagine è aggressiva. E Manganelli, pure avendo una profonda familiarità con l’aggressività letteraria, sembra sempre avere un certo qual timore dell’immagine.
L’immagine è aggressiva. E Manganelli, pure avendo una profonda familiarità con l’aggressività letteraria, sembra sempre avere un certo qual timore dell’immagine, forse anche d’invidia, simile a quella ch’egli ha dichiarato di provare per la musica, parlando di una “specifica invidia dello scrittore verso il musicista che è l’invidia di una condizione particolare che a lui sembra infinitamente più libera e più inventiva, più naturalmente fantastica”, invidia del privilegio “di non dovere affrontare l’onta del significato” (Una profonda invidia per la musica, 2014).
Manganelli sa benissimo che non può, allo stesso modo in cui disferebbe un testo, disfare o frantumare l’immagine, l’oggetto d’arte. Sa che non può maneggiare scaglie di marmo, briciole di gesso o pezzetti di fotografie strappate, così com’è abituato a far giocoleria virtuosistica con la grammatica, coi concetti astratti e le parole-menzogna della letteratura, spesso meretrici e remissive. L’immagine impone la propria forma, e il fool Manganelli, insieme timoroso e riverente, non può che tentare di girarle intorno e trattare con lei, o d’insidiarla, nello spazio e nel tempo, lo sguardo obliquo.
Anche i luoghi d’abitazione per eccellenza dell’immagine, i musei, di cui Manganelli diffida – ci dice qui in Lager di squisitezze – impongono la propria grandezza assai più violentemente rispetto alle biblioteche. Il museo impone la propria natura narcisistica attraverso l’insistente affermazione della propria unicità, “esige di essere solitario, esemplare, irripetibile”. Il museo proclama apertamente la propria condotta tirannica e paternalistica, è “fatto di oggetti unici” e ognuno di questi appare a Manganelli come “una preda, comprata, trovata, catturata, deportata, scovata, scavata, rubata, corrotta, scambiata, trafugata”. Invece la biblioteca “è pedante ma onesta” e “non pretende di essere unica”.
Gli Uffizi sono un “delicato leviatano che racchiude nel suo ventre la pittura italiana, con qualche squisitezza esotica”, e ancora, “rete enigmatica che adesca e sgomenta”, “lager di squisitezze” che cattura le sue opere imponendo loro di rinunciare alla propria “qualità magica”, alla “intrinseca violenza”, in cambio dell’eternità. Eppure, osserva Manganelli, l’immagine contravviene persino alle norme imposte dalla macchinazione dittatoriale del museo. Il “vero popolo” del museo non è il pubblico umano, ma le opere che vi sono rinchiuse, le quali, “durante le lunghe ore di solitudine reciprocamente si contemplano, si imparano”, e quando noi torniamo in visita le ritroviamo arricchite l’una dell’altra. Il loro “prodigio intrinseco”, ci rivela Manganelli, è “qualcosa che agisce numinosamente, che è insieme gioco e impossibile”. È una certa “affinità patente” tra di loro, una “oscura affinità” tra quei soggetti apparentemente estranei, un’affinità che spesso riconosciamo nel colore; quel colore che d’altra parte, in Salons (1987) nel corsivo dedicato a Edouard Benedictus e intitolato Tutti i colori del fool, Manganelli afferma essere non solo la sostanza, ma la personalità di una piuma, di una rosa o di una farfalla.
I quadri, le immagini, come le cose del mondo, sono governati da una “interiore legge dell’analogia”, vi scorre “sangue analogico”, numinosità parentale (qui in Il mondo frantumato). E l’analogia non è forse il gesto centrale di quella “cerimonia con l’ombra” che si colloca al centro della riflessione manganelliana sulla letteratura (cap. dieci del Discorso dell’ombra e dello stemma, 1982)? Una cerimonia con l’ombra che a sua volta è apparentata con quella “magia nera”, “cauta ma innegabile”, che – ancora sfogliando Salons, in L’animaliera magata – Cosimo III de Medici dovette avvertire quando commissionò la propria animaliera dipinta, in cui ogni animale, demone antropomorfo, “si lega in misteriosa conversazione con altri, e celebra gesti di oculata segretezza”. E Manganelli avrà certamente trafitto con la mente quel passo di Maurice Blanchot, nell’appendice de Lo spazio letterario – che sappiamo ha letto, riletto e sottolineato – dov’è scritto che “magia nera” dovrà essere il nome autentico da attribuire a quella precisa modalità in cui l’immagine “fa della nostra intimità una potenza esteriore che noi subiamo passivamente”, conducendo “le cose a svegliarsi come riflesso e la coscienza a condensarsi in cosa”.
Manganelli sa benissimo che non può, allo stesso modo in cui disferebbe un testo, disfare o frantumare l’immagine.
Quella specie di timore nei confronti dell’immagine, della fisicità ingombrante di ciò che non è parola, non inibisce però la natura del fool, non impedisce a Manganelli di osar giocare al suo gioco prediletto, tutto letterario. Così, leggendo un corsivo che prende le mosse da una visita al Museo delle Statue Stele Lunigianesi (qui Stirpe di pietra), siamo spettatori di una gratuita, squisitamente inutile, fantasticheria immaginifica sulla storia del mondo e della vita, che Manganelli ci racconta come una genealogia della pietra. Tutto si fa vivo nelle parole di Manganelli, animazione d’inanimato, fin dall’incipit: “Per milioni di anni, per tempi non misurabili, il mondo fu di pietra. La terra fu un sasso coperto da una epidermide d’erba, acque, carni”. L’uomo sempre si è posto il problema di “interrogare e capire la pietra che ci sta attorno e che ci sta dentro”, la sua divinità e la sua mediocrità, le mille forme e i mille modi in cui l’accompagna: così l’argilla è forse “una pietra che tenta di non spaurire l’uomo”, mentre le figure che ci sono tramandate sulla pietra sembrano un “tentativo della pietra di produrre qualcosa che potesse essere frainteso per uomo”.
Eppure, è anche inevitabile che il gioco ipotetico del fool-Manganelli venga interrotto, ch’egli sia costretto a frenare piroette e giravolte, per riconoscere ad un tratto, in una testa di statua stele, “una oscura volontà d’occhi”, una “violenza affettiva sconvolgente”, la “sagoma pietrigna di un urlo in questa volontà di volto”, un “non volto” che è nessuno e tuttavia ci è “orrendamente familiare”. Così, dopo aver planato con Manganelli nella sublime inutilità panoramica di cui è sapiente conoscitore, ci pietrifichiamo innanzi alla pietra muta, imparando a riconoscervi la sostanza fantasmatica del numinoso, che pervade gli oggetti d’arte e d’artificio, a riconoscervi i segni di una magia nera indefinibile che però ci tocca intimamente, il gesto analogico della cerimonia con l’ombra che apparenta infine, vicino-lontano, immagine e parola.
Così come il mito, l’arte ci parla indirettamente di noi stessi, del nostro mondo, della nostra mente, specchio di specchi. Come ha sottolineato Roberto Calasso, fu Nietzsche a rovesciare gli equilibri, attribuendo all’arte una “suprema qualità gnoseologica”: da quel momento, “conoscenza e simulazione non erano più antagoniste, ma complici”, poiché l’istinto fondamentale dell’uomo, ovvero l’istinto a formare metafore, non potendo acquietarsi nel “grande colombario dei concetti”, scorre illimitatamente nel mito e nell’arte (R. Calasso, La letteratura e gli dèi, 2001).
L’immagine impone la propria forma, e il fool Manganelli, insieme timoroso e riverente, non può che tentare di girarle intorno e trattare con lei, o d’insidiarla, nello spazio e nel tempo, lo sguardo obliquo.
L’istinto metaforico, d’intima parentela con il “sangue analogico” che Manganelli sente scorrere nelle vene della pietra, nelle trame delle tele, ci appare allora come il fondamento di quella capacità dell’arte di esserci così intimamente vicina: queste immagini, riconosce Manganelli, “appartengono al nostro mondo”, come le immagini dei miti; esse “non popolano le nostre strade quotidiane, ma sì i nostri itinerari notturni” (ancora in Stirpe di pietra). E non si pensi solo al sogno, poiché la notte, per Manganelli, è una “terra cimmeria”, una “sostanza notte”, coeterna al mondo: insieme uno spazio di accadimenti e una sostanza che agisce (La notte, 1996). In questi itinerari notturni, ad esempio, s’incontrano le patate di Van Gogh, che si rivelano a Manganelli “tuberi ctonii, frutti che si nutrono di lunghe tenebre, cibi apparecchiati, allevati nel luogo della sepoltura”, che sono “notte, profondità, cimitero, tomba, nero, nerità; e hanno la forma sgraziata e concentrica del mondo”, poiché Van Gogh, “essere umano, eterno ed effimero, fermava sulla tela i modelli degli oggetti terreni, in attesa che la notte totalmente, stupendamente li trasformasse” (qui in Sacramento negativo). Questa notte, spazio-sostanza, in fondo – come tutti gli spazi manganelliani dati al lettore da esplorare – è uno spazio mentale. Perciò quei “nostri itinerari notturni”, che ospitano le infinite immagini dell’arte e del mito, sono i labirintici cunicoli della nostra mente.
Diciamo pure che protagonista della scrittura manganelliana è lo spazio mentale, allo stesso modo in cui protagonista del teatro è il palcoscenico, su cui forme e sostanze recitano le parti di personaggi, comparse, fondali, tutti protagonisti e allo stesso tempo tutti non-protagonisti: tutto instabile, tremolio di gioiosa inventiva e rappresentazione. Così gli Egizi, “inventori d’immortalità”, vivono in uno di quei “luoghi mentali prima che geografici, che sembrano consacrati ad immagini definitive, totali, dalle quali l’uomo non potrà mai spogliarsi” (qui in Volti di mummia). Così la “poesia visiva” dell’arte orientale (araba, turca, persiana) partecipa di uno spazio mentale che ci compete e compenetra violentemente (qui in Un tappeto di nulla):
L’oriente non è, come suppongono i geografi e fantasticavano i navigatori, un punto cardinale, un luogo univoco, un “là” da indicare coll’indice. La bussola non ne sa nulla, le carte raccontano delle fole. L’oriente sta alla nostra destra, alla nostra sinistra, davanti a noi, e alle nostre spalle; sta sotto i nostri piedi, nella terra senza luce e senza respiro, sta sopra il nostro capo, in tutte le forme dell’aria.
Osservando le opere del pittore giapponese Hokusai ci ritroviamo in una condizione di “emigrazione onirica” che ci fa “sospettare in noi stessi un mondo segreto che non si lasciava interpretare o depositare nelle nostre ‘figure’” occidentali (qui in L’interminabile). In occidente, le strade romane sono “avvenimenti della ragione”, reti mentali che alla mente ritornano, portandosi dietro una ricca pescagione di città, pellegrinaggi e cattedrali di cui, ancora, Manganelli ci propone una panoramica aerea vertiginosa (qui in La cattedrale parla). In un corsivo sul Caravaggio, Manganelli ci indica un’apertura nello specchio, certamente usato dal pittore come da altri per studiare gli oggetti: tuttavia Caravaggio, “tragico, di altissima brutalità, pensò tutto nello specchio, e lo specchio, luogo della mente, gli insegnò ad eludere, a mortificare, a insultare la pietas con il virtuosismo” (qui in Gaglioffo di pelo buio).
Scopriamo poi che Fausto Melotti, amico di Manganelli, “catturatore di immagini” e “manipolatore di ombre”, con la sua arte polimaterica devota alle geometrie, affascinata dalle linee, “appoggiandosi a questi spazi, questi segni puri, […] evocava una mitologia miniaturizzata, quasi un olimpo divenuto per grazioso incantamento infantile”. E Carol Rama, con la sua pittura notturna tentata dalla luce, che tanto affascina Manganelli, è una “governante sicura e stridula di uno spazio che secerne segni penosi, tetri, torvi, tuttavia intensi, alacri, petulchi” (qui, Uno sguardo dal sottosuolo). E i quadri di Gastone Novelli “non di rado si atteggiano come pagine mentali, o forse muri calcinati, muri adoperati, distese su cui poggiare i segni” e formare un alfabeto in cui tutti i significati sono “irreparabilmente scomposti nelle sillabe, nei segni irriducibili”, segni che poi tornano ad unirsi, “come all’inizio – non un inizio storico, ma mentale” (qui in Obbedienza alla legge dei segni).
Un critico definì Novelli “un progettatore di gioia”; certamente è difficile immaginare un pittore più felicemente intento a inventare frammenti di mondo, un mondo che non sarebbe esistito senza la gioia, l’ilarità della scoperta dell’immagine. Il dipingere di Novelli aveva sempre il ritmo di una scoperta; come se la figura fosse sempre stata lì; bastava illuminare la pagina mentale, scoprire il muro per trovare allineati tutti gli sgorbi virtuosistici che disegnavano un mondo.
Così, ancora una volta e come sempre, Manganelli non solo ci ammutolisce con la sua prosa mirabile, incomparabile e forse incompatibile con altro da sé, ma soprattutto ci porta per mano – insieme fool e guida fidata delle profondità e delle altezze – in emigrazioni oniriche che si rivelano soprattutto emigrazioni fantasmatiche, immaginifiche, emigrazioni mentali.