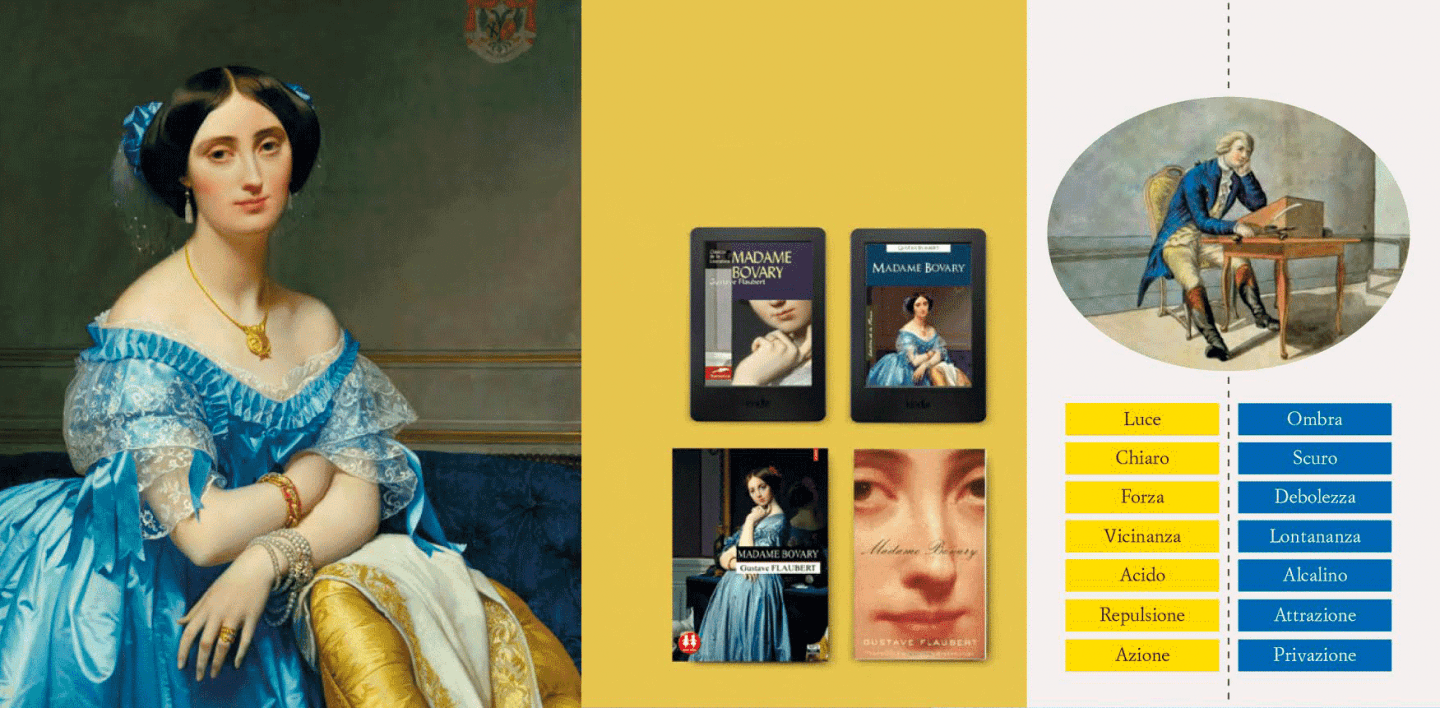
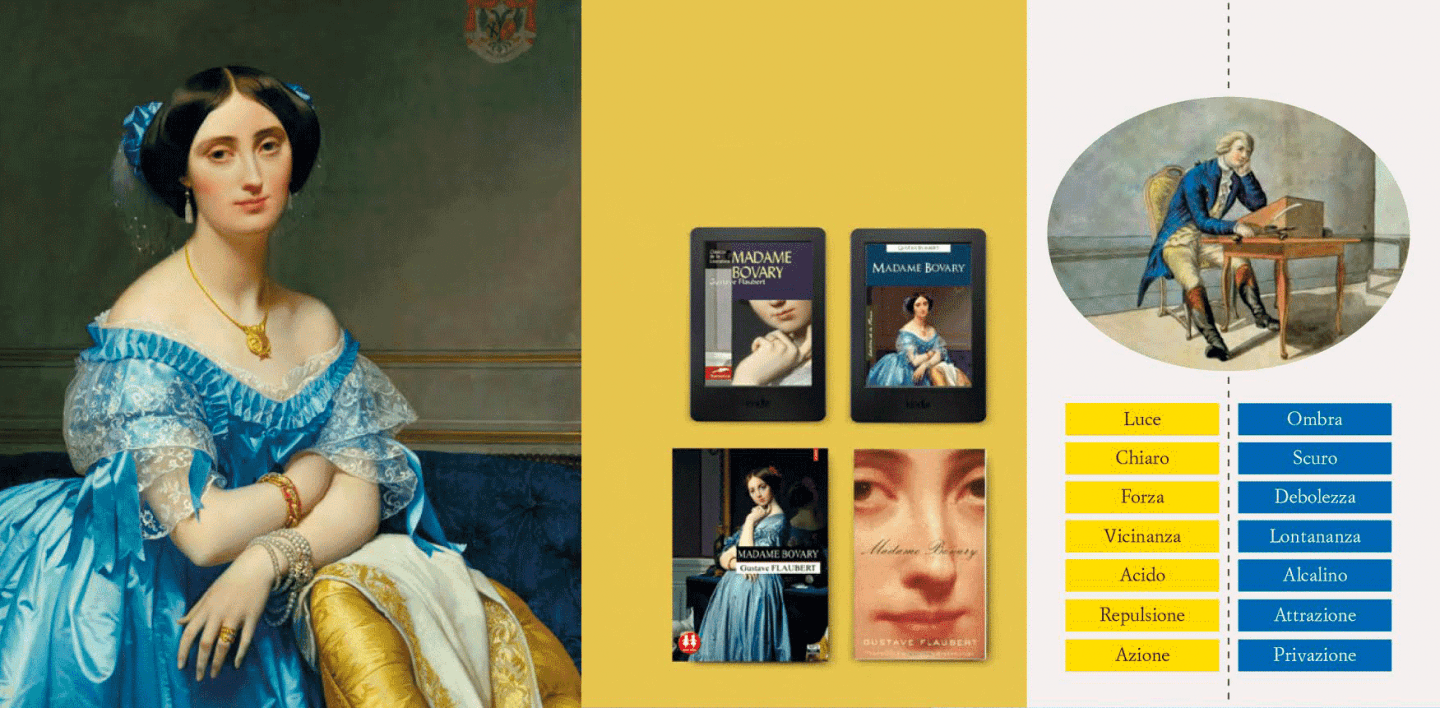
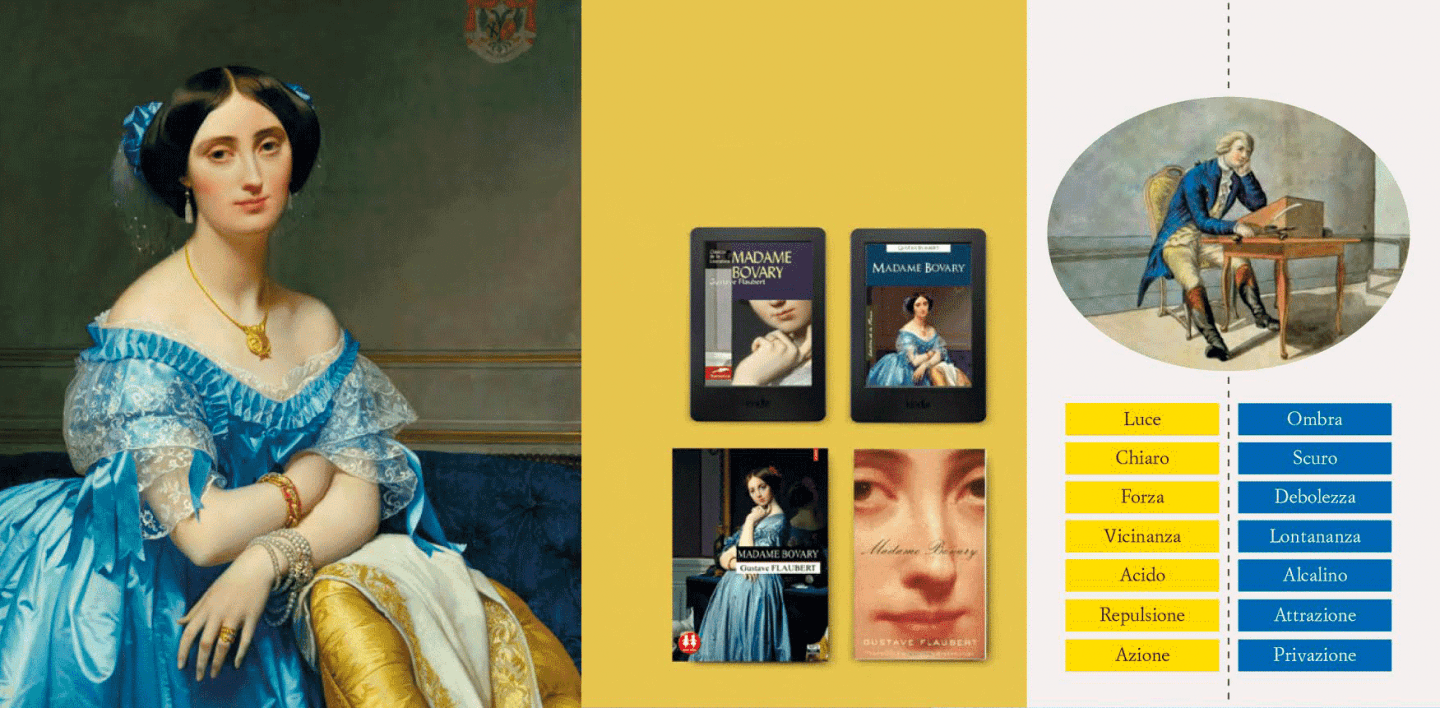
Riccardo Falcinelli è un art director formato a Londra e cresciuto professionalmente a Roma, dove ha realizzato, fra i tanti altri, i progetti grafici di minimum fax, Einaudi Stile Libero, Pagina 99. Con Marta Poggi ha scritto i graphic novel Cardaferrania e Grafogrifo. Il suo Critica portatile al visual design è diventato in tre anni un longseller, un libro di riferimento per chi vuole imparare a conoscere i principi di una disciplina i cui frutti sono onnipervasivi nella vita della società industriale. Su questa linea si pone anche Cromorama, allargando lo sguardo sulla storia della scoperta umana del colore e dei suoi effetti: dalle scienze cognitive a Hitchcock, da Goethe ai Lego, dall’outfit giallo-blu di Werther a Gipi, Falcinelli ci fa riscoprire quel che ogni giorno ci troviamo davanti agli occhi e nella mente.
Riccardo Falcinelli: Marta Poggi quando l’ha letto mi ha detto che sembra di leggere Artusi, un libro di cucina da fine Ottocento…
FP: Esattamente. Con questo libro ho avuto la sensazione che tu sia uno dei migliori scrittori italiani, o comunque che tu lavori come uno stilista della scrittura.
RF: Si continua a pensare che la saggistica non abbia una forma e per me non è così. Poi, è evidente che non è una scrittura da romanziere, prima dei trent’anni non ho mai pensato di scrivere…
FP: Mi pare che per te la scrittura sia un’ulteriore incarnazione del design. Faccio un esempio che mi riguarda: secondo me la scrittura del giornalismo culturale pone delle questioni di uso pratico, come se fosse un pezzo di design. Il mio criterio, in un saggio o articolo, è che i primi due paragrafi siano la maniglia per entrare, per afferrare l’oggetto. Allo stesso modo mi sembra che, nel rapporto tra funzionalità ed eleganza che caratterizza il modo in cui lavori con le case editrici, con i giornali e con gli oggetti-libro che ti capita di realizzare a tuo nome, la questione dello scrivere sia diventata parte della tua idea generale di design. E siccome il tuo punto di partenza è il design industriale, stai cercando di raccontare le tradizioni che ti stanno a cuore in un procedimento che è quasi industriale: i capitoli del libro sono oggetti realizzati per trasportarci nella storia del pensiero e della scienza. È un libro molto ambizioso.
RF: Amo leggere saggistica, ne leggo tanta, perché imparare cose mi rassicura, mi permette di dare senso a ciò che è intorno. Ora, il 95% della saggistica con cui abbiamo a che fare ha una certa forma perché chi la scrive pensa che ti debba soltanto dire delle cose. In realtà io faccio un altro mestiere, il mio mestiere è dare forma alle cose che fanno gli altri: tutto ha una forma. I modelli certo sono i libri di Roland Barthes – perché si deve sempre partire da grandi modelli, non esiste alternativa – o di Gombrich. Se Gombrich è diventato lo storico dell’arte più famoso del mondo non è per quello che diceva, ma per come lo diceva, in una maniera talmente cristallina che anche un ragazzo di terza media può seguirlo. Qual è il punto quindi? Io mi occupo di tutto ciò che prende forma nella società di massa. Che sia la scarpa, che sia la pubblicità, il libro. Quello di cui mi occupo non ha bisogno di divulgazione; la fisica, per dire, ne ha bisogno, perché sono concetti densi e devi rendere digeribile i concetti per il pubblico.
FP: Rovelli per esempio crea un’atmosfera.
RF: Vero, ma i libri di Rovelli secondo me hanno un elemento intrinseco di debolezza: una frattura tra il concetto denso che mi vuoi passare e le eccessive diluizioni che si mettono di mezzo. Io invece parlo dei Simpson, del packaging del latte e della cioccolata, e del perché il viola va di moda: non c’è bisogno di divulgarla questa roba, perché è roba che noi abbiamo sotto gli occhi. Io cerco di scrivere in maniera piana qualcosa che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni rendendola più… complessa. Cerco di utilizzare uno stile avvincente che è strumentale a portarti dalla mia parte e dirti: “Guarda, quello che hai nel frigorifero, la grafica del latte è più complessa di quanto credi”. Secondo me è impossibile fare divulgazione del design, a meno di non essere in cattiva fede. Del design tu puoi solo rendere accessibile la complessità che le persone non vedono: che i bambini si vestano di celeste e le bambine di rosa, che i Simpson si vedano in televisione, è la banalità del quotidiano per come lo viviamo oggi. Il punto è: perché le cose stanno in quel modo?
FP: Come hai deciso che tutto questo poteva essere spiegato, al meglio, dai colori?
RF: Il fatto che abbia scritto un libro così imponente sul colore è un caso. Io insegno psicologia della percezione all’università, mi sono trovato a fare diversi corsi sul colore ed erano la cosa a cui gli studenti rispondevano di più, quindi alla fine mi sono trovato con una mole di appunti, di note, dopo anni era una pila enorme di aneddotica. Ho pensato che potesse essere un escamotage per parlare a un pubblico non specialista: i colori sono un pretesto.
FP: Il colore qui è un modo per capire come è cambiata l’economia, dal lapislazzulo sbriciolato al Pantone…
RF: Le pratiche economiche e sociali vanno di pari passo, anche se quelle sociali sono imprevedibili. A differenza di tanti miei colleghi io non penso che il capitalismo sia il Male. Anzi, qui provo a raccontarti come la società economica in cui viviamo presenta tutta una serie di aspetti biechi, che però per eterogenesi dei fini produce anche cose fantastiche, cose che non ti aspetti. Volevo scrivere un libro non moralista. L’esempio più eclatante, l’influenza dell’industria dei cosmetici nell’emancipazione femminile: è chiaro che l’Oréal, Revlon eccetera non hanno prodotto cosmetici per liberare le donne, ma in maniera indiretta questa cosa l’hanno consentita.
Bauhaus, Kandisky, Mondrian li adoro, ma in questo libro li prendo affettuosamente in giro, vivevano in un mondo in cui credevano esistesse un Male oppugnabile da un Bene. Oggi è tutto troppo scivoloso per poterlo fare. Penso che la maggior parte delle pratiche delle multinazionali siano nefaste, però permettono delle cose che in altri periodi storici non erano possibili. Mi sono reso conto dopo anni che insegnavo che tu puoi anche parlare della cosa più affascinante, che ti appassiona di più, ma gli studenti ti seguono – gli studenti sono il lettore ideale perché sono a metà tra l’interessato e l’indifferente – quando capiscono che qualcosa vuole inserirsi nella loro vita. L’aneddoto è il grimaldello per portare il lettore dalla mia parte.
FP: Qual è quindi la tua parte?
RF: Il fatto è che le persone credono che i romanzi parlano di cose profondamente sentite, e che la saggistica sia una cosa gelida: l’aneddoto ti fa capire quanto questa cosa mi appassiona.
FP: Quando leggevo del vestito blu e giallo del giovane Werther mi è venuto in mente il giubbotto del protagonista di Drive. Mi è venuto in mente che la gente in passato ha rimorchiato vestendosi come Werther.
RF: Meraviglioso. E Werther non esiste, è inventato.
RF: Il grande rimosso della cultura italiana è che la cultura e i soldi siano due cose che non hanno a che fare l’una con l’altra. Questo libro parla di design, ma il sottofondo di dolore esistenziale, sessualità e soldi è presente.
FP: E in questo è romanzesco. Un’altra illuminazione: musei e centri commerciali sono nati nello stesso momento, come luoghi dove la gente va a passare il tempo.
RF: Quello è il cuore di tutto il libro. A me è sempre pesata la dicotomia tra il discobolo di Mirone come arte Vera, alta e rarefatta, e lo shopping come cosa bassa, utilitaristica. Le due cose sono talmente affini dall’Ottocento in poi… È qualcosa di vertiginoso, e se te ne rendi conto rendi più complesso il discobolo di Mirone e più artistica la scarpa da ginnastica. Bisogna rivelare queste cose, metterle sotto al naso delle persone, in un certo senso è una forma di onestà: smettiamola di andare al museo cercando lì i valori spirituali, e poi il 90% della vita la passiamo alla Coop a comprare i surgelati. Rende la nostra vita misera: possibile che odiamo il commercio, il capitalismo, e poi “Ah, questi venti minuti di estasi al museo…”.
FP: L’altro giorno alla radio il direttore di un museo diceva di avere rinunciato tempo fa al museo come specchio della vita: non è che siccome il mondo è sempre più brutto il museo deve per forza diventare la piazza idealizzata.
RF: Certo. Chiarisco una cosa: non credo che i bastoncini Findus e la Gioconda siano sullo stesso piano. È giusto dividere i piani, però soltanto dopo avere capito le cose che ci siamo detti prima. Altrimenti diventa una specie di mistica a priori che non permette nemmeno di cambiare i valori del mondo in cui viviamo. Il libro ha anche una vocazione politica.
FP: Come raccogli il materiale?
RF: Ho dei quaderni, quintali, li riempio di appunti. Le cose che raccolgo di più sono l’aneddotica, familiare soprattutto, e le idee che la gente si fa sulle cose. I miti che le persone creano intorno ai Fatti. Uno dei temi del libro: tutti ci insegnano che giallo più blu fa verde, e non è vero, è una tipica invenzione dell’industrializzazione. Dipende dalle sostanze. Però viviamo in un contesto culturale in cui è vero perché fin dall’asilo ci danno dei colori che reagiscono in quel modo. Queste sono le cose che mi affascinano di più: il fatto di dare al lettore qualcosa di banale, e poi ribaltarlo tutto. È un gioco di prestigio.
FP: La valigia nera sembra più pesante; la matita gialla vende di più della verde perché la verde sembra più fragile…
RF: Qual è il punto? Quando vengono rivelate queste cose la reazione del pubblico e dei giornalisti e degli scrittori è “ci stanno ingannando”. La questione invece è: che meraviglia, come funziona il cervello umano… Noi abbiamo bisogno che le cose abbiano un senso, che una cosa sia più importante di un’altra, desiderare una matita gialla è rassicurante. Qual è la reazione del mondo di oggi – penso ai social? La paranoia, la teoria del complotto. Questo libro – che non parla di relativismo culturale, di post-verità – vuole dirti che le cose vere esistono, ma non necessariamente ci devono interessare. È smaliziato, come libro, da questo punto di vista.
FP: È un libro sulla costruzione del consenso e sulle sfumature psichedeliche che questa costruzione riflette a livello percettivo.
RF: Non è la finalità del libro, ma in effetti è un tema che torna spesso. Nel libro cerco di dire che forse la giustizia e la felicità sono meglio della verità, però a patto che tu sappia come stanno le cose. Io ti spiego come stanno le cose, te ne puoi pure dimenticare, fare altrimenti… Il capitolo in cui parlo de La donna visse due volte è emblematico: lì c’è una donna che si innamora di un uomo recitando una parte, e quando all’uomo si rivela la vera donna lui non la ama, preferiva quella di prima, finta. Questo è il nostro rapporto con il design, la pubblicità e l’arte: ci innamoriamo di una cosa costruita ad arte. Il protagonista del film la deve sapere la verità? E il consumatore? Secondo me deve avere la possibilità di scegliere, e in caso fare un passo indietro.
FP: Una delle parole più ricorrenti negli ultimi due anni è stata “distopia”, un po’ per i discorsi intorno al cambiamento climatico, un po’ per le ovvie questioni politiche, ci stiamo proiettando in un futuro che abbiamo sempre percepito come fantascientifico e distopico. Di solito la fantascienza distopica è scolorata… Riassumendo: il libro ti dice “ecco il design industriale, che ha portato colore nelle nostre vite”, prima era tutto grigio, il sabbia che oggi è lusso un tempo era il banale. Tu, a valle di un libro del genere, come ti immagini il futuro, parlando di colori?
RF: Domanda difficilissima. Sono troppo concreto per riuscire a immaginarmi il futuro. Amo più il passato, il libro lo dimostra… Però a un certo punto ho imparato una cosa. Prendi il film di fantascienza per eccellenza, 2001 Odissea nello spazio. Tre-quattro anni dopo questo film, film per me cupo e angosciante, non il mio preferito di Kubrick (il pessimismo io lo trovo facile), insomma dopo tre-quattro anni Kubrick fa Barry Lindon. Bene, dal mio punto di vista il vero film di fantascienza è Barry Lindon. Perché Kubrick dopo 2001 ha fatto Barry Lindon? Risposta semplice: a Kubrick piaceva cambiare genere. Io non ci credo in questa cosa, secondo me ha fatto sempre lo stesso film, come ogni grande artista. Gli interessava il Settecento, invece, perché è molto codificato. Insomma, se sbagli a fare una cosa nel Settecento sei morto: e questo è il grande rimosso del contemporaneo, credere che siamo spontanei, liberi nelle nostre scelte. Anche oggi se sbagli una mossa ti uccidono… Però è indiretto e fingiamo di non darci peso.
La società funziona così, con le aspettative delle persone, le regole, il denaro… In questo senso Barry Lindon è fantascienza: dice “attenti a voi, il mondo sarà sempre così”. La pratica sociale determinerà i rapporti tra gli uomini. Allora non saremo mai liberi? Ovvio, ma non è un problema da porsi: Homo Sapiens ha a che fare con gli altri. Tutto il nostro ambito di intervento c’entra con questo: siamo liberi all’interno di quello che ci è permesso. Inviterei alla disillusione… Siamo ancora figli dei movimenti di liberazione degli anni ’60, e una retorica strettamente capitalistica del tipo, quanto bello è essere liberi, finalmente: finalmente dopo cosa? È falso.
FP: È tutto significato costruito.
RF: Esatto. Però non è un libro pessimista; è un invito alla concretezza. Noi viviamo tempi in cui il pessimismo ci sta facendo a pezzi, e certo non è la migliore delle epoche possibili: la società in cui viviamo però mi ha permesso di fare una serie di cose che mi interessano, mi appassionano e credo siano importanti: non ultima, scrivere un libro come questo.