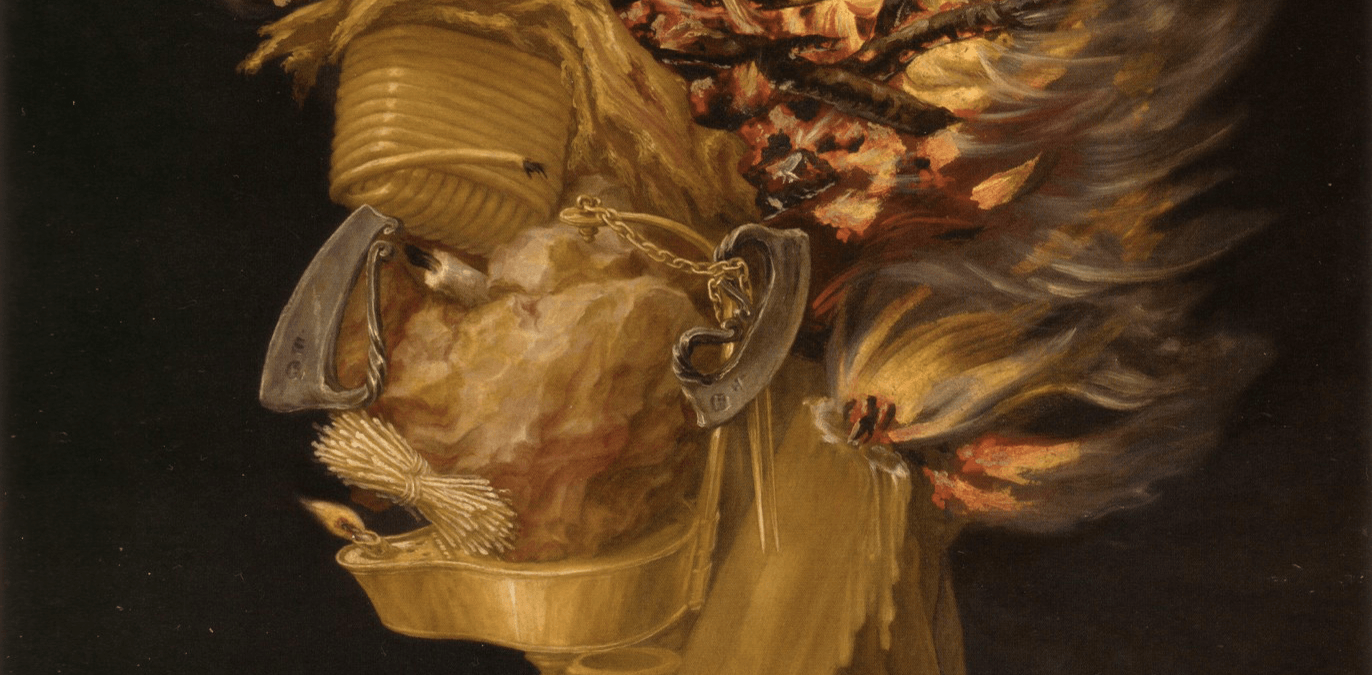
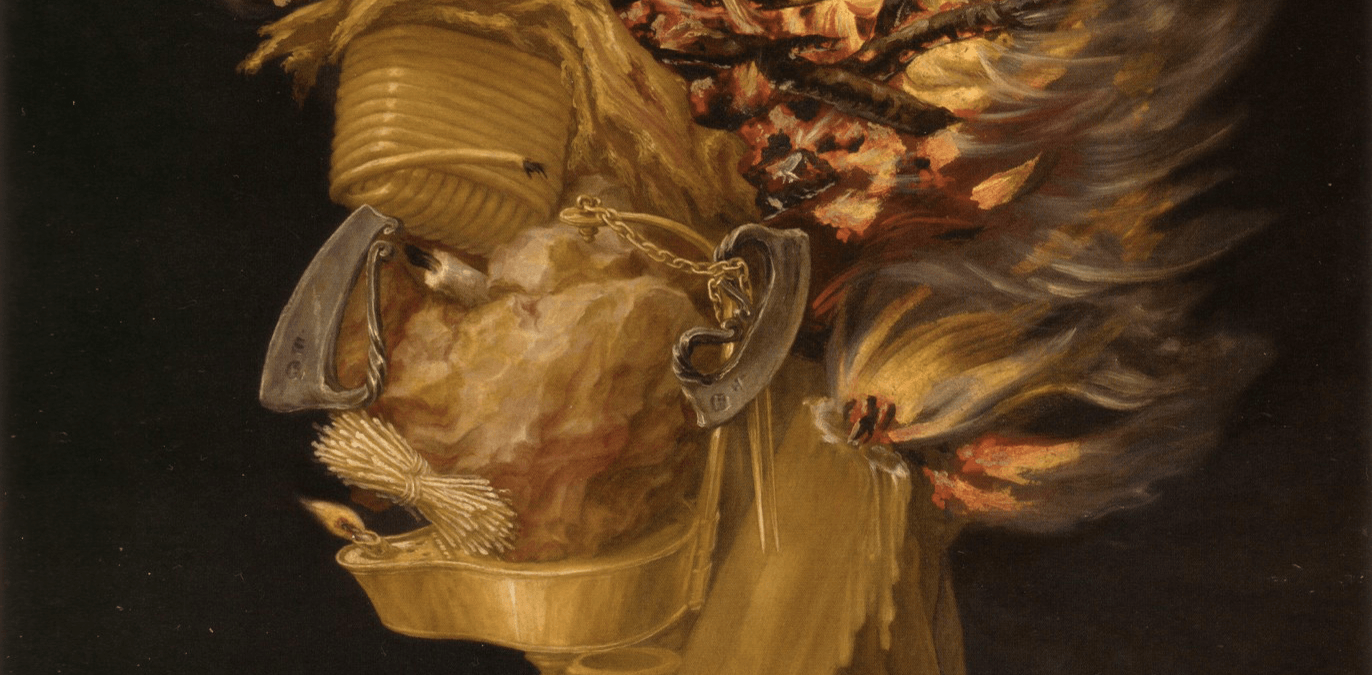
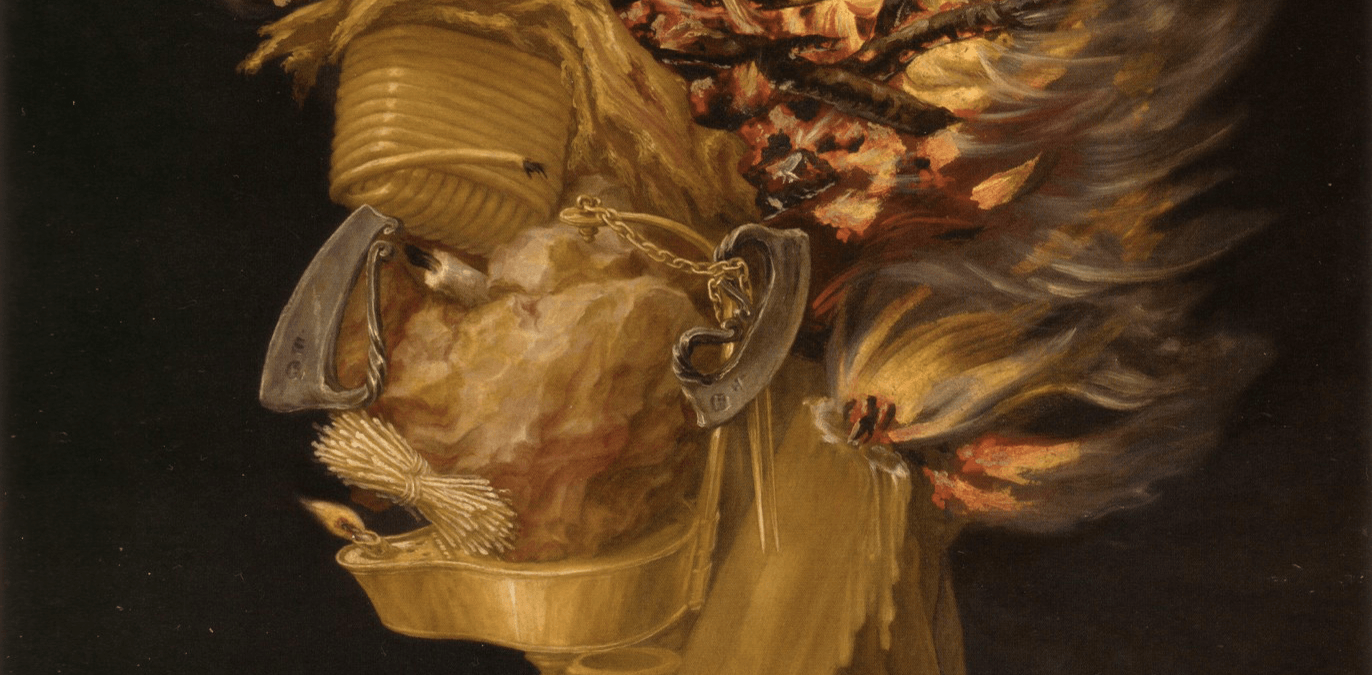
Mariana Enriquez è una scrittrice argentina; il suo ultimo libro pubblicato in Italia è la raccolta di racconti Le cose che abbiamo perso nel fuoco (Marsilio, 2017) dove, in una Buenos Aires nerissima, si alternano vicende che sfociano nel surreale e storie puramente fantastiche. Nel 2018 un racconto di Enriquez è apparso nel primo numero italiano della rivista letteraria Freeman’s edita da Black Coffee: “Vieni qui, tesoro”, una storia d’amore che, oscillando tra momenti grotteschi, crudeli e comici, esplora il feticismo in una dimensione horror, a partire dall’ossessione della protagonista per i malati di cuore. “La canzone della torre più alta”, il racconto che pubblichiamo qui, è invece tratto dall’ultimo numero di Freeman’s, dedicato all’amore. (AC)
E ra nel cortile del palazzo, seduto sul sudicio materasso che fungeva da divano. Sarei partita quella notte e volevo vederlo prima di lasciare Parigi. Ricordo con grande chiarezza di aver pensato: non sono innamorata. Lo conosco da appena una settimana. Non so nemmeno il suo cognome.
Guillaume aveva aperto un pacchetto di sigarette e allungato la mano. Mi ricordo che aveva agitato le dita affusolate per chiedere qualcosa e io avevo intuito: una penna. Non mi guardava. Aveva scritto il suo indirizzo e-mail sulla carta argentata del pacchetto: guillaumejolie1980@hotmail.com. Era l’estate europea del 2003 e lui era seduto sul materasso con un completo nero, con quegli sfuggenti occhi azzurri e i capelli talmente unti da sembrare bagnati. Avevo messo il suo indirizzo nel portafogli e non gli avevo detto: «Ti scriverò», e lui non si era avvicinato per un’ultima carezza. Mi aveva lasciato andare. La notte prima era stata troppo straziante. Avevo salito le cinque rampe di scale in legno fino all’appartamento della mia amica dove le mie valigie erano già pronte, ma al secondo piano avevo iniziato a piangere e avevo pensato, Perché è tutto così drammatico, perché voglio tornare giù ad affondare il viso nella sua camicia bianca che puzza di sudore vecchio di settimane e andare con lui? Esploreremo insieme, cacceremo nei deserti, dormiremo sui marciapiedi di città sconosciute, senza pensieri, senza dolore. Avevo preso un analgesico, aperto la doccia, e mi ero ripetuta che avevo trent’anni, che qualsiasi amore di una settimana appena, per quanto travolgente, era dimenticabile e che un ragazzo come lui, così giovane – Guillaume di anni ne aveva ventitré – era un capriccio, una leggerezza, un gioco, una cosa di cui vantarsi, il parigino bello e tenebroso, un Rimbaud di Barbès, il mio ragazzo morente con le vene bucate dagli aghi e con le cicatrici di ferite autoinflitte, segni pallidi e precisi, orizzontali, recenti.
Quando ero uscita dalla doccia e avevo sbirciato fuori dalla finestra Guillaume se n’era già andato dal cortile – dal cour – e anche la borsa non era più sul materasso. Ero contenta. Quando era arrivato il momento di andare all’aeroporto la mia amica mi aveva accompagnato alla fermata della metro: cercavo Guillaume a ogni angolo – i suoi capelli biondi, il completo nero. Non era nemmeno alla stazione ad aspettarmi, nonostante la notte prima avesse promesso di esserci, prima di arrabbiarsi perché gli avevo detto di no, che doveva lasciarmi andare da sola, che il tempo passato insieme era stato piacevole. Piacevole, aveva ripetuto.
Très jolie.
Non ne avevo fatto menzione alla mia amica. Non avevo parlato di Guillaume per il resto del viaggio, con nessuno, nemmeno per alleviare il peso tragico della storia. A Barcellona, ultima tappa, mi svegliavo ogni mattina con la nausea. L’amica da cui alloggiavo, dietro la porta chiusa del bagno, mi chiedeva se stavo bene e io dicevo Sì, forse è per qualcosa che ho mangiato, troppi aerei, residui di ansia. Non erano residui: era una scheggia ansiosa di ferro incastrata in gola e il ricordo delle gambe di Guillaume, stranamente pelose per uno così biondo – le gambe di un fauno, di un demone. Dopo aver vomitato bile, ogni mattina mi guardavo allo specchio e trangugiavo tranquillanti a digiuno.
Eppure non gli scrivevo. Guardavo la carta argentea nel portafoglio e lasciavo perdere. Andavo all’Internet café e mandavo messaggi a tutte le persone di poco conto, capo, amici, ex marito. Per chiamare i miei genitori dovevo usare la carta – ve la ricordate? Si grattava un morbido strato di piombo grigio per svelare il codice: andava inserito prima di comporre il numero. Guillaume era capitato in quel mondo, prima di Gmail, prima degli smartphone, quando il telefono ancora squillava e non c’erano social network e non si viveva online, quando non si viaggiava con il computer a meno che non ce ne fosse davvero bisogno e i motori di ricerca non facevano saltar fuori curriculum, fotografie o fedine penali. Ho soltanto tre foto di lui, prodotte da una macchina fotografica analogica. Due sono state scattate a una festa. Oggi proprio non me lo spiego quel mondo dove era ancora possibile perdersi e dove anche ritrovarsi poteva risultare impossibile.
Scrissi a Guillaume il giorno stesso del mio rientro a Buenos Aires, esausta, con la valigia intatta abbandonata nel bel mezzo del soggiorno. Poi mi sedetti in attesa di una risposta, immaginandolo in qualche Internet café aperto tutta la notte in Rue des Poissonniers, che sorrideva alla vista del mio messaggio. Aggiorna. Mi si seccò la bocca all’arrivo della risposta. Troppo presto. Quel tossico ha la casella piena, pensai. O forse non ha capito il mio messaggio, la mia triplice lingua: parlavamo un po’ di francese, un po’ di inglese, un po’ di spagnolo.
Il messaggio diceva che l’indirizzo era inesistente, che l’errore era irreversibile e non avrei dovuto provare ancora.
Lì per lì non capivo. Guillaume aveva sbagliato a scrivere il suo indirizzo? Era un errore di Hotmail? Forse avevo sbagliato io a digitarlo? Copiai e rimandai il messaggio. Stesso risultato. A volte capita, quando una casella è piena, pensai, mentendo a me stessa. Poi dormii quattordici ore grazie alle pillole, mi svegliai in un lago di sudore, vomitai nel bagno e gli riscrissi con il caffè che si freddava accanto alla tastiera. Stesso risultato, errore irreversibile, non è stato possibile consegnare il messaggio.
Ricordo di aver provato una disperazione vertiginosa molto simile al panico. Ripenso a quel momento e sono sbalordita dalle discussioni che si fanno sull’amore romantico, che se fa male non è amore. Come tieni a bada l’adrenalina durante un terremoto? Come controlli il panico in un incendio domestico? Come si ferma la tachicardia quando il referto annuncia un cancro, o una gravidanza? Chi vorrebbe vivere così anestetizzato?
Telefonai alla mia amica a Parigi. Le raccontai cosa stava succedendo. «Le mie e-mail tornano indietro». Fingevo una certa dose di calma, anche se credo avesse percepito la mia devastazione. Mi disse: «Appena lo rivedo gli richiedo l’indirizzo. Quel tipo è sempre rincoglionito». Quindi partì a raccontarmi del suo nuovo lavoro in una galleria nel Marais. Io seguitavo a mandare messaggi ogni giorno all’indirizzo guillaumejolie. Jolie. Bonito, piacevole. Très jolie, aveva riso amaramente la nostra ultima notte, durante quella discussione senza fine piena di lacrime e sesso. Mi aveva ingannato, il Jolie era la sua vendetta. Perché? Non avevo chiesto io il suo indirizzo, non avevo insistito per rimanere in contatto. Che il suo corpo sempre febbricitante serbasse malanimo? Gli avevo sfiorato le cicatrici con la punta delle dita. Tremava sempre. Un uomo che vuole automutilarsi non può non essere dannato, pensavo. «Andiamo a Charleville» gli avevo detto un giorno. «Odio la Francia» aveva risposto. Voleva andare in Mali, da dove erano emigrati i musicisti con cui suonava.
Un giorno la mia amica, dopo diverse settimane di ansia insopportabile, mi scrisse un’e-mail piena di pettegolezzi e novità: accennava di sfuggita al fatto che non aveva più visto Guillaume, e che lui non era mai tornato a Rue Myrha. I suoi amici a queste sparizioni ci erano abituati. A volte andava a casa dei genitori, in campagna. Guillaume non tornò mai nel palazzo dove viveva la mia amica. Lei si trasferì più a nord, in città. Smise di frequentare i suoi vecchi vicini: i cileni erano tornati in Cile, i normanni amici di Guillaume erano tornati a Rouen, e lei non indagò più perché io non insistetti – dopotutto era stata solo una settimana e le nostre vite erano andate avanti. Non l’ho più sentito. Non so se è vivo o morto, non so niente dei normanni, non ho più trovato il gruppo con cui suonava, una ricerca su Guillaume Jolie tira fuori una marea di risultati – troppi! – inutili e imprecisi, non so neanche se sia il suo vero cognome, la mia amica si è dimenticata della mia intensa storia d’amore e in ogni caso ormai non ha più importanza. È possibile che lui non si ricordi di me. So di non aver mai buttato via la carta metallica con la sua grafia incerta, ma non ho idea di dove sia: persa da qualche parte in casa.
Non ho osato buttarla perché non avrò mai un altro uomo come Guillaume. Si bucava in bagno con la porta mezza aperta per essere osservato come il poète maudit per antonomasia. I suoi capelli color sabbia sul cuscino e la tristezza con cui mi aveva raccontato il poco che so della sua famiglia: il padre schizofrenico chiuso in una stanza perché la moglie gli negava le cure psichiatriche. Un paesino. Le lezioni di musica oltremodo impegnative. La sua delusione quando gli avevo detto che odiavo il jazz. «Non è che lo odio» avevo ritrattato, per alleviare il suo dolore. «Non mi piace, non lo capisco». «Te lo spiego io» aveva replicato, e io avevo risposto no, non ce n’è bisogno, parto tra una settimana, e lui aveva sospirato e la sua enorme mano esile aveva preso la mia per posarsela sul petto scarno, e aveva lasciato che lo guardassi.
Non avrò mai più un altro uomo del genere: la sua giovinezza debole, moribonda, un cucciolo che non può e non vuole vivere ma che è scappato dalla madre per non essere mangiato e adesso è un suicida ambulante, un maestro di fantasmagorie. «So che non è sano,» mi aveva detto una notte, dopo aver bevuto un sorso di vino direttamente dalla bottiglia «ma se rimani forse mi verrà voglia di vivere». Parlava così: senza vergogna, senza paura, nell’intimità della notte tossica. Non avevo mai deriso la sua intensità. Ancora non ero cinica. Non mi affascina più avere vicino qualcuno che desidera morire; voglio invecchiare, non sono più attratta da quei feroci invalidi, credo di essermi addomesticata, non penso che la miglior cosa sia una bella dormita da ubriachi sulla sabbia.
Magari è cambiato. O magari è morto, proprio come voleva. Non sono mai stata nuda accanto a qualcuno tanto bello: la pancia infossata, le anche sporgenti, la schiena senza imperfezioni, liscia e morbida come quella di un neonato, gli occhi che risplendevano al buio, il collo delizioso con quei piccoli aloni di sudiciume.
Mi sono dimenticata di raccontare come l’ho conosciuto. Mi trovavo nell’appartamento del Normanno n° 1. Era in corso una festa improvvisata a base di musica e alcol. Guillaume mi aveva baciata dopo che gli avevo chiesto di passarmi il whisky. Avevamo iniziato una conversazione che era durata sette giorni. A quella festa aveva ballato nudo su richiesta di un vicino gay che l’aveva incoronato Uomo più bello della città. Poi si era rimesso i pantaloni, mi aveva condotto in un angolo e spinto contro il muro, io avevo alzato la gonna, aperto le gambe e avevamo fatto sesso proprio lì, davanti a tutti. Non so se gli altri se ne fossero accorti, urlavano e penso stessero ballando il flamenco. Mi ero sentita protettiva e triste quando, prima di penetrarmi, si era bagnato le dita di saliva e mi aveva chiesto aiuto con il preservativo – ottime abitudini sessuali, in quegli anni di epidemia – e avevo visto i segni dell’ago sul braccio quando per baciarmi si era scostato i capelli biondi dalla bocca e a mente lucida avevamo stimato l’ampiezza della mia innocenza.