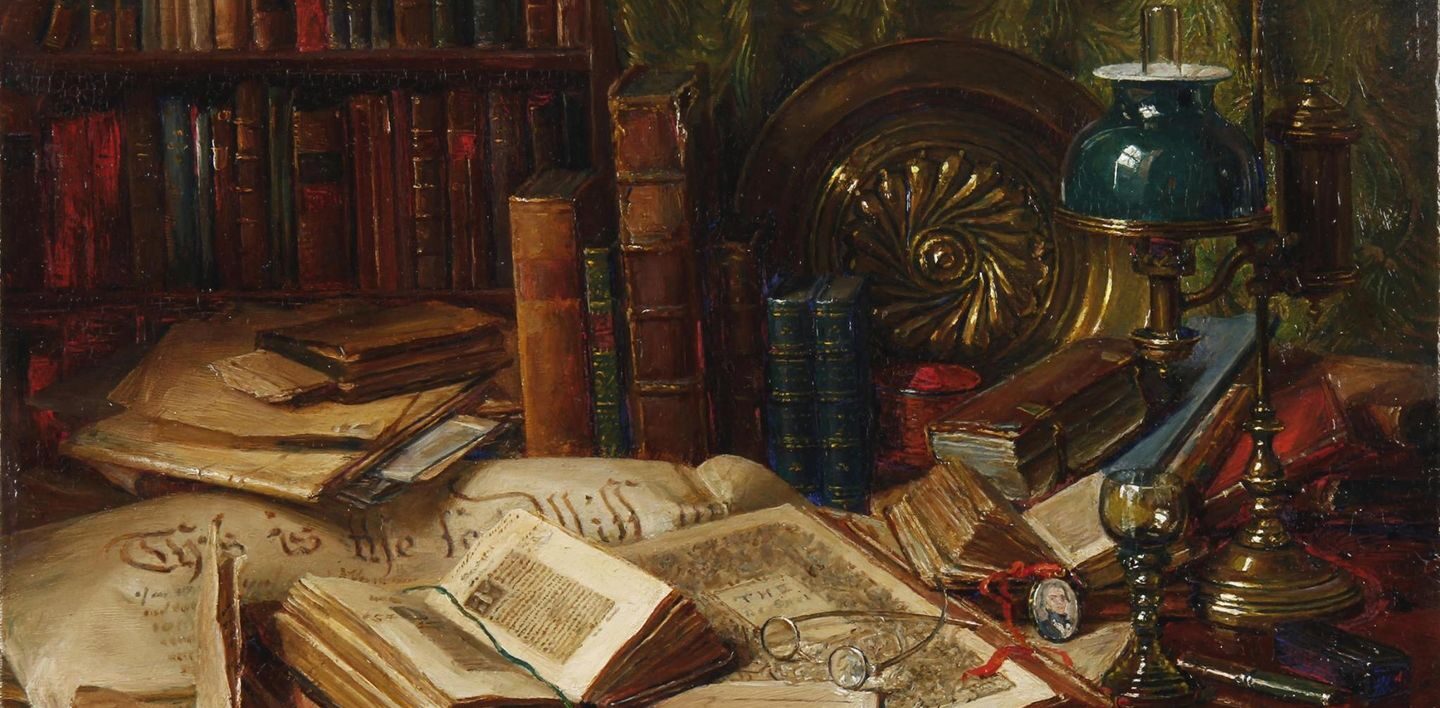
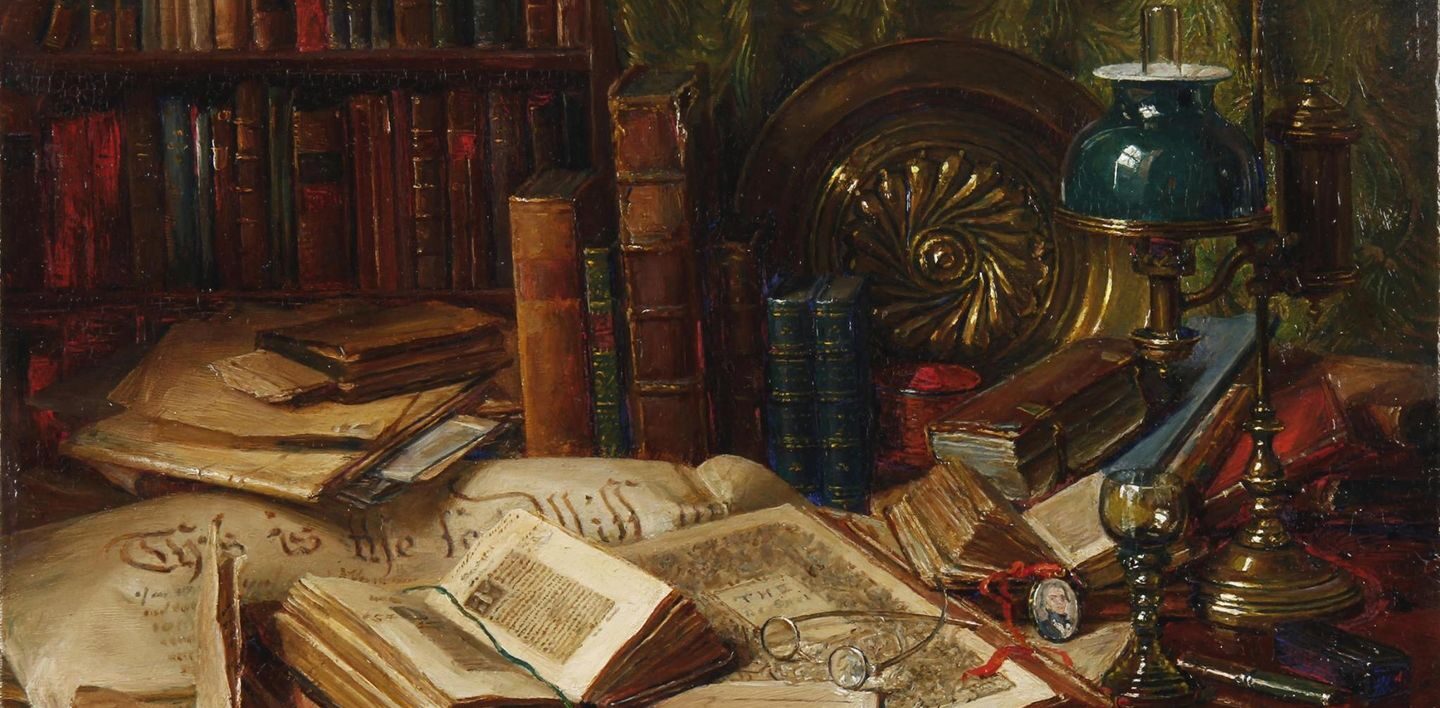
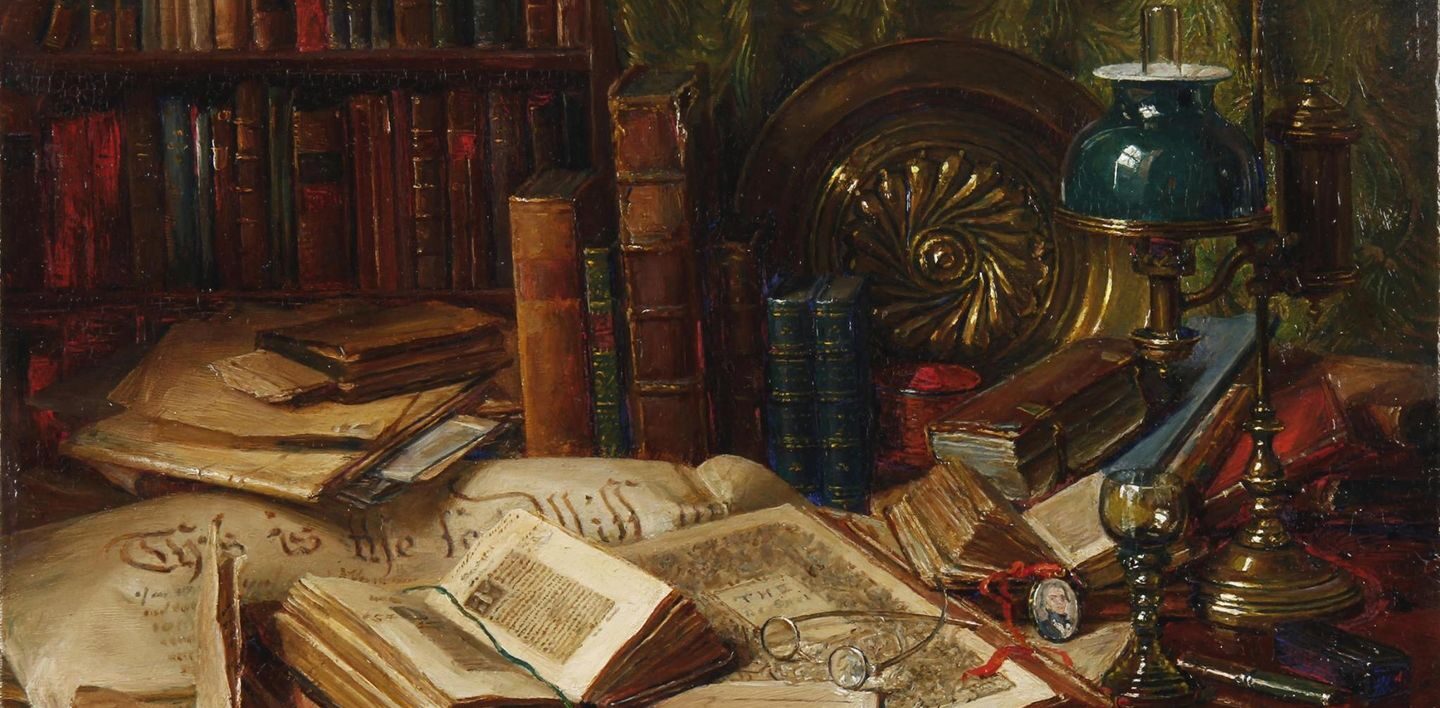
N
egli ultimi mesi si sono sviluppati due dibattiti che hanno saturato la bolla del mondo di chi si occupa, a vario titolo, di scrittura. Il 10 aprile Grazia Verasani pubblica un post su Facebook, che poi viene ripreso sul Resto del Carlino e poi da diversi giornali, in cui lamenta il fatto che le presentazioni di libri sono uno sforzo notevole per chi scrive e per chi le organizza ma forse servono sempre meno:
La domanda è: perché ci ostiniamo a presentare, o a cercare recensioni, quando è diventato quasi umiliante, e non parlo tanto o solo di me, ma in generale: ho assistito a troppe presentazioni di scrittori anche piuttosto noti vuote di gente. E ogni volta che gli scrittori vedono una platea semideserta assumono espressioni da ego ferito che fanno male al cuore. Dobbiamo accettare di essere un’elite e stare a casa con i nostri animali da compagnia? Accettare che non legge quasi più nessuno? Chi ce lo fa fare di macinare chilometri per toccare la triste realtà con mano? Eh, me lo chiedo sempre più seriamente…
Le reazioni che seguono e che continuano anche oggi sono state letteralmente migliaia, segno che al di là dello sfogo estemporaneo, c’è un nodo che è stato scoperto. Di che si tratta, però?
Il 16 giugno scorso su Substack e poi su che Instagram, su Tik Tok e sul suo blog, una donna con il nickname di Kants Exhibition scrive un post critico nei confronti della scuola Holden. Si chiede se la frequentazione della scuola – lei è un’ex allieva del triennio 2018-21 – e i 20.000 euro di spesa per il corso principale siano davvero utili ad apprendere le tecniche di scrittura o servano invece a conferire uno status e a favorire delle relazioni sociali che si potrebbero acquisire anche in altri modi meno costosi. Anche qui ovviamente ci sono state molte reazioni, compresa quella della scuola Holden stessa, che ha pubblicato un reel che aveva realizzato qualche tempo prima, in cui provava a ironizzare sulla critica, soprattutto riguardo al costo economico. Il video è stato poi rimosso perché le reazioni ancora più urticate hanno investito anche questa difesa d’ufficio.
I post sollevano due questioni importanti: la sostenibilità di due pezzi fondamentali della filiera dell’industria editoriale, la formazione degli scrittori e la promozione dei libri. Ma al di là del merito, le due questioni sono soprattutto sintomatiche di un’altra questione, grande quanto un elefante sempre più imponente in una stanza sempre più stretta. In Italia si leggono sempre meno libri, un pezzo consistente del settore editoriale è in crisi e una parte non piccola rischia di chiudere. Ma non è questa la notizia peggiore. La notizia peggiore è che una società che legge di meno peggiora da tanti punti di vista.
I dati degli ultimi mesi sono agghiaccianti. Nelle prime 24 settimane del 2025 sono stati comprati due milioni netti di libri in meno, un calo di fatturato di 31 milioni: un dato che equivale al 5% di lettori persi, uno su venti. Le statistiche sul lettorato del 2024 ci davano già conto di una condizione rovinosa. L’Istat rilevava che solo il 40% legge almeno un libro l’anno. Altre statistiche – Eurostat – mostravano che l’Italia è il Paese in Europa dove si legge meno dopo Cipro e la Romania. La percentuale di chi legge almeno un libro l’anno, secondo Eurostat, è del 35%, a confronto di una media europea del 53%. Nel Nord Europa si arriva almeno al 70%, in Francia, Germania e Spagna siamo abbondantemente sopra il 50. Anche nelle rilevazioni dell’AIE (Associazione italiana editori), che sono più confortanti (anche a fronte di una diversa concezione della lettura e di una diversa selezione del campione), restano però alcuni indici significativi, come quello del tempo medio usato per la lettura: quello settimanale si riduce, secondo i dati AIE del 2024 a 2 ore e 47 minuti contro le 3 ore e 16 minuti del 2023 e le 3 e 32 minuti del 2022.
In Italia si leggono sempre meno libri, un pezzo consistente del settore editoriale è in crisi e una parte non piccola rischia di chiudere. Ma non è questa la notizia peggiore. La notizia peggiore è che una società che legge di meno peggiora da tanti punti di vista.
Perché si legge meno? Come invertire questa tendenza? Può diventare comprensibile, alla luce di questi dati, come la questione della formazione degli scrittori e la promozione dei libri siano degli epifenomeni, rispetto a problemi sistemici e di lunga durata. Ma la sintomatologia non è da sottovalutare. È chiaro che la vulgata per cui l’editoria, nella sua accezione più ampia – la creazione e la confezione di contenuti – sia un luogo in cui è bello lavorare, che accoglie progetti, desideri, e fa da volano all’emancipazione individuale e collettiva, è una narrazione con sempre più passaggi difettosi e illusori. I social in questo hanno esasperato una tendenza di lunga durata. Descrivere il mondo dei libri, della lettura e della scrittura, come un universo felicemente esperienziale, ha eliminato in buona parte l’idea che i libri siano un prodotto diverso dagli altri. I mondi che contengono possono essere complessi, problematici, conflittuali, inutili, difformi, respingenti, contraddittori. La delusione per una scuola di scrittura che promette una realizzazione delle proprie aspirazioni e richieste e che poi invece non mantiene, o per delle presentazioni che al posto di essere una festa della relazione con i lettori sono solitarie e frustranti, non sono tanto segreti di Pulcinella (di una comunità che fa finta di non essere aspirazionale, in cui il proprio successo dipende tanto dall’impegno prestazionale quanto dall’insuccesso dei propri colleghi, in un mercato che non solo non si allarga ma si restringe); ma è piuttosto l’esito della trasformazione dell’industria culturale dagli anni Novanta in poi.
La scuola Holden nasce nel 1994. È lo stesso anno dell’inizio della più grande narrazione politica italiana contemporanea, il berlusconismo: il video con la calza sulla camera, “questo è il Paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti”. Caduto il muro di Berlino, indebolite le Grandi interpretazioni del mondo, basta un bauscia che si spaccia per self made man per rendere credibile politicamente una svolta regressiva spacciata per rivoluzione liberale. Ma il berlusconismo rende chiaro un bisogno: la smania di uscire dal Novecento della serietà e del rigore. Il nuovo miracolo italiano è una grande fiera dell’autoincantamento. Come era accaduto per la televisione commerciale, il modello pubblicitario può costituire uno standard di verità collettivo con il quale identificarsi facilmente, mentre crollano i regimi, i partiti, le ideologie.
Alessandro Baricco nel 1994 ha 36 anni, e ha studiato filosofia a Torino. È l’università di Luigi Pareyson, di Umberto Eco, di Gianni Vattimo, la culla del pensiero ermeneutico italiano. Gli anni Settanta sono stati gli anni della svolta ermeneutica. Il conflitto delle interpretazioni (come si intitolava il libro di Paul Ricoeur del 1969) è diventato un conflitto a tutto campo, di massimalismi delle critiche, di ideologie contrapposte, un conflitto anche aspro e persino sanguinario, in cui gli intellettuali hanno pensato che non fosse possibile essere disimpegnati, che ha determinato grandi trasformazioni, ma anche lasciato sul campo morti, feriti, e infine riflusso, e fraintendimenti spacciati per rovesciamenti interpretativi. Il desiderio di demistificazione, ironia, alleggerimento, laicità, sembra emergere di pari passo con la risoluzione emergenziale del contrasto alla lotta armata e alle rivoluzioni postcolonialiste, la repressione delle lotte operaie. Il thatcherismo e il reaganismo per la prima volta rendono suadente la narrazione del potere esaltando i desideri individuali e non le istanze collettive.
Negli anni Novanta il nuovo miracolo italiano è una grande fiera dell’autoincantamento. Come era accaduto per la televisione commerciale, il modello pubblicitario può costituire uno standard di verità collettivo con il quale identificarsi facilmente, mentre crollano i regimi, i partiti, le ideologie.
Decretata la sconfitta della classe operaia, la fine dei gloriosi Trenta, la fede nella narrativa ingloba il disincanto per la politica. Per dire, nel numero di Granta dei best younger novelist del 1983 ci sono scrittori che, di fronte alla degenerazione thatcheriana, mostreranno cosa vuol dire diventare esemplari maestri di questa capacità di trasfigurazione del romanzo politico e sociale in altri generi (romanzo storico, thriller, fantascienza, noir…): Salman Rushdie, Ian McEwan, Kazuo Ishiguro, Martin Amis.
Anche per l’Italia la fine del decennio dei Settanta ha un che di funesto. Il 1980 arriva dopo il sequestro e l’omicidio Moro, è il momento in cui le Brigate Rosse si alleano con la Nuova camorra organizzata, è l’anno della marcia dei 40.000. A mettere un punto a quel decennio arriva la pubblicazione del più venduto romanzo italiano del Novecento, Il nome della rosa, 55 milioni di copie in tutto il mondo: una messa in pratica delle idee narratologiche sviluppate da Eco negli anni Settanta in Opera aperta, nel Superuomo di massa o in Lector in fabula, e riprese con precisione nelle Postille al Nome della rosa del 1983, con la consapevolezza che nel giro di vent’anni si è passati dalle idiosincrasie del Gruppo ’63 alla autolegittimazione del postmoderno.
Il famoso passaggio:
Ma arriva il momento che l’avanguardia (il moderno) non può più andare oltre, perché ha ormai prodotto un metalinguaggio che parla dei suoi impossibili testi (l’arte concettuale). La risposta post-moderna al moderno consiste nel riconoscere che il passato, visto che non può essere distrutto, perché la sua distruzione porta al silenzio, deve essere rivisitato: con ironia, in modo non innocente. Penso all’atteggiamento post-moderno come a quello di chi ami una donna, molto colta, e che sappia che non può dirle “ti amo disperatamente”, perché lui sa che lei sa (e che lei sa che lui sa) che queste frasi le ha già scritte Liala. Tuttavia c’è una soluzione. Potrà dire: “Come direbbe Liala, ti amo disperatamente”. A questo punto, avendo evitata la falsa innocenza, avendo detto chiaramente che non si può più parlare in modo innocente, costui avrà però detto alla donna ciò che voleva dirle: che la ama, ma che la ama in un’epoca di innocenza perduta. Se la donna sta al gioco, avrà ricevuto una dichiarazione d’amore, ugualmente. Nessuno dei due interlocutori si sentirà innocente, entrambi avranno accettato la sfida del passato, del già detto che non si può eliminare, entrambi giocheranno coscientemente e con piacere al gioco dell’ironia… Ma entrambi saranno riusciti ancora una volta a parlare d’amore.
Comunque, quello che è accaduto è che il più importante intellettuale italiano si è trasformato in un romanziere popolare, il quale confessa come ogni decostruzione faccia venir voglia di costruzione, soprattutto quando la realtà viene sequestrata dalle narrazioni complottarde come era accaduto con il racconto della stagione del terrorismo italiano. Il dispositivo più efficace è quello di inglobare gli scetticismi e cimentarsi con una letteratura che riesca a mantenere un orizzonte demistificatorio nella mistificazione, stabilendo con il lettore un patto più laico, democratico, aperto, in cui si mescolano ironia e credulità, mosse dell’autore e contromosse del lettore. Nel Pendolo di Foucault (1988) questo intento sarà ancora più manifesto.
Con il senno di poi, ma forse anche di allora, poteva essere il modo di uscire dal cul-de-sac di chi aveva creduto nelle utopie politiche e ora si trovava ad avere a che fare più che con il sol dell’avvenire con le rovine ridicole di regimi al collasso. Ma anche una mossa del cavallo generativa dopo la morte dell’autore decretata dai vari Paul De Man, Roland Barthes, Michel Foucault. A prendere la parola all’inizio degli anni Ottanta sono nuovi autori, che si riconoscono già in una generazione disincantata, escapista, che diserta, che ama viaggi, naufragi, deragliamenti, digressioni, narrazioni picaresche: Enrico Palandri, Pier Vittorio Tondelli, Andrea De Carlo, Aldo Busi, Daniele Del Giudice…
Non si sa se Baricco abbia letto La filosofia dopo la filosofia o l’ancora più radicale Verità e progresso di Rorty. Ma condivide questa visione che, in nome della laicità e del postmoderno, sostituisce la narrazione all’interpretazione come modello principale per aver a che fare con il mondo.
Non si sa se Baricco abbia letto La filosofia dopo la filosofia o l’ancora più radicale Verità e progresso di Rorty. Ma sappiamo dalle cose che scriverà di lì a poco che condivide questa visione che, in nome della laicità e del postmoderno, sostituisce la narrazione all’interpretazione come modello principale per aver a che fare con il mondo. È lui stesso a raccontare anni dopo questa sua svolta, e indica come data finalmente periodizzante il 1997, quando si autocommissiona per Repubblica un articolo sul passaggio della cometa Hale-Bopp. Il direttore di Repubblica è Ezio Mauro, con cui Baricco ha già cominciato a collaborare alla Stampa e con cui condivide un’idea di giornalismo narrativo. Lo storytelling.
[…] Hale-Bopp, sembra un nome inventato e invece erano i due astronomi semidilettanti che avvistarono per primi questa cometa che ad un certo punto, nel 1997, passò molto vicina alla terra […]
Al tempo lavoravo, ma anche adesso, per un giornale, italiano, quotidiano, Repubblica, […] Non il tipo di giornalismo che si faceva quando io ero piccolo… Quando io ero piccolo i giornali erano di una noia sconfortante. Questo è un giornalismo creato negli anni ’90 e uno di quelli che lo hanno inventato, non il solo, ma uno di quelli che lo hanno inventato era il mio direttore del giornale in quel momento. Quindi era uno che c’aveva l’istinto, c’aveva la velocità, proprio il senso, proprio il sentimento per l’aspetto narrativo del mondo. È lui con gli altri che hanno tirato fuori dalla cronaca del mondo il potere dello storytelling e delle storie… Un genio, a suo modo. E difatti quando sentì che alla gente piaceva questa storia della cometa […] tirò su il telefono e telefonò a me, e mi disse […]potresti andarla a vedere e fare un bel pezzo, di quelli tuoi, così un po’… da scrittore, così no… Erano gli anni ’90, adesso siamo più smaliziati, allora questo era ancora abbastanza…non dico rivoluzionario, ma era nuovo in un certo modo.
E lì era praticamente 4/5 giorni prima del giorno fatidico, che era il 24 marzo che era il giorno della massima vicinanza della cometa. L’attesa per questa cometa era stata tale che alcune città più New Age di altre, avevano perfino deciso quel venerdì 24 Marzo, di spegnere una parte delle luci della città di modo che la gente con lo sguardo su vedesse in cielo passare senza troppo inquinamento di luci questa cometa.
Intere città che si oscuravano per la bellezza di vederla passare, il 24 marzo.
Cosi quando il direttore mi disse ‘valla a vedere, scrivi un pezzo’, gli dissi ‘sì volentieri’ […] ok vado venerdì poi ti faccio il pezzo il giorno dopo, d’accordo […]
E sentii un lungo silenzio dall’altra parte del telefono… Ero anche stupito perché avevo detto di sì una volta tanto, perché spesso dicevo di no, ma avevo detto di sì… Di solito lui era entusiasta […] e poi sento lui che dice ‘beh un po’ tardino però’ […] ‘no io pensavo che potevi andare stasera a vederla’ erano tipo quattro giorni prima.
[…] Io gli dico ‘ma insomma la cometa passa il 24 Marzo’. Ed ecco cosa mi rispose lui, un genio… Mi rispose ‘la cometa passa quando lo diciamo noi’.
Adesso detto così voi dite ‘ma chi è questo essere immondo’… No guarda, invece aveva capito esattamente. […] La sera alle 11 ero in collina fuori Torino a vedere questa roba piccolissima che si vedeva anche male ero nel nulla non c’era nessuno che la guardava, la gente pensava ad altro, c’era una macchina con una lucina, una stradina…
[…] Scrivo il pezzo e Repubblica esce effettivamente in anticipo sul giorno della cometa, cioè il giorno prima del giorno della cometa, ed esce con queste paginate bellissime in cui c’era anche il mio pezzo […] E quel giorno dato che poi i media si ispirano l’uno con l’altro, tu non potevi aprire il giornale che c’erano paginate sulla cometa, la cometa, la cometa… Quella sera tutti col naso su, a guardare la cometa.
Il giorno dopo, 24, giorno della cometa le città spengono la luce… La gente sacramenta dice ma cos’è ’sta storia che avete spento le luci, perché la cometa non esisteva già più se l’erano vista il giorno prima ‘la cometa passa quando lo diciamo noi’. Fatti senza storytelling non esistono. Se sai gestire lo storytelling puoi anche anticipare un fatto di un paio di giorni, ma anche di una settimana. Se sei molto bravo un mesetto prima guarderanno la cometa che non c’è neanche ma è come se la vedessero. Ma non perché sono scemi. No. Perché tu sei bravo in quella circostanza lì.
Anni fa, quando la Scuola Holden era appena nata, questo testo ne era per cosí dire la Bibbia. Lo si studiava con grande lentezza e cura, in un lettorato che durava l’intero primo anno di studi e che era tenuto dal preside, cioè da me. La ragione era semplice: la Holden è una scuola di narrazione, e Benjamin è colui che meglio di ogni altro ti può introdurre a riflettere su cosa mai voglia dire, veramente, quel termine.
La prima cosa che va detta è che Benjamin ha il merito di riportare la narrazione al posto che le spetta, dandole una centralità, nell’umano pellegrinaggio, che non è scontata. Oggi noi ci troviamo a vivere in una società fortemente segnata dalle narrazioni, ma bisogna ricordare che non sempre è stato cosí. Se vogliamo essere piú precisi, non ci deve sfuggire che dall’inizio del Novecento fino almeno a tutti gli anni Ottanta del secolo, narrare è stato, in Occidente, un gesto minore, e spesso misconosciuto. Tutta l’esperienza delle avanguardie (a cui proprio l’entourage intellettuale di Benjamin aveva dato un fortissimo sostegno ideologico), aveva in qualche modo imposto una sostanziale equazione tra valore dell’opera e suo mutismo narrativo. L’Ulisse di Joyce, i quadri di Mondrian, la musica di Schönberg, per fare degli esempi, determinavano una concreta eclisse del narrare, indicando come direzione della ricerca obiettivi completamente differenti. Nello scrivere letterario si è arrivati a un estremismo antinarrativo che fino agli anni Ottanta ha preteso, e a volte ottenuto, di confinare a pratica kitsch qualsiasi desiderio, semplice, di raccontare storie. E nello stesso cinema, che per le sue radici plebee da luna park aveva una sorta di lasciapassare per la volgare pratica del narrare, è rimasta comunque a lungo una linea di demarcazione tra prodotto commerciale e film d’arte dove l’accesso all’arte era spesso fatto risalire al rattrappirsi dell’enfasi narrativa. Nel cuore di un simile processo, nel 1936, Benjamin innalza il narratore nella cerchia dei maestri e dei saggi. Di piú, lo ricostruisce come forza originaria, come mito di fondazione, come pietra angolare nell’architettura dell’umano.
Nel 2009 esce, sempre per Einaudi, il saggio-manifesto sulla letteratura italiana a firma di Wu Ming, intitolato New Italian Epic. Anche tra i numi tutelari di Wu Ming c’è Walter Benjamin e in particolare Il dramma barocco tedesco (che Baricco liquida come testo incomprensibile in una nota del Narratore). Wu Ming scrive:
Portando il discorso alla sua inevitabile conseguenza, si può dire che tutte le opere narrative siano ambientate nel passato. Anche quando il tempo verbale è il presente, si tratta di una forma di presente storico: il lettore legge di cose già pensate, già scritte, già oggettivate nel libro che ha in mano. Dunque tutte le narrazioni sono allegorie del presente, per quanto indefinite. La loro indeterminatezza non è assenza: le allegorie sono «bombe a tempo», letture potenziali che passano all’atto quando il tempo giunge. La definizione dell’allegoria come «espediente retorico» si mostra del tutto inadeguata, e infatti Walter Benjamin, nel suo Il dramma barocco tedesco (1928), descrisse l’allegoria come una serie di rimbalzi imprevedibili, triangolazione fra quello che si vede nell’opera, le intenzioni di chi l’ha creata e i significati che l’opera assume a prescindere dalle intenzioni. Questo livello dell’allegoria è privo di una “chiave” da trovare una volta per tutte. È l’allegoria metastorica […] ciò che diverse narrazioni hanno in comune sotto le apparenze, e sotto i livelli più vicini alla superficie.
Adesso tutto è narrativo: vai in una macelleria e il modo di esporre le carni è narrativo. Ormai è impossibile sentir parlare uno scienziato normalmente: anche lui narra. Lo stesso vale per i giornali, che hanno sostituito al settanta per cento l’informazione con la narrazione. E poi c’è la contaminazione con il marketing. Lì comincia il pericolo, così come quando lo storytelling entra nella comunicazione politica. Adesso sono diventati così bravi da riuscire a vendere quello che vogliono se riescono ad azzeccare la storia giusta.
Le storie hanno un potere. Un potere di liberazione estetica, per Baricco; un potere di emancipazione politica per Wu Ming. Quello che ovviamente non era stato preso in considerazione era che la consapevolezza del potere delle storie viene incamerata presto dal capitalismo più aggressivo.
Arriviamo a oggi. Questa lunga, disomogeneissima, escursione nel passato prossimo della riflessione sulla narrativa italiana, può concludersi con le due polemiche da cui eravamo partiti: la manifestazione d’insofferenza e delusione di un’ex allieva della scuola Holden per la formazione allo storytelling, a cui sono seguite molte reazioni dello stesso segno o di segno contrario; la manifestazione di insofferenza e delusione di una scrittrice per le presentazioni, a cui sono seguite molte reazioni dello stesso segno o di segno contrario. Le due lamentele sembrano il segnale di una questione sistemica, come dicevamo all’inizio. La bolla dei lettori si è ristretta. Le infrastrutture culturali che pensavamo solide, la scuola, l’università, il sistema bibliotecario, il sistema istituzionale di sostegno all’editoria, vengono costantemente indebolite attraverso definanziamenti e cattiva gestione, mancano di norme che guidino un cambiamento radicale. In altri Paesi, come la Spagna per esempio, è accaduto, già negli anni zero. Un disfacimento che si è mostrato anche in momenti grotteschi e avvilenti come l’ultima fiera di Francoforte dove l’Italia come Paese ospite è riuscita a presentarsi senza un progetto di sistema, con uno status immiserito dall’arroganza del potere, perdendo del tutto un’occasione di esposizione e riflessione internazionale.
Le infrastrutture culturali che pensavamo solide, la scuola, l’università, il sistema bibliotecario, il sistema istituzionale di sostegno all’editoria, vengono costantemente indebolite attraverso definanziamenti e cattiva gestione, mancano di norme che guidino un cambiamento radicale.
Il mondo di chi scrive e legge e produce e compra e dà importanza ai libri è in umiliante contrazione. E quindi, che si fa? Le reazioni sono spesso pavloviane e controproducenti. Solidificare delle posizioni di rendita, come spesso fanno le case editrici, le società di distribuzione o di vendita, non risolve ma amplifica il problema più urgente: come arrivare ai nonlettori, ai lettori deboli, a chi non può permettersi consumi culturali. Sembra significativo che la risposta di Baricco e della Holden a questione sistemica sia, nel piccolo, esemplarmente, di ripensare la dimensione live dell’esperienza estetica. L’ultima iniziativa della scuola Holden, ideata da Baricco con Enrico Melozzi, è la Traviata da cortile, che prevede la trasformazione della scuola Holden in uno spazio scenico. Wu Ming è più esplicito nel programma che segue e che propone per ripensare e rinnovare la relazione con la comunità dei lettori. Nell’intervista che Wu Ming 1 ha rilasciato a Loredana Lipperini per Lucy, c’è una importante considerazione di sistema che risponde alla manifestazione d’insofferenza e prova a politicizzarla:
Allora il problema è a monte: è quello delle vite logoranti, della fatica mentale, dei lavori di merda. Senza queste premesse, l’attività predatoria delle piattaforme di Big Tech, il loro estrattivismo, sarebbe molto più difficile. Aggiungiamoci i salari bassi, le pensioni da fame… Molte persone i libri non riescono più a comprarli.
Presentare è ciò che più fa vivere un libro, e nei casi migliori lo trasforma proprio in un utensile, tipo coltellino svizzero, a disposizione di chi vive i territori. In questi mesi Gli uomini pesce – certo, per i temi che tocca e per come lo fa, ma anche perché lo sto portando in giro a più non posso – è diventato un dispositivo per catalizzare energie e far convergere soggetti diversi. Alle presentazioni di questo libro sono nate collaborazioni, alleanze e amicizie. E questo non è esclusivo dei libri di Wu Ming: mutatis mutandis, può accadere con altri libri, è accaduto, accade.
[…] Incontrare lettrici e lettori è già politico, mi spingo a dire che è già lotta. La letteratura non è politica tanto per il suo contenuto, quanto per i legami che può stabilire. I colleghi e le colleghe che pensano di sostituire questo con una presenza – e una vanvera tuttologica – a getto continuo sui social si stanno consegnando all’irrilevanza. Irrilevanza non a livello mediatico: irrilevanza nella vita delle persone in carne e ossa.
A metà degli anni Novanta, facevo filosofia all’università, mi ritrovai a frequentare tutti i venerdì pomeriggio gli incontri di una rivista. Uno studente di lettere Emiliano Caprio aveva partecipato a un bando dell’Università La Sapienza di Roma ed era riuscito a farsi finanziarsi una rivista che aveva chiamato Liberatura, rivista di libera scrittura. Per tre anni dal 1995 al 1999, ci riunimmo nelle stanze del dipartimento di filologia romanza, per leggere e discutere di testi che scrivevamo. Una microscopica selezione di questi testi poi veniva raccolta nel numero annuale che veniva pubblicato; pubblicare non era il primo dei nostri interessi. Vederci e discutere erano un’esperienza già coinvolgente di per sé. Questi incontri settimanali erano lunghi, popolati, e ogni volta diversi: piano piano venne fuori un gruppo che era una composita redazione allargata di studenti e ex studenti, narratori, poeti, drammaturghi, di cui quasi nessuno aveva pubblicato nemmeno in fanzine. Alcuni che animavano questi incontri sarebbero diventati poi degli autori pubblicati, professionisti, anche un po’ noti, in campi della scrittura molto diversi, dalla saggistica alla poesia al teatro alla narrativa al fumetto. Giordano Tedoldi, Paolo Pecere, Marco Mantello, Simone Consorti, Veronica Raimo, Francesco Longo, Sara Ventroni, Fabio La Piana, Angela Maria Rucco alias Veronika Bekkabunga, Laura Cingolani, Adriano Marenco, Lucio Del Corso, Paolo Pagnoncelli… Altri, con un talento cristallino, avrebbero smesso di scrivere, Leonardo Pafi, Francesco Russo. C’era anche chi, come Martina Testa, si sarebbe messa a lavorare come traduttrice e editor nell’editoria. Sicuramente me ne dimentico molti altri.
La buona battaglia per gli intellettuali o per chi riconosce le ingiustizie e le storture dell’industria culturale è di lottare per la scuola pubblica e l’università pubblica libera e di qualità prima di tutto. È lì che si impara a essere una comunità di lettori, e anche di artisti.
Allora immaginavo fosse quello che accadeva normalmente nelle università pubbliche. Di lì a poco mi resi conto che invece ero stato fortunato, perché avevo vissuto quella che era una parentesi temporale che sarebbe terminata a breve: l’università sarebbe rimasta vittima di definanziamenti e della involuzione neoliberista. Lo realizzai bene proprio quando cominciai a leggere Mark Fisher che raccontava come l’università – nel suo caso Warwick – era stata la fucina di laboratori di riflessione teorica e pratiche artistiche d’avanguardia. Nel 1995 Sadie Plant a Warwick aveva fondato la CCRU, la Cybernetic Culture Research Unit, un leggendario gruppo matrice di molte delle cose più interessanti della cultura cosiddetta alternativa inglese dei decenni successivi. Fisher partiva dalla sua esperienza per ragionare di come il capitalismo neoliberista avesse attaccato proprio questo tipo di funzione dell’università, rendendole dei luoghi di competizione e conformismo.
Per questo la buona battaglia per gli intellettuali o per chi riconosce le ingiustizie e le storture dell’industria culturale è di lottare per la scuola pubblica e l’università pubblica libera e di qualità prima di tutto. È lì che si impara a essere una comunità di lettori, e anche di artisti. E a pensare che questo porti anche a un miglioramento della vita democratica.