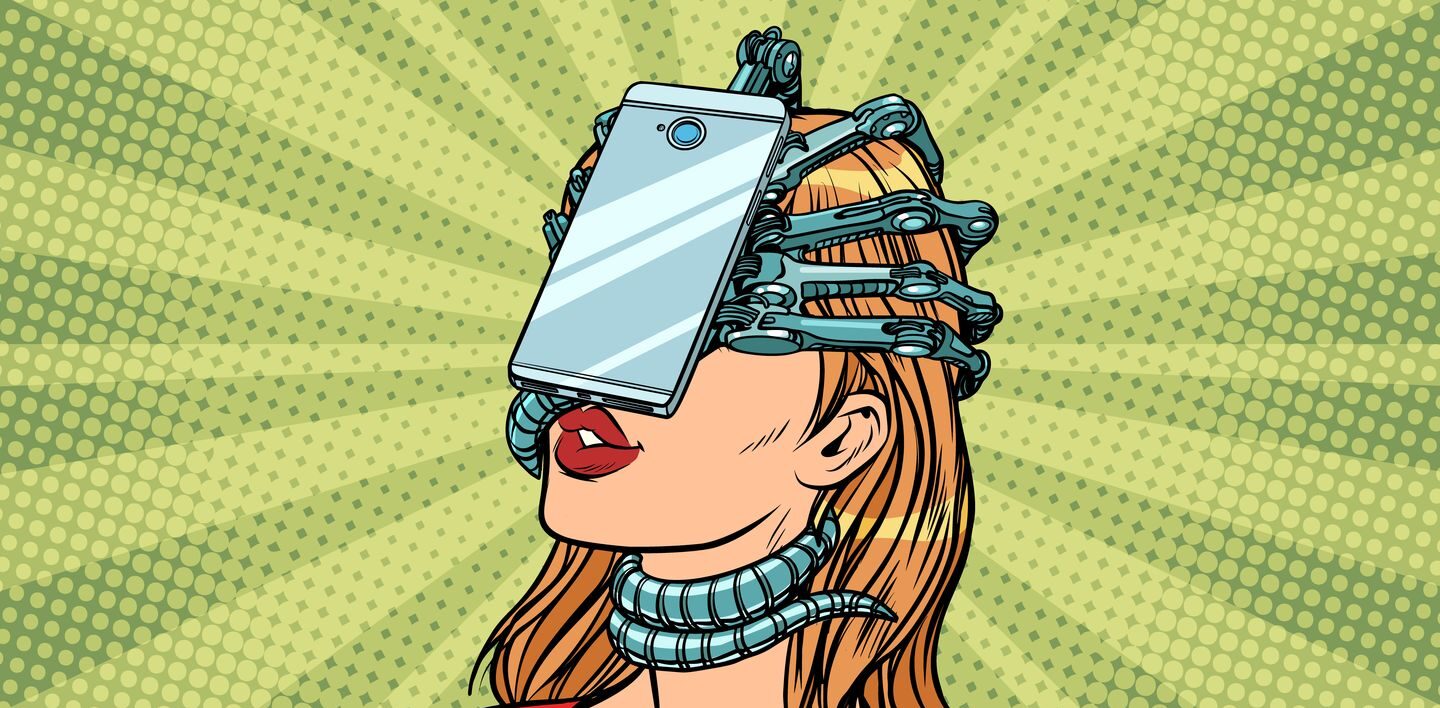
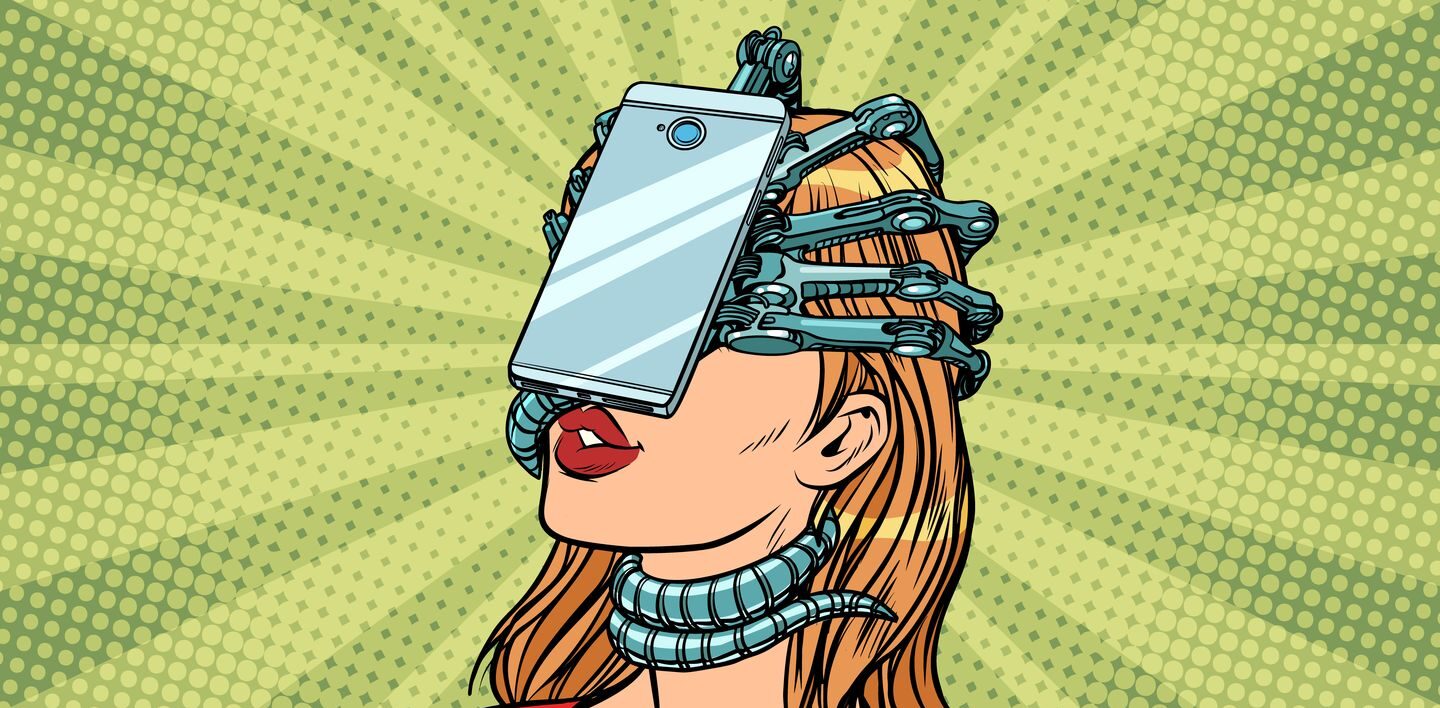
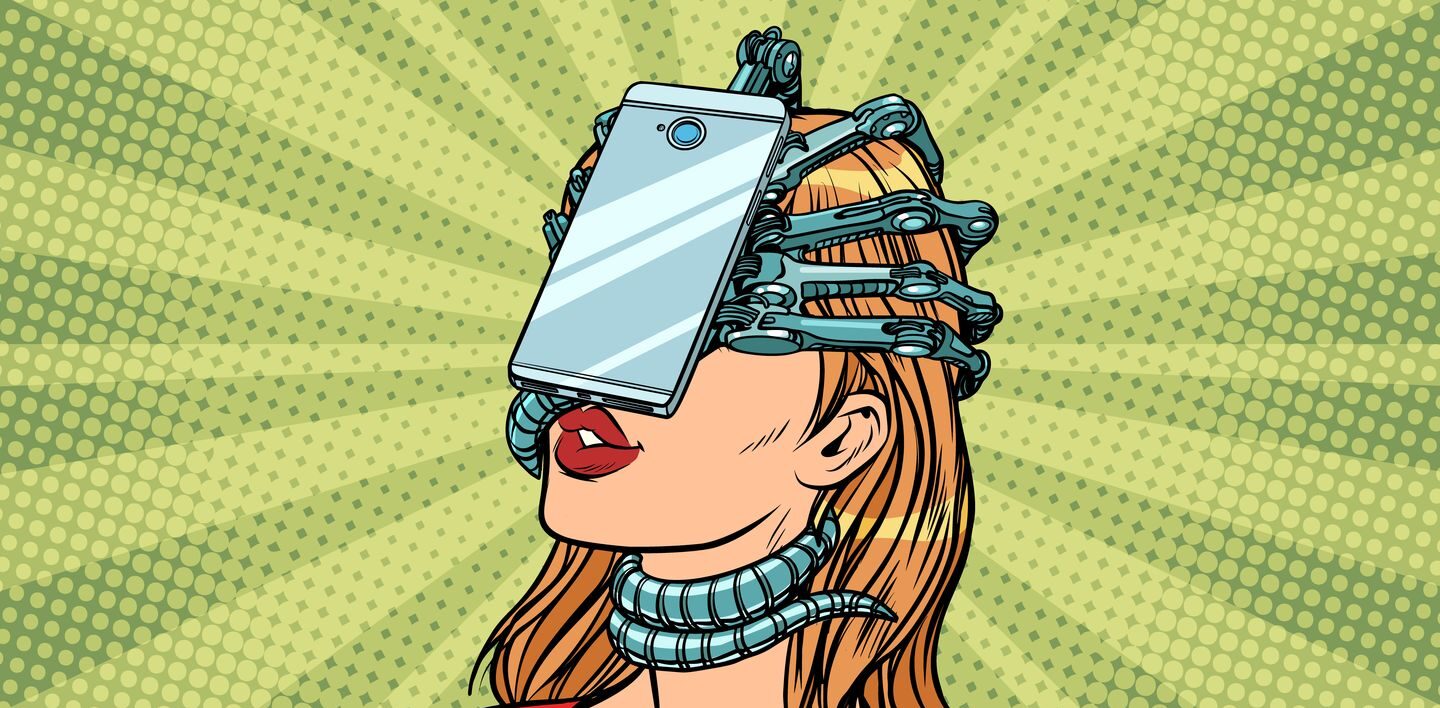
Q uando osserviamo qualcosa immaginiamo qualcosa. Lo dice la psicologia cognitiva: nell’elaborare mentalmente quello che vediamo, ne allarghiamo i confini. Se guardiamo la fotografia di una finestra in un palazzo, nella nostra mente estendiamo l’inquadratura. Ogni atto di visione suscita una risposta emotiva che produce immaginazione. Se al mattino vediamo le foto che i nostri amici hanno pubblicato la sera prima, ricostruiamo mentalmente i contorni di quell’evento. Se eravamo presenti sarà un ricordo, altrimenti la nostra immaginazione suggerirà i contorni di una festa che ci siamo persi. Ricordo quando, durante un seminario di disconnessione digitale, nel corso di storia dei media del 2023 all’università di Torino, un ragazzo raccontò di svegliarsi ogni mattina con la sensazione di essersi perso qualcosa, di inseguire la festa degli altri. Questo suggerisce che quando guardiamo delle fotografie non è solo il nostro apparato visivo ad attivarsi, ma anche un sistema di proiezione del contesto sociale che trasforma quell’immagine, in qualcos’altro: per esempio una fonte di nostalgia per una possibilità non realizzata.
I confini dell’immaginario
Nel racconto Pics di Tony Tulathimutte (incluso nella raccolta Rifiuto, 2025) Alison guarda le foto della fidanzata dell’amico, con cui vorrebbe stare, e sente il bisogno di competere, comunicando un’immagine di sé che risulti affascinante. Vorrebbe usare Instagram per creare un’aura da elusiva intellettuale, ma con una spontaneità che faccia sembrare la rivale, al confronto, una cacciatrice di attenzioni. Purtroppo per Alison ogni soluzione le sembra banale, nessun angolo sembra valorizzarla, e resta imprigionata nel paradosso dell’autenticità costruita ‒ realizzare una foto che nasconda la finalità implicita in ogni immagine postata: indirizzare lo sguardo degli altri, fare sì che ci vedano come vogliamo essere visti. Come vedremo, questa spinta a costruire un’immagine di sé giocando con l’immaginazione altrui contribuisce a restringere le possibilità dell’immaginazione e dell’azione, spingendoci verso una “simbiosi” talvolta parassitaria con i nostri dispositivi.
Secondo la sociologa Eva Illouz la modernità è caratterizzata dall’onnipresenza del sogno a occhi aperti, che ha come oggetto essenziale la costruzione di un’immagine: un “sé sognato”. Nella serie TV Too Much scritta e diretta da Lena Dunham, Jessica ha registrato 537 video di dialogo immaginario con la fidanzata del suo ex. Un flusso che la tiene bloccata in una realtà parallela, l’unica dove esprime quello che prova. Quando per errore pubblica i video, si meraviglia di come la soglia tra pubblico e privato sia sorvegliata da un solo tasto. Nell’introduzione al romanzo Queer, nel 1985, William Burroughs scriveva che “la disintegrazione dell’immagine di sé produce spesso un’indiscriminata fame di immagini”, riferendosi all’indifferenza per la propria immagine provocata dalla dipendenza da eroina.
La spinta a costruire un’immagine di sé giocando con l’immaginazione altrui contribuisce a restringere le possibilità dell’immaginazione e dell’azione, spingendoci verso una “simbiosi” talvolta parassitaria con i nostri dispositivi.
Nostalgia immaginaria
Nel 1973 Susan Sontag scriveva: “la nostra è un’epoca nostalgica e i fotografi sono promotori attivi della nostalgia”. Nell’accelerazione del presente la nostalgia ha assunto le proporzioni di un mondo fantastico, in cui si può desiderare di abitare anche se non lo si è mai sperimentato in prima persona. Per avere un’idea di cosa intendiamo, torna utile un aneddoto musicale piuttosto recente.
A giudicare dalle stime, nel 2025 l’umanità ha scattato più di 2 trilioni di fotografie, la quasi totalità con uno smartphone. Questa iperattenzione all’immagine di sé è associata a un aumento significativo del livello di stress.
Sentirsi nel posto giusto al momento sbagliato è un tipo di nostalgia particolare, perché non investe il vissuto, ma l’immaginato: la possiamo chiamare nostalgia storica. Secondo lo Human Flourishing Lab (HFL) la nostalgia storica è una risorsa per costruire l’immagine di sé, grazie a esplorazioni culturali di un passato mai vissuto. Ci si costruisce un’identità con citazioni e gadget di epoche superate. Il fidanzato di Jessica, la protagonista di Too Much, un aspirante musicista, usa un walkman e prepara compilation di CD, come negli anni Novanta: una playlist non algoritmica. Secondo la ricerca di HFL se il fenomeno del viaggio nel tempo culturale è comune a più generazioni, per la generazione Z ha particolare rilevanza il tema della disconnessione. La nostalgia storica viene usata per dare forma a un futuro con meno ansia, con relazioni significative e un senso di sé più stabile.
In Italia, secondo l’ultimo rapporto Coop circa il 69% degli intervistati afferma che in passato si vivesse meglio, e il 53% degli appartenenti alla generazione Z è convinto che i propri genitori abitassero una realtà più confortevole. Ma come fa notare l’autore e scienziato Ian Bogost, una cosa che le nuove generazioni non sanno è che quella senza smartphone era una vita piena di tempi morti e attività noiose, e chi l’ha sperimentata tende a non averne particolare nostalgia.
Viene definita nostalgia vicaria, o storica, la tendenza a rimpiangere un passato che non abbiamo mai vissuto. Alcuni studi ipotizzano sia una risorsa che il nostro cervello utilizza per costruire l’immagine di sé.
A proposito di White Stripes: è cosa nota che Jack White creda che i limiti nutrano la creatività. I White Stripes facevano concerti senza scaletta, usavano solo tre colori per gli abiti di scena, e le chitarre erano strumenti da banco dei pegni, scelti appositamente perché sollecitassero un ulteriore impegno. Non era un rifiuto della tecnologia, ma il tentativo di non adagiarsi nelle sue scorciatoie. White ha resistito senza uno smartphone fino ai cinquant’anni, impresa che oggi non riesce quasi a nessuno. Eppure come notava nel suo Contro lo smartphone (2023) l’informatico Juan Carlos De Martin, non dovremmo dare per scontato che lo smartphone debba essere come quelli che maneggiamo adesso, controllati da due soli sistemi operativi, con applicazioni che hanno lo scopo di aumentare il tempo sul dispositivo.
Un’indagine del Washington Post ha scoperto che bastano 35 minuti di esposizione al formato video di TikTok per creare un’abitudine al consumo; inoltre, dopo una settimana d’uso il tempo trascorso sulla piattaforma tende a aumentare del 40%. “Non si tratta di dare la colpa alla tecnologia, ma di non rassegnarsi a una tecnologia che erode lo spazio di convivenza sociale e democratica”, mi ha detto De Martin, quando gli ho chiesto se negli ultimi anni ha visto cambiare l’atteggiamento delle nuove generazioni verso lo smartphone: “ho visto crescere un senso di autodifesa”.
Il punto non è mettere alla berlina la tecnologia in sé e per sé, ma piuttosto non rassegnarsi a una tecnologia che erode lo spazio di convivenza sociale e democratica.
Mente estesa, simbiosi e parassiti
“Tutti gli oggetti materiali fatti dall’uomo possono essere trattati come estensioni di ciò che l’uomo una volta faceva con il proprio corpo o con una parte specializzata del proprio corpo”, scriveva nel 1959 l’antropologo Edward Hall. Lo citava Marshall McLuhan all’inizio di La galassia Gutenberg (1962), in cui il sociologo canadese discute di come l’alfabeto fonetico e la stampa abbiamo contribuito a plasmare la società che abitiamo. Nella teoria dei filosofi Andy Clark e David Chalmers lo smartphone è un’estensione della nostra mente. Il telefono connesso a Internet e le applicazioni che usiamo sono uno strumento cognitivo, come le dita delle mani del bambino che impara a contare e la lista della spesa che aiuta a non dimenticare. Una recente obiezione a questa teoria è che gli smartphone non siano un’estensione cognitiva, perché incorporano interessi potenzialmente divergenti da chi li usa: gli smartphone sono progettati per manipolare gli utenti, quindi la relazione persona-smartphone somiglia piuttosto a una relazione simbiotica.
Nel loro recente paper “Smartphones: Parts of Our Minds? Or Parasites?”, la filosofa Rachael L. Brown e l’evoluzionista Robert C. Brooks ricordano che lo spettro delle relazioni simbiotiche in biologia va dal mutualismo al parassitismo: si passa dalla cooperazione con beneficio reciproco, a interazioni che, per asimmetria di vantaggi, indeboliscono l’ospite; sottolineano inoltre che si tratta di relazioni con uno scambio dinamico, fortemente caratterizzato dal contesto. L’analogia con lo spettro delle relazioni simbiotiche permette di evidenziare sia gli aspetti positivi dell’uso dello smartphone (orientamento, relazionalità, conoscenza), sia quelli negativi, dove cioè la volontà dell’agente soccombe a un’abitudine d’uso nociva.
Secondo Clark e Chalmers lo smartphone è un’estensione della nostra mente. Ma c’è chi non è d’accordo: poiché gli smartphone sono progettati per manipolare gli utenti, ci avviciniamo piuttosto a una relazione simbiotica di tipo parassitario.
Nei primi diciassette giorni del nuovo anno scolastico la biblioteca del liceo Pleasure Ridge Park High a Louisville, ha prestato 1.200 libri, in meno di venti giorni ha raggiunto la metà dei prestiti dell’intero anno precedente. A seguito di un divieto imposto dalla scuola, gli studenti, non potendo più usare i telefoni, prendono libri in prestito. Lo ha raccontato Jessica Grose, in un articolo in cui evidenzia come i livelli di comprensione del testo e i risultati di matematica, nel 2024, siano stati i più bassi degli ultimi trent’anni.
Per quanto possiamo avere la sensazione di poterci dedicare a due cose simultaneamente, la nostra capacità di concentrazione è limitata: riusciamo a dedicarci con impegno soltanto a una cosa per volta.
crea uno spazio vuoto che può essere usato per riflettere su come usare il mezzo. In fin dei conti non si tratta di non usare il telefono, ma di ridurre e circoscrivere il tempo passato sullo schermo. Con lo smartphone abbiamo la sensazione di poter controllare un’infinità di funzioni, una sensazione di potenza che ci risarcisce delle molte cose su cui invece non riusciamo a esercitare il controllo. Sottovalutiamo però quanto a nostra volta siamo controllati dallo strumento.
Restringimento dell’immaginario
Quando ho chiesto ai ragazzi di famiglia della generazione Z se lo smartphone a loro avviso estenda i confini dell’immaginario, mi hanno risposto senza esitazione che, al contrario, li restringe. Immagino che volessero dire che lo smartphone comporti una diminuzione di scelta, di possibilità di azione, perché sei indirizzato a seguire il flusso delle immagini proposte, a rispondere, dialogare, costruire, nei limiti delle applicazioni che usi.
Un’altra forma di nostalgia è quella per il futuro che non avremo. Brian Eno ha fatto spesso riferimento a questo tipo di nostalgia, di recente anche con il brano Cmon scritto con Fred Again. Come sarebbe un futuro in cui gli smartphone non fossero disegnati per creare dipendenza, isolarci dal mondo esterno, accumulare dati, appiattire l’offerta culturale, costruire monopoli finanziari, oltre ai servizi per cui li usiamo tutti i giorni. Brian Eno, come Jack White, non è un nemico della tecnologia, anzi, deve la sua carriera all’uso obliquo e inatteso di essa: “quando sono davanti a un dispositivo tecnologico non voglio sapere cosa può fare. Voglio sapere come posso usare quel dispositivo per fare qualcosa che il suo produttore non immaginava si potesse fare”. Non è una scelta comune. Gran parte del successo dell’offerta tecnologica si basa sulla vittoria della pigrizia contro l’iniziativa. L’opzione default, la modalità standard, la soluzione più veloce, la versione con meno passaggi, che riduce o annulla ogni frizione, vince. Insomma, vince, e viene adottato, ciò che scorre senza ostacoli, come sa chiunque lavori sull’esperienza d’uso, che sia un produttore di sintetizzatori o lo sviluppatore di un’interfaccia digitale.
Per Brian Eno, Jack White e molti altri artisti usare la tecnologia in modo inatteso fa parte del lavoro. Invece i limiti dell’immaginario e l’accumulo della nostalgia riguardano tutti; come la costruzione, fotografia dopo fotografia, di un sé che vorremmo ammirato da tutti, o il dialogo fantastico, giorno dopo giorno, con le migliaia di doppi digitali che incontriamo sul telefono. A tutti tocca scegliere tra immersione e minimalismo digitale, tra scorciatoie e scelte personali. In Jolene di Dolly Parton chi canta chiede alla rivale di non andarsene con il suo uomo. È una canzone che suggerisce di non fare qualcosa solo perché lo si può fare, ma di pensarci sopra e scegliere.