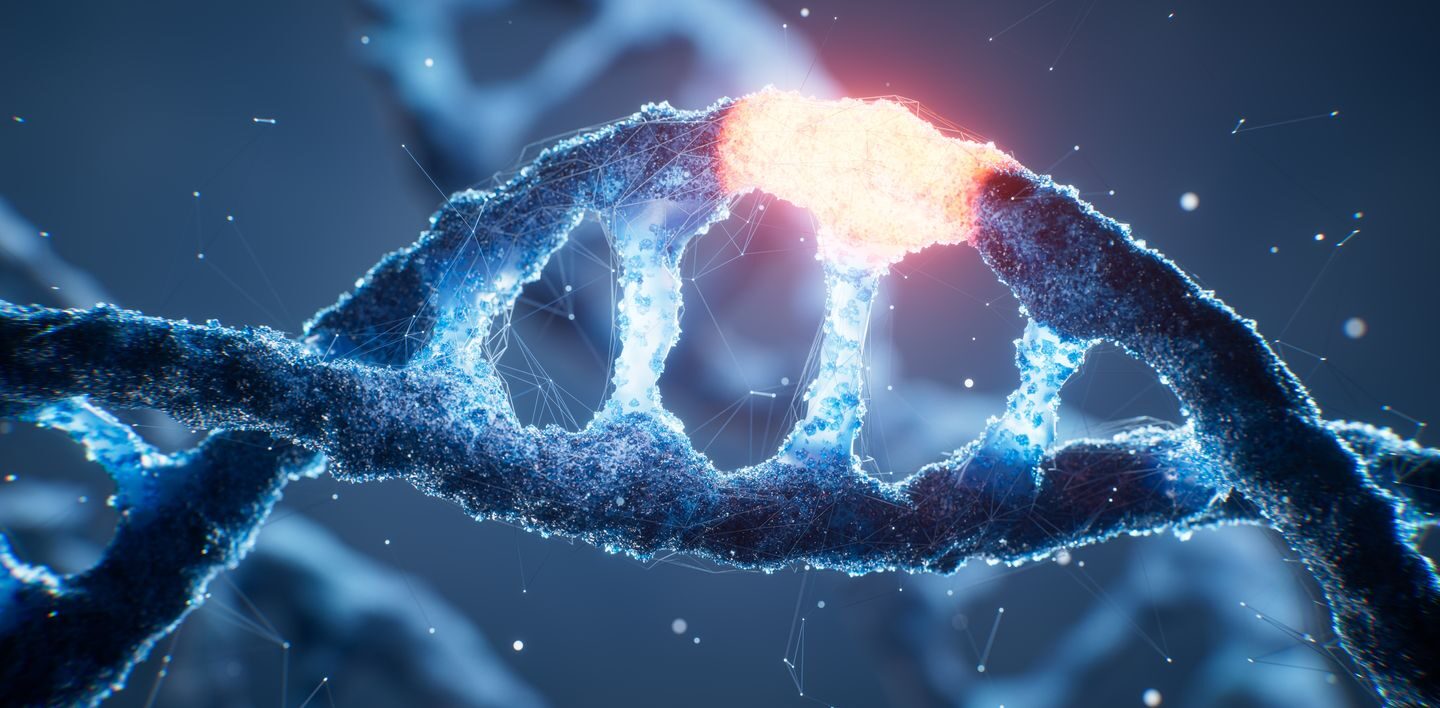
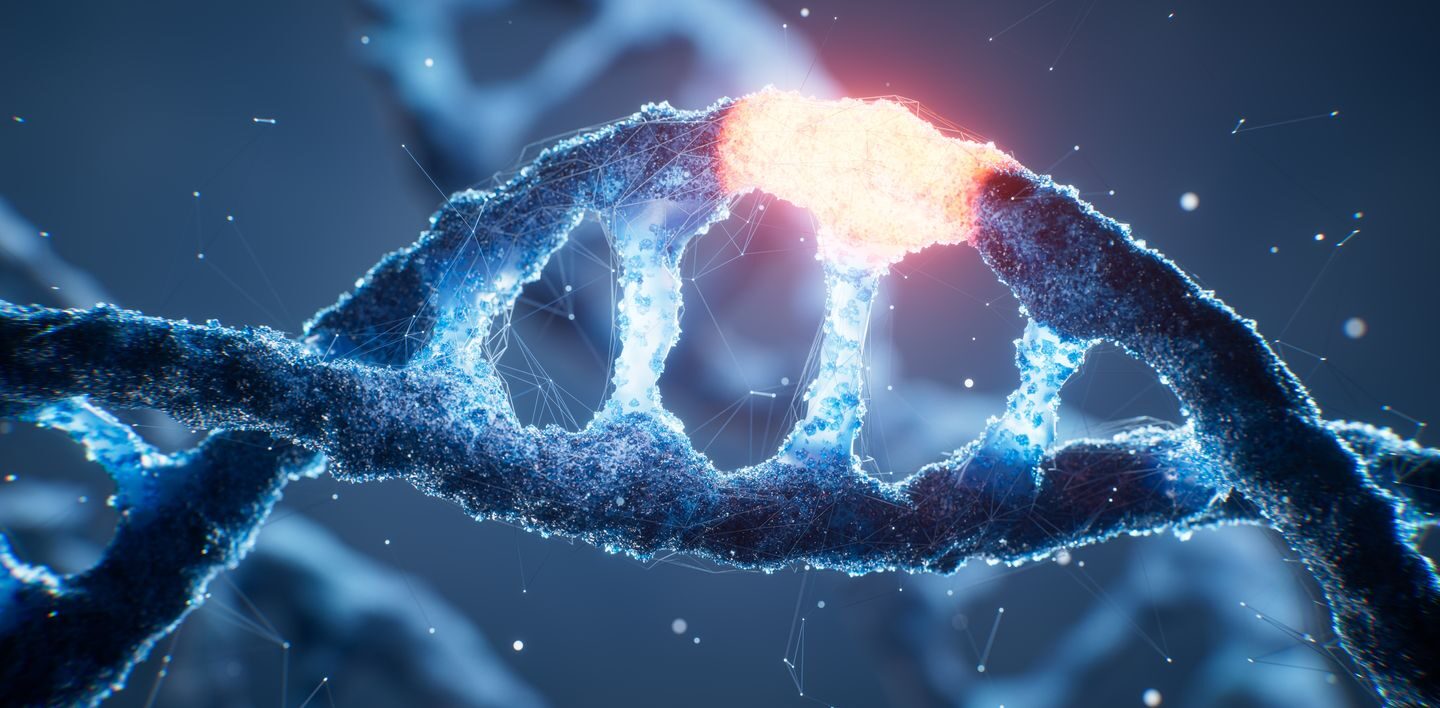
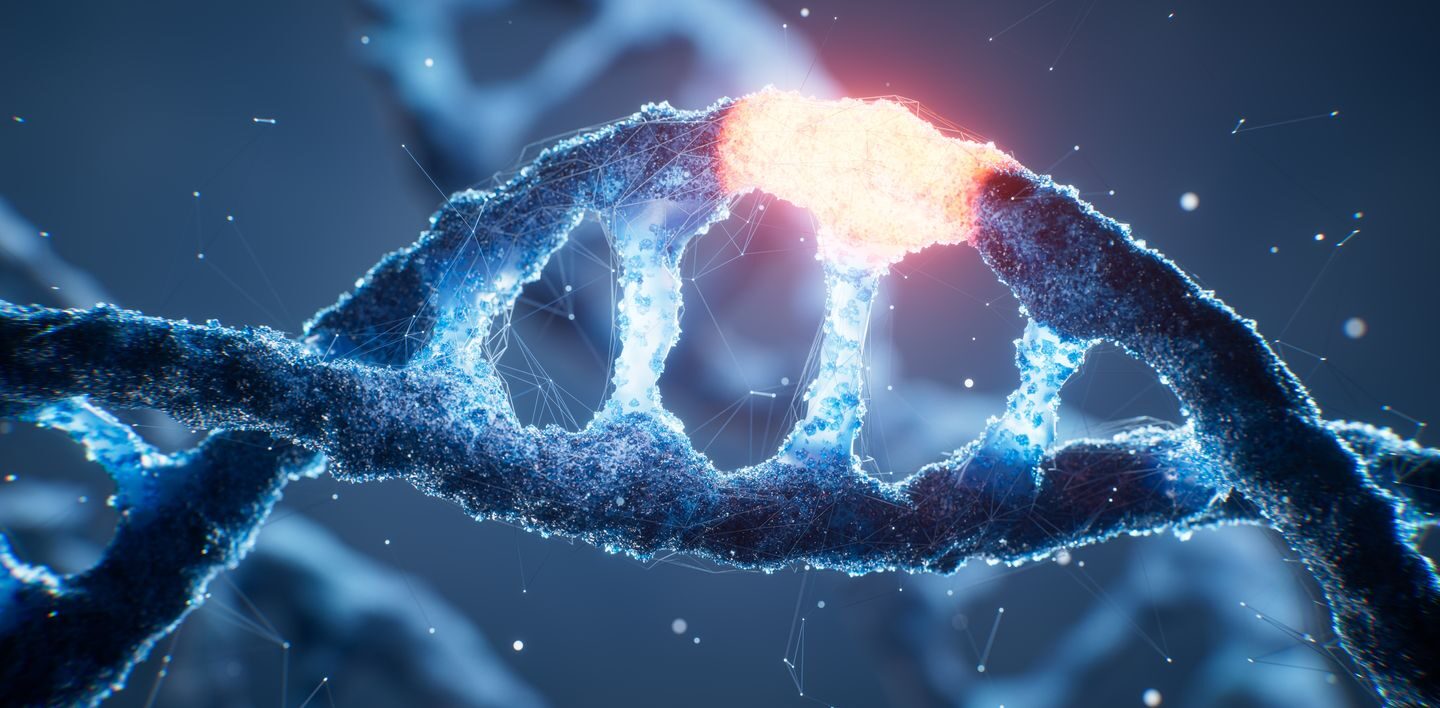
L a biologia evoluzionistica ha una storia strana. Per certi versi, la si potrebbe definire asimmetrica: dalla presentazione della teoria di Darwin e Wallace del 1858 (anche se, come i più appassionati sanno bene, il concetto di evoluzione non nasce certo lì), all’integrazione con la genetica mendeliana, la cosiddetta sintesi moderna intorno agli anni Trenta del Novecento, dagli sviluppi della genetica molecolare nel secondo dopoguerra, alle teorie sull’equilibrio punteggiato di Gould, alle recenti integrazioni con biologia dello sviluppo, epigenetica e le ultime scoperte in campo genetico (tra cui lo straordinario trasferimento genico orizzontale), l’impressione è che la materia sia nata come argomento da copertina, quasi pop, per diventare via via sempre più un tema di nicchia, adatto più che altro agli addetti ai lavori.
È chiaro che il successo straordinario di L’origine delle specie di Darwin e il suo impatto sulla società sono praticamente impossibili da replicare ai giorni nostri, ma rimane il fatto che un tema che occupava le prime pagine dei giornali nella seconda metà del Diciannovesimo secolo sia, di fatto, quasi totalmente scomparso da quelli che sono i grandi temi del dibattito scientifico, sociale e culturale mainstream. Con un’unica eccezione: i continui attacchi e dibattiti sulla veridicità della teoria.
Anche se alcuni di questi temi sanno un po’ di stantio per chi mastica bene la materia, è indubbio che un aspetto che ha sempre tenuto viva l’attenzione almeno di una parte del grande pubblico sulla biologia evoluzionistica sono state le continue critiche degli antievoluzionisti. La storia è ben nota: l’antievoluzionismo nasce nel Diciannovesimo secolo come reazione religiosa e culturale alle idee di Darwin, soprattutto in contesti cristiani conservatori. Poi, nel corso del Novecento, prende forma il creazionismo moderno, protagonista di scontri pubblici come il celebre processo Scopes del 1925 negli Stati Uniti. Col tempo, però, alcune posizioni si rivelano eccessivamente antiscientifiche per restare a galla e così, ironicamente, è lo stesso antievoluzionismo a evolversi: dagli anni Settanta si sviluppa il cosiddetto “disegno intelligente”, una versione aggiornata di questa dottrina, che continua a influenzare il dibattito pubblico, soprattutto sull’insegnamento dell’evoluzione delle scuole, ma non solo. Ma il dibattito, in certi casi, viene riacceso grazie anche ad alcuni studi scientifici tout-court, sfruttati ad arte. Ed è il caso di una recente ricerca.
Uno studio condotto da un gruppo dell’Università di Haifa in collaborazione con ricercatori del Ghana ha infatti riacceso un dibattito antico quanto la biologia evolutiva: le mutazioni sono davvero eventi casuali? Oppure il genoma possiede una sorta di predisposizione interna a generare alcune mutazioni più di altre? La domanda non è banale, perché la casualità delle mutazioni è stata storicamente uno dei pilastri della sintesi moderna. Non solo: uno studio del genere potrebbe riportare in auge una sorta di finalismo nell’evoluzione, di lamarckiana memoria. E il povero Lamarck, grande biologo che fu tra i primi a dare dignità scientifica a tanti gruppi animali fino ai suoi tempi pressoché ignorati, meriterebbe di essere ricordato per ben altro.
Un nuovo studio ha riacceso un dibattito antico quanto la biologia evolutiva: le mutazioni sono davvero eventi casuali? Oppure il genoma possiede una sorta di predisposizione interna a generare alcune mutazioni più di altre?
L’elemento più interessante, e per certi versi destabilizzante, non è soltanto la correlazione tra mutazione e ambiente selettivo, ma il fatto che l’organizzazione del genoma stesso sembri creare canali preferenziali per l’innovazione genetica. Quando i ricercatori citano fenomeni come la “fusione genica”, intendono proprio questo: geni che interagiscono di frequente e che, trovandosi spesso fisicamente vicini all’interno della cromatina (il complesso formato da DNA e proteine che si trova nel nucleo delle cellule eucariotiche), hanno una probabilità maggiore di fondersi. Ne deriva, almeno sulla carta, una visione meno accidentale delle mutazioni, che non sarebbero soltanto il frutto di errori casuali durante la replicazione del DNA, ma anche il risultato di una struttura interna del genoma che orienta, in qualche misura, il tipo di variazioni che possono emergere.
Nonostante la recente pubblicazione, lo studio sembra aver già sollevato l’interesse di più di un sostenitore del disegno intelligente. E non è un caso: è chiaro che una simile interpretazione può essere letta come una sfida alla sintesi moderna. Come accennato in precedenza quest’ultima, nella sua formulazione classica, si basa proprio sull’idea che la variazione genetica sia essenzialmente casuale, mentre la selezione naturale funge da filtro non casuale che amplifica le mutazioni vantaggiose. Ma quella che potrebbe apparire come un’arma in mano ai sostenitori del disegno intelligente, in realtà, non è di certo un’arma e forse nemmeno un proiettile.
Molti ricercatori lavorano già da tempo a un’estensione concettuale della sintesi moderna che non nega la validità della selezione naturale, ma riconosce che l’origine della variazione ereditaria non è riducibile solo a mutazioni casuali.
E infatti, da questo punto di vista, lo studio non rappresenta necessariamente una demolizione della sintesi moderna, quanto piuttosto l’ennesimo tassello che invita ad ampliarla. Del resto, molti ricercatori lavorano già da tempo in direzione di una Extended evolutionary synthesis, un’estensione concettuale che non nega la validità della selezione naturale, ma riconosce che l’origine della variazione ereditaria non è riducibile solo a mutazioni casuali. C’è un’intera costellazione di meccanismi regolativi che condizionano ciò che può variare e in che modo può farlo.
La lettura proposta da alcuni critici, secondo cui scoperte di questo tipo aprirebbero le porte a un ritorno dell’ortogenesi, una teoria evolutiva oggi abbandonata secondo cui l’evoluzione seguirebbe una direzione predeterminata, guidata da una sorta di “forza” o impulso intrinseco alle specie, è però forzata. Non c’è nulla, nei dati disponibili, che implichi un orientamento finalistico dell’evoluzione, né una tendenza intrinseca verso la complessità, né tantomeno una qualche volontà interna dei genomi. Si può parlare, con più prudenza, di mutazioni non del tutto casuali nel senso statistico del termine: distribuzioni non uniformi, predisposizioni legate all’organizzazione cromatinica e alle pressioni ambientali. In altre parole, una complessità maggiore. Discorso ben diverso dalla teleologia, in cui gli eventi accadono in vista di un obiettivo prestabilito. Niente mutazioni che avvengono al fine di contrastare malattie endemiche, insomma.
Anche dai nuovi studi non emerge nulla che lasci pensare a un orientamento finalistico dell’evoluzione, né una tendenza intrinseca verso la complessità, né tantomeno una qualche volontà interna dei genomi.
D’altro canto, è innegabile che il quadro si stia evolvendo verso una visione più complessa della variazione. A partire dagli anni Novanta, con l’emergere di concetti come il natural genetic engineering (termine coniato da James A. Shapiro per indicare i meccanismi attivi di ristrutturazione del materiale genico) o la facilitated variation, un’idea proposta da Marc Kirschner e John Gerhart per spiegare come gli organismi possano produrre nuove varianti evolutive in modo relativamente semplice ed efficiente grazie alla loro architettura biologica, l’idea di un genoma del tutto passivo ha perso credibilità. Gli organismi possiedono sistemi sofisticati per rispondere allo stress, limitare i danni, modificare pattern di espressione, attivare trasposoni o ricombinazioni non casuali. Questo non significa che tali sistemi abbiano un fine evolutivo consapevole, ma che l’evoluzione, nel corso di milioni di anni, ha selezionato organismi capaci di generare variazioni in modi più strutturati rispetto al semplice “errore”.
Si parla sempre più spesso di evolvabilità, la capacità di un sistema biologico come un gene, un organismo o un’intera popolazione, di generare una variazione ereditabile su cui la selezione naturale può agire. L’evolvabilità stessa può essere selezionata: un organismo in grado di produrre variazioni utili (ad esempio grazie a una maggiore plasticità fenotipica) ha un vantaggio in ambienti particolarmente mutevoli. Vedendola sotto questa luce, la direzionalità dell’evoluzione non è un piano preordinato, ma l’effetto emergente di vincoli, strutture interne e pressioni selettive che rendono alcuni percorsi, molto semplicemente, più probabili di altri.
Ragionando in questi termini, si potrebbe pensare alla direzionalità come a una proprietà statistica: non un tragitto obbligato, ma una certa tendenza a muoversi lungo percorsi più agevoli. L’organizzazione del genoma, i pattern di regolazione, la struttura delle reti metaboliche e di sviluppo, la storia evolutiva precedente (ciò che Stephen Jay Gould chiamava contingency) contribuiscono tutti a creare una direzionalità, ma tutto questo non implica un fine, né un progresso. Comporta invece che l’evoluzione non sia un cammino del tutto aperto, bensì un processo che si muove all’interno di un ventaglio di possibilità limitate.
Gli studi sulle mutazioni non casuali ci invitano a riconsiderare i meccanismi interni del genoma: non dei banali replicatori che incappano in errori casuali, bensì un sistema complesso che possiede vincoli, predisposizioni e una storia che ha modellato la sua possibilità stessa di mutare.
Il lavoro su APOL1 non annuncia il ritorno del lamarckismo né un nuovo “slancio vitale”, ma ricorda che l’evoluzione è un processo molto più ricco e dinamico rispetto allo schema che comprende una mutazione casuale unita alla selezione naturale. Ci invita a considerare i meccanismi interni del genoma non come dei banali replicatori che ogni tanto incappano in errori casuali, ma come un sistema complesso che possiede vincoli, predisposizioni e, soprattutto, una lunghissima storia antecedente, che ha modellato la sua possibilità stessa di mutare. Lo studio di Haifa, come ho già detto, non si rivela un’arma contro la sintesi moderna, ma forse nemmeno un proiettile. Anzi, è più probabile il contrario: potrebbe aggiungere un tassello in più in un’architettura sempre più meravigliosamente complessa e che solo in questi decenni si sta rivelando ai nostri occhi.