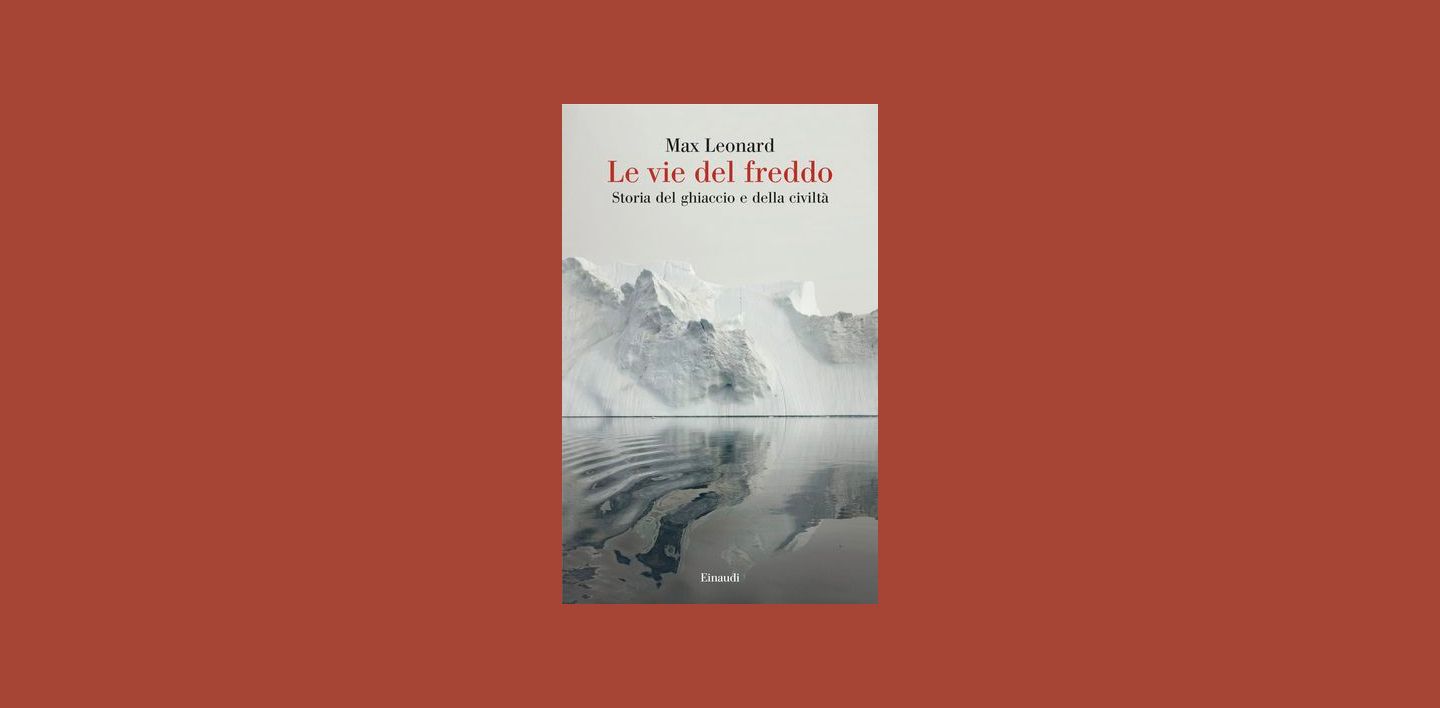S
e volete capire perché le imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina sono un disastro concettuale, prima ancora che ecologico, politico e economico, leggete un libro sul ghiaccio. Leggete, anzi, il libro sul ghiaccio: Le vie del freddo (2025) di Max Leonard, traduzione di Simonetta Frediani. Un saggio che ripercorre la storia di come il ghiaccio abbia intersecato nel profondo l’evoluzione delle civiltà umane, influenzandone forme e direzioni – a dimostrazione di quanto fittizia sia la separazione tra “natura” e “cultura”. Leonard sceglie come proprio oggetto d’analisi una sostanza, o meglio uno stato fisico, che fa della contraddizione la propria caratteristica principale: simbolo di calma e grazia sotto pressione, ma anche di insensibilità e distacco; per millenni in bilico sul crinale medico tra il benefico e il dannoso; se toccato, genera sensazioni di congelamento oppure di bruciore. Dall’ultimo secolo in poi quest’ambiguità irriducibile è stata però, almeno apparentemente, irreggimentata: il ghiaccio è entrato a far parte dell’esperienza quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo e si è arrivati al costoso paradosso del freddo artificiale, quello appunto senza il quale i Giochi olimpici invernali del 2026 non sarebbero stati nemmeno pensabili.
Un saggio che ripercorre la storia di come il ghiaccio, uno stato fisico che fa della contraddizione la propria caratteristica principale, abbia intersecato nel profondo l’evoluzione delle civiltà umane, influenzandone forme e direzioni.
«Le macchine per la neve consumano energia generata altrove e mentre producono neve rilasciano calore. […] Quanto più freddo innaturale produciamo, tanto più freddo naturale distruggiamo e più diventa scarso», scrive Leonard nell’ultimo capitolo, dedicato al ghiaccio nell’Antropocene. La sua è, in effetti, una parabola saggistico-narrativa che descrive una proporzionalità inversa: dai primi passi nella storia del freddo, quando di ghiaccio sulla Terra ce n’era tanto ma se ne sapeva poco, ai giorni d’oggi, in cui da perturbante il ghiaccio è stato reso domestico, con la progressiva diminuzione della sua presenza allo stato naturale, sui ghiacciai e ai poli. Eppure di avvilimento in questo libro se ne respira poco. Piuttosto, Leonard sembra prefiggersi lo scopo di restituire al ghiaccio l’aura di straordinarietà che a lungo lo ha contraddistinto, portando chi legge ad apprezzare la profondità storica e anche filosofica di qualcosa di ormai decisamente ordinario, ma proprio per questo valevole di un’attenzione più sfaccettata.
Ciascun capitolo è dedicato a un diverso gruppo umano i cui destini sono stati plasmati dall’incontro con il ghiaccio in una delle sue tante forme. Si va dai pittori delle caverne, seguendo i quali si ripercorrono gli effetti dell’Era glaciale sulle migrazioni umane e animali della preistoria, ai cosiddetti festaioli, protagonisti del risvolto carnevalesco della Piccola era glaciale del Seicento, fatto di feste popolari e fiere del gelo sul Tamigi, pattinaggio sul ghiaccio e colf (gioco che molti olandesi considerano all’origine del golf). Ci sono i filibustieri del Sedicesimo secolo, alla disperata ricerca di una rotta di navigazione settentrionale per raggiungere l’Asia, convinti dell’esistenza di un “mare polare aperto” al di là di un anello di iceberg. Tantissimi poi gli scienziati che nel tempo hanno contribuito a districare i misteri più disorientanti legati al ghiaccio: la forma dei suoi cristalli; l’andamento dall’alto verso il basso del processo di congelamento (senza il quale la fauna marina si sarebbe estinta a ogni era glaciale); l’espansione nel passaggio allo stato solido; la sospensione sull’acqua liquida. Ma le storie sono anche quelle, mai del tutto ordinarie, dei gelatai e dei birrai che dal ghiaccio hanno estratto piaceri e ritualità ormai ineludibili, degli alpinisti e delle alpiniste che hanno esplorato la Mer de Glace e i ghiacciai più inaccessibili del pianeta, dei soldati combattenti per i confini e sui confini, spesso ghiacciati, dei neonati stati-nazione del Novecento.
Molto di quel che oggi siamo e sappiamo è dovuto al ghiaccio e alle discipline che intorno a questo si sono sviluppate. L’archeologia glaciale ci parla nel dettaglio di culture lontanissime del tempo, i cui resti sono stati preservati alla perfezione dal ghiaccio terrestre – almeno finché il suo scioglimento non ha iniziato a restituirceli a ritmi sempre più serrati. La geologia glaciale è stata in grado, attraverso la messa a sistema di “fossili indice” come quelli dei mammut, di ricostruire una cronologia universale ben più complessa e affascinante delle semplificazioni creazioniste (e negazioniste del clima) a lungo imperanti in Occidente.
Molto di quel che oggi siamo e sappiamo è dovuto al ghiaccio e alle discipline che intorno a questo si sono sviluppate.
Persino l’anatomia medica, al netto di dubbi morali e loschi commerci di cadaveri, è stata resa possibile dal congelamento dei corpi e dal loro sezionamento, molto prima che venissero scoperte la formalina e la plastinazione. Più recente, tra tutte, la branca della criopolitica, definita per la prima volta nel 2006 da Michael Bravo e Gareth Rees come termine ombrello che mette insieme «la sicurezza dell’Artico, la protezione ambientale delle popolazioni indigene, la storia del criosfruttamento, il lavoro scientifico sui ghiacciai, gli interventi governativi sul cambiamento climatico e le questioni culturali».
Questa storia della cultura mondiale sub specie gelus, attraversando ogni epoca e territorio, non manca di toccare anche aspetti problematici. Leonard sottolinea a più riprese il carattere intrinsecamente colonialista e razzista del capitalismo speculativo e di frontiera che ha promosso le spedizioni del ghiaccio – tanto in forma di incursioni territoriali quanto di imprese scientifiche. Molte delle cosiddette scoperte che hanno plasmato la conoscenza del ghiaccio in Occidente fanno parte da sempre della vita quotidiana delle popolazioni dell’Artico, il cui contributo scientifico è stato storicamente minimizzato o cancellato. Più a sud, la produzione del ghiaccio è stata praticata in Persia e in India da migliaia di anni, e spesso con modalità di accesso ben più democratiche di quelle della catena del freddo come espressione tecnica dell’imperialismo britannico. In Cina, poi, le ghiacciaie e i depositi di neve punteggiavano le coste già molto prima dell’industrializzazione della pesca operata dalla Compagnia britannica delle Indie Orientali, e la stessa morfologia esagonale dei cristalli di ghiaccio era nota agli scienziati cinesi sin dal 135 a.C. – solo diciassette secoli prima della “nascita” della cristallografia di Keplero.
Molte delle cosiddette scoperte che hanno plasmato la conoscenza del ghiaccio in Occidente fanno parte da sempre della vita quotidiana delle popolazioni dell’Artico, il cui contributo scientifico è stato storicamente minimizzato o cancellato.
A proposito di colonialismo dei tempi d’oggi, nel capitolo sul ghiaccio e la guerra Leonard rivela dettagli sulla presenza degli Stati Uniti in Groenlandia che meriterebbero le prime pagine dei giornali, a dimostrazione di quanto lo sguardo rapace di
Donald Trump su questo territorio non sia nuovo né peggiore di quello di molti suoi predecessori. Già nel 1946 il governo statunitense cercò di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, vedendosi opporre un rifiuto. La reazione in quel caso fu la creazione da parte degli Stati Uniti del programma SIPRE (
Snow, Ice and Permafrost Research Establishment) su suolo groenlandese, dedicato alla scienza militare applicata alle aree glaciali. L’“applicazione” fu però ben diversa da quella dichiarata:
Il probabile segreto della base di ghiaccio è stato svelato soltanto nel 1996, quando documenti declassificati hanno confermato l’esistenza del Progetto Iceworm.
L’obiettivo del Progetto Iceworm era niente meno che la realizzazione di una rete mobile di siti di lancio di missili nucleari rivolti verso la Russia, distribuiti su un’area tre volte più grande della Danimarca, tutti situati a quasi 9 metri al di sotto della superficie della calotta glaciale della Groenlandia. […] Il governo danese non avrebbe mai approvato ufficialmente un’installazione offensiva statunitense in Groenlandia e aveva vietato la presenza di armi nucleari nei suoi territori e nel suo spazio aereo. Il che, suppongo, è in parte il motivo per cui gli Stati Uniti avevano pianificato di nasconderle tra i ghiacci.
E pensare che proprio i ghiacci, ai tempi dell’ultimo massimo glaciale, univano quel che la storia politica avrebbe poi separato per sempre: attraverso un ponte ghiacciato tra la Siberia e l’Alaska, piccole popolazioni di esseri umani sono arrivate nelle Americhe per la prima volta proprio dalla Russia orientale.
Se le scalate delle donne sono meno note è forse anche per via dell’equilibrio pacato con cui le hanno riportate, senza ricorrere alle iperboli e alle millanterie tipiche di molti racconti maschili.
Leonard non manca di evidenziare nemmeno gli elementi misogini legati all’alpinismo borghese dell’Ottocento, alimentato da una buona dose di vigore ipermascolino e desiderio machista di pericolo, oltre che di avidità territoriale. Nonostante i pregiudizi sociali e gli ostacoli più o meno materiali posti sul loro cammino, di donne alpiniste nella storia ce ne sono però state diverse. E se le loro scalate sono meno note è a causa delle minori opportunità da queste avute di pubblicare i propri resoconti e di essere riconosciute nelle proprie imprese, ma anche forse per via dell’equilibrio pacato con cui le hanno raccontate, scevre delle iperboli e delle millanterie di molti racconti maschili. Descrizioni come quelle di Margaret Jackson, che compì sette prime ascensioni di cime superiori ai 4000 metri, si soffermano poco sull’esperienza individuale della scalata, comunicando piuttosto la meraviglia matericamente spirituale dell’alta quota e un senso di comunione con l’ambiente circostante.
Se è vero che il razionalismo illuminista è riuscito a dare spazio a precisi calcoli barometrici, meteorologici e geodetici allontanando dal ghiaccio le streghe, gli spiriti e i demoni del folklore, è anche necessario riconoscere quanto sia andato perso o frainteso con la tendenza delle scienze a ignorare la meraviglia degli oggetti in esame. In altri termini, è più che mai necessaria una pratica femminista e postcoloniale della scienza (dei ghiacci e non solo), in grado di conciliare rigore dei calcoli e stupore dello sguardo: proprio quello stupore, quel misticismo più o meno laico, di cui sono intrise le pagine di Jackson e che attraversano molto del sapere indigeno. Il rischio insito nel privilegiare la razionalità a totale discapito di una certa spiritualità, e viceversa, è quello di cadere nello scientismo da un lato, nella superstizione dall’altro – due facce opposte della medesima chiusura mentale. Il libro di Leonard, con la sua miriade di dati tecnici tenuti insieme da una prosa cristallina e impreziositi da un ricco apparato fotografico, è lì a dimostrare che l’armonizzazione di scienza e arte, precisione e creatività, ricerca e ispirazione, non è affatto un’impresa impossibile.