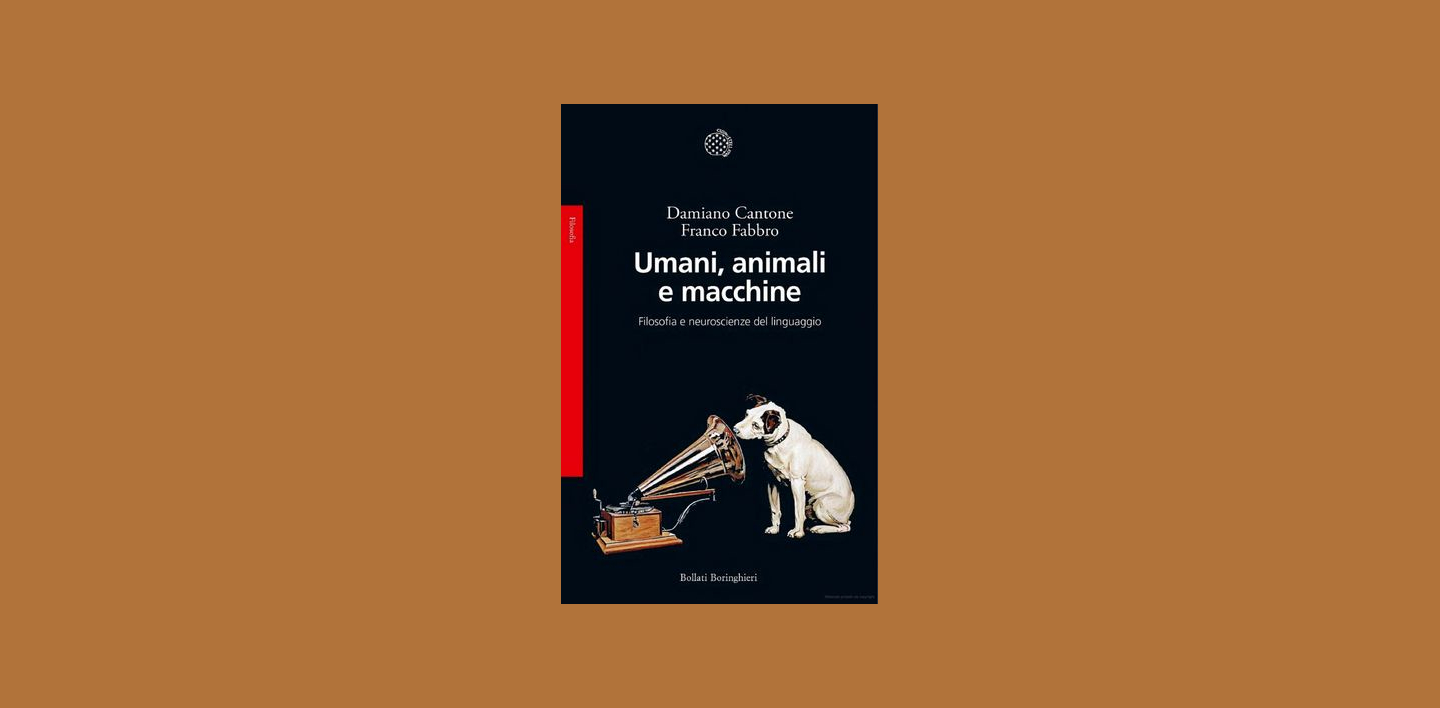
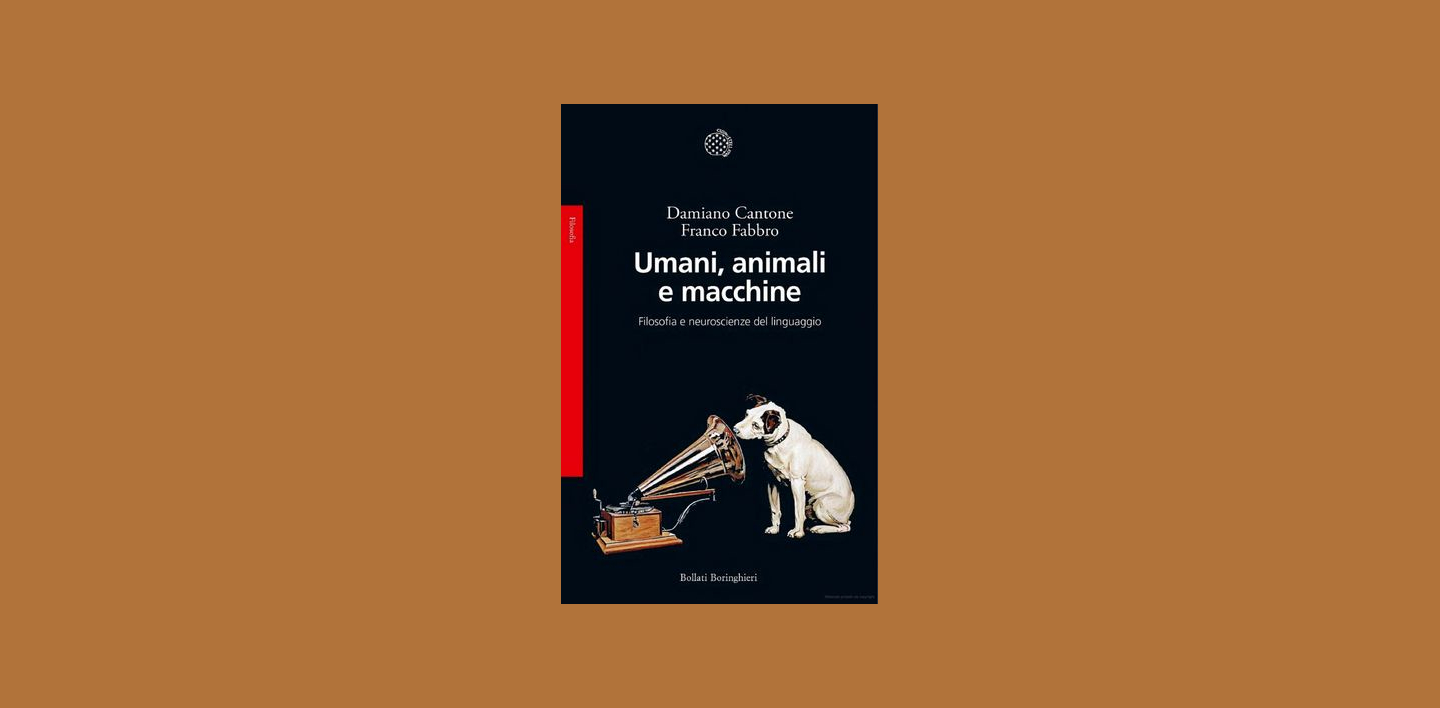
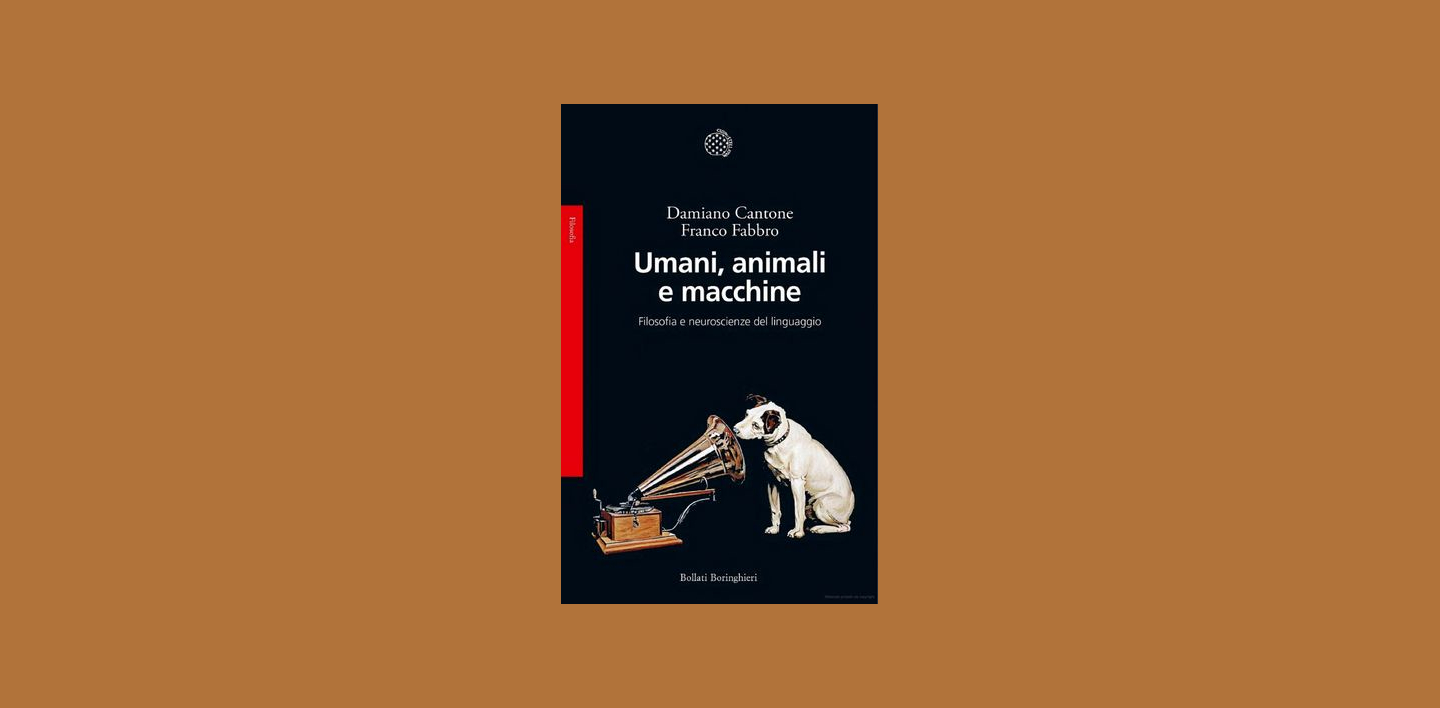
E ra l’anno 1864 e il futuro primo ministro britannico Benjamin Disraeli espose in un suo discorso a Oxford la propria indignazione verso l’opera di Charles Darwin. Trovava sbalorditiva la domanda implicita che la teoria dell’evoluzione imponeva alla società vittoriana: “L’uomo è una scimmia o un angelo? Io, mio signore, io sto dalla parte degli angeli. Ripudio con indignazione e orrore quelle nuove teorie”. Sono trascorsi circa due secoli dal discorso di Disraeli e per tutto questo tempo la nostra specie ha cercato di tracciare una linea netta che ci separasse dagli altri animali, che confermasse la nostra natura “angelica”. Il linguaggio è stato e continua a essere ciò che sembra renderci unici nel regno animale: la nostra capacità di articolare suoni e attribuirvi un significato, di combinare parole in innumerevoli modi per ricordare il passato, descrivere il presente e prefigurare il futuro ci ha permesso di plasmare noi stessi e l’ambiente in cui viviamo. Ma per quanto ancora sarà il nostro segno distintivo, il baluardo del nostro essere umani, se consideriamo che abbiamo insegnato alle intelligenze artificiali a usare il linguaggio naturale per comunicare con noi?
È uno dei dubbi che scaturiscono dalla lettura del libro Umani, animali e macchine. Filosofia e neuroscienze del linguaggio (2025). Gli autori, Damiano Cantone, ricercatore in filosofia e teoria dei linguaggi all’Università di Udine, e Franco Fabbro, professore ordinario di fisiologia, neuropsichiatria infantile e psicologia clinica nella stessa università, riflettono sul linguaggio e sulla sua evoluzione attraverso i tre domini citati nel titolo ‒ esseri umani, animali e macchine ‒ e quattro temi al centro del dibattito su questa abilità: il ruolo delle relazioni sociali nella sua nascita, ciò che unisce l’origine del linguaggio gestuale e di quello vocale, la visione del linguaggio come tecnologia sociale e i suoi meccanismi di apprendimento.
La nostra capacità di combinare parole per ricordare il passato, descrivere il presente e prefigurare il futuro ci ha permesso di plasmare noi stessi e l’ambiente in cui viviamo. Ma per quanto ancora sarà il nostro segno distintivo?
Le parole potrebbero aver sostituito la pulizia reciproca di pelle e mantello (grooming) per consolidare legami e gerarchie in gruppi umani sempre più ampi, con un numero più elevato di relazioni da coltivare, oppure essere state un modo di colmare il divario di esperienze tra individui per rendere più efficace la cooperazione. O ancora, la crescente complessità del linguaggio potrebbe aver dato l’opportunità all’essere umano di diventare il più abile degli ingannatori: sebbene l’inganno esista anche in altre specie animali, negli umani l’uso della menzogna, per un tornaconto spesso personale, avrebbe richiesto il raggiungimento di un livello cognitivo superiore e sarebbe stato un utile allenamento per conquistare il controllo che attualmente mostriamo nell’eloquio.
Il linguaggio umano possiede un grado di complessità che pare non poter essere eguagliato da altre forme di comunicazione animale. È un sistema di simboli arbitrari che gli esseri umani usano per codificare e comunicare la loro esperienza del mondo e degli altri, e possiede caratteristiche specifiche: è composto da un insieme di unità, come suoni o parole; queste parole possono essere combinate secondo delle regole più o meno variabili per comunicare nuove idee; le combinazioni tra queste unità possono veicolare un numero sconfinato di messaggi, che possono riferirsi a eventi passati, presenti, futuri o addirittura immaginari. Questa rappresentazione del linguaggio, che descrive una minima parte degli attributi propri del nostro modo di comunicare, mostra alcune proprietà che abbiamo osservato solo in alcune altre specie e sovente separatamente.
La danza dell’addome delle api non è solo un sistema di comunicazione simbolico: consente di veicolare messaggi riferiti a qualcosa che non è fisicamente presente nel luogo dell’esibizione e riguarda un evento passato.
In Umani, animali e macchine non si parla solo di api, vengono approfonditi gli studi sulle vocalizzazioni dei cetacei e sui canti degli uccelli, con i loro dialetti e le loro culture. Con una prosa chiara e lineare, Catone e Fabbro narrano anche gli esperimenti sull’apprendimento del pappagallo cenerino Alex e quelli dei primati: l’utilizzo di lessigrammi del bonobo Kanzi, le esperienze di Washoe, la scimpanzé, e di Koko, la gorilla, con il linguaggio dei segni sono state sperimentazioni che ‒ sebbene spesso accolte con un certo scetticismo dalla comunità scientifica a causa dei metodi utilizzati ‒ hanno aperto la strada per ulteriori ricerche. A proposito dello studio del linguaggio negli animali non umani, Damiano Catone scrive:
Anziché negare del tutto la presenza di un “linguaggio” nel mondo animale, basandoci sulla definizione del nostro per poi scoprire che quello degli animali non ha le stesse caratteristiche, è diventato più proficuo partire dalla prospettiva dell’esistenza di altri “linguaggi” […]. Questo ha permesso di individuare tratti cognitivi significativi in specie anche molto lontane dalla nostra […] abbandonando l’idea che solo i primati siano capaci di prestazioni mentali paragonabili a quelle umane.
Ritornando alla citazione iniziale di Benjamin Disraeli, se davvero l’essere umano fosse un angelo ‒ o, forse, una scimmia con le ali ‒ oggi si preparerebbe a cederle alle macchine che lui stesso ha creato.
Lo psicologo Steven Pinker non solo aveva appoggiato l’ipotesi della comparsa graduale di un linguaggio forgiato dalla selezione naturale, ma l’aveva anche paragonato alla proboscide degli elefanti: un organo unico nel suo genere, presente solo in questi animali.
è difficile, vedendo una pila di piatti puliti, capire se li ha lavati un essere umano o una lavastoviglie. E in ogni caso nessuno si sognerebbe mai di dire che la lavastoviglie è intelligente, anche se spesso è molto più brava di noi a lavare i piatti in questione. Questo significa che, sebbene i LLM riescano a generare testo coerente e a dialogare con gli esseri umani, non significa che lo facciano esattamente allo stesso modo, né che le conversazioni intrattenute con la macchina siano dello stesso tipo di quelle che possiamo avere con altre persone.
Cantone e Fabbro evidenziano come la tecnica e il linguaggio siano strettamente intrecciati e, anzi, quanto sia probabile che per molto tempo quest’ultimo sia stato la tecnologia più potente di tutte: ha reso efficaci le comunicazioni umane, ha unito e separato popoli, ha dato origine a identità culturali e corpo a leggi e preghiere che hanno determinato la sopravvivenza delle società umane. Il connubio tra sviluppo tecnico umano e linguaggio, però, sembra destinato a dissolversi. Un esempio distopico e ancora lontano dalla realtà è la possibilità di far comunicare direttamente i nostri cervelli: nessun segno, nessun suono, solo stimoli elettrici. Se un giorno questo accadrà, e il linguaggio così come lo conosciamo non permeerà più le nostre esistenze, saremo meno umani? Umani, animali e macchine non fornisce una risposta, ma invita a una riflessione critica che trova terreno fertile nell’intreccio tra biologia, scienze cognitive e filosofia.