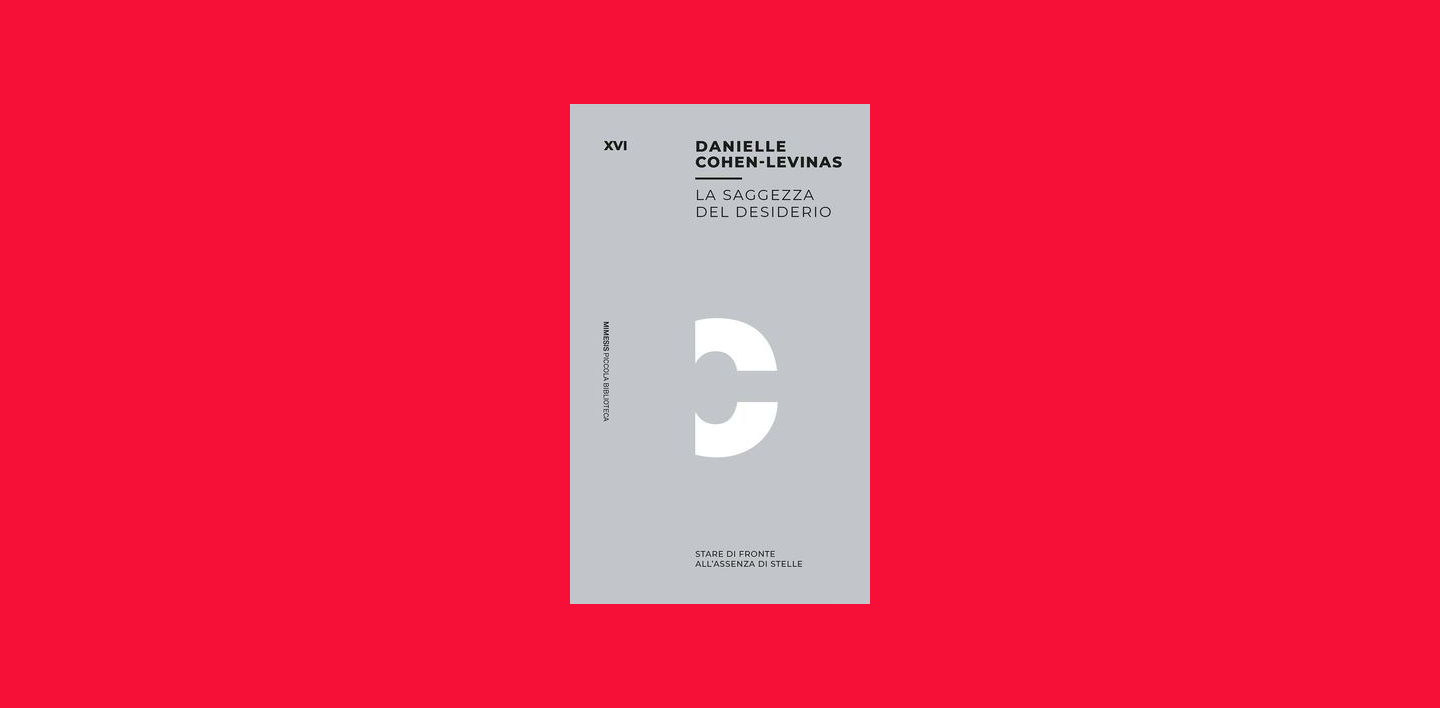
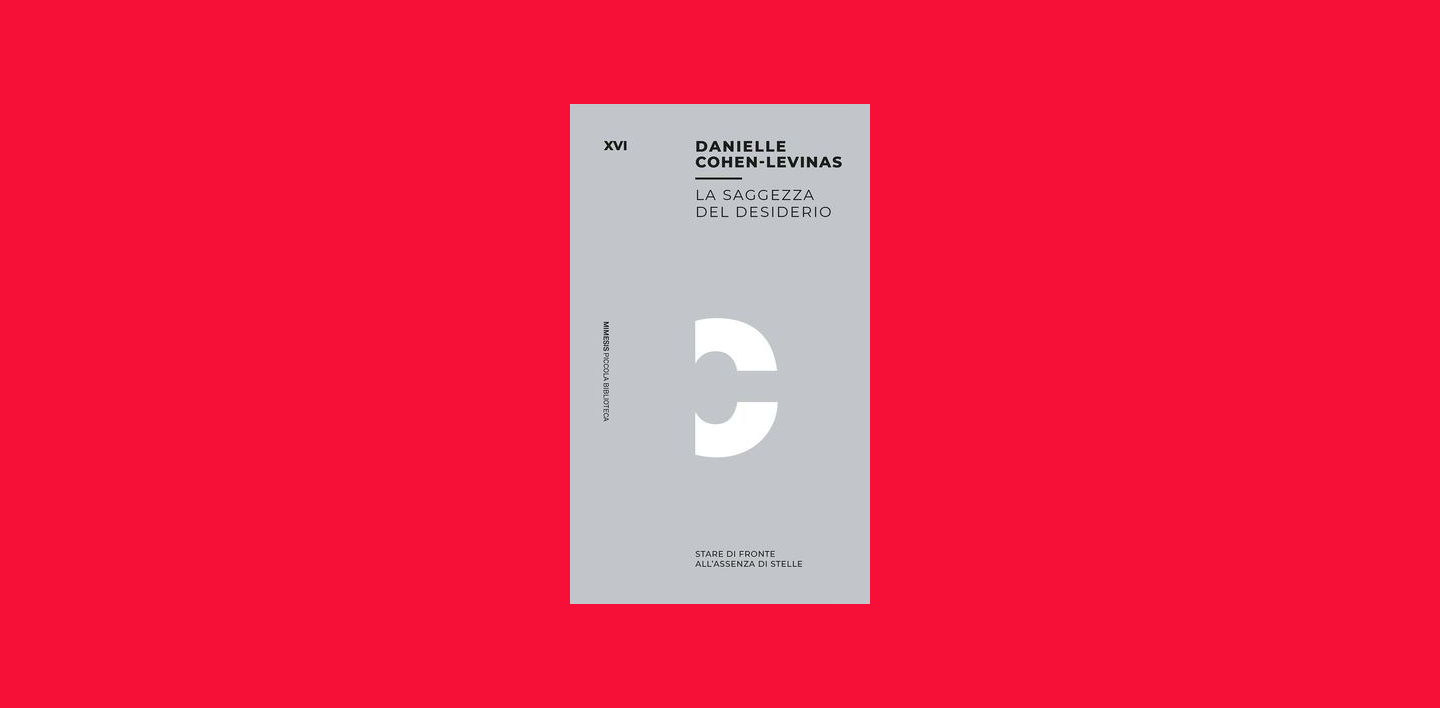
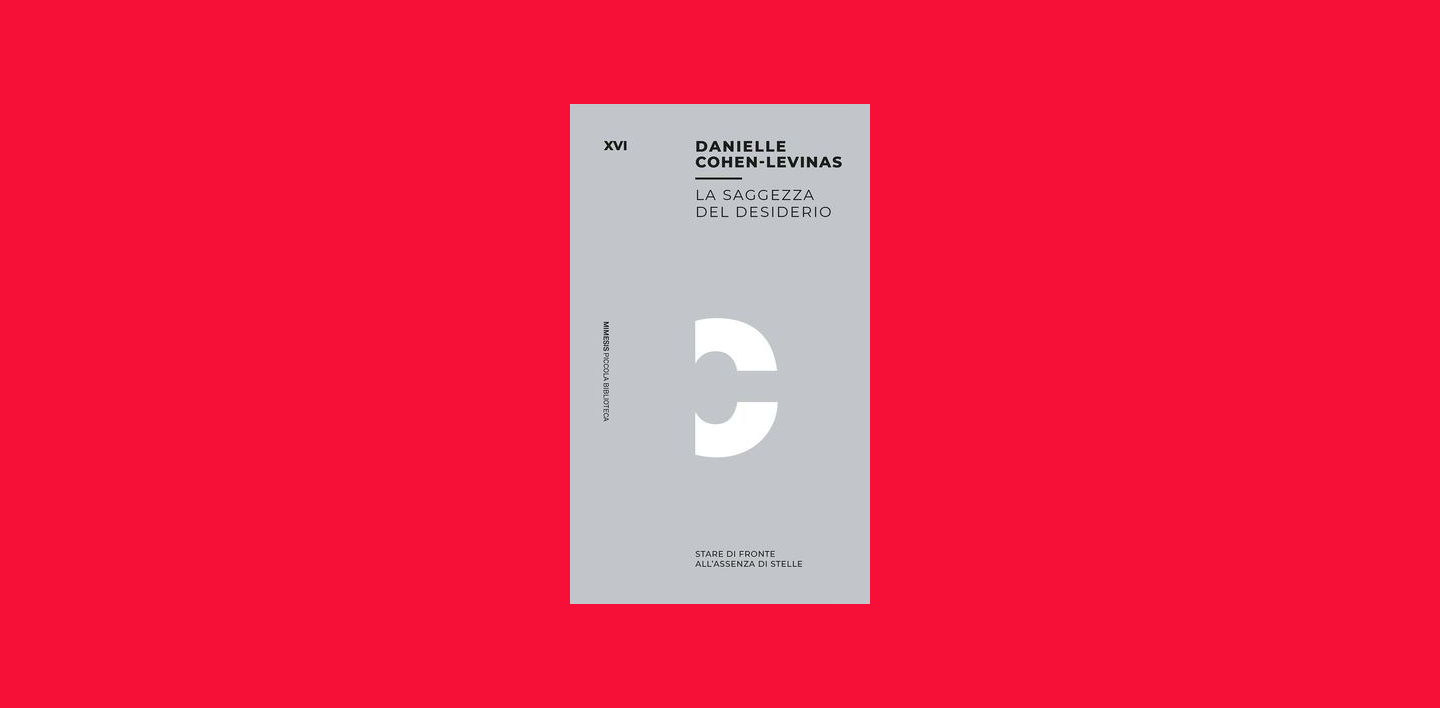
C osa rimane oggi del desiderio? Nel suo saggio La saggezza del desiderio. Stare di fronte all’assenza di stelle – pubblicato a giugno 2025 dalla casa editrice Mimesis – la musicologa e filosofa Danielle Cohen-Levinas, fondatrice del Centre Emmanuel Levinas presso l’Università Sorbona di Parigi, mette a tema, passando dall’Etica Nicomachea di Aristotele ai più recenti saggi del filosofo italiano Giorgio Agamben, una riflessione filosofica rigorosa attorno al problema del desiderio.
Il pensiero del desiderio proposto da Cohen-Levinas, seguendo la traccia lasciata da Platone nel Simposio, prende le mosse dal binomio, solo apparentemente paradossale, saggezza-desiderio annunciato nel titolo. “Perché associare due termini, saggezza e desiderio, che la nostra tradizione filosofica ha piuttosto avuto la tendenza a opporre, o quantomeno a separare?” è l’interrogativo con cui si apre il breve saggio, che è una rielaborazione della lectio magistralis tenuta al festival Filosofi lungo l’Oglio nel luglio 2024.
Si tratta, seguendo Cohen-Levinas, di superare il pensiero del desiderio come qualcosa che rinvia soltanto a “un eccesso, ad una pulsione, anzi ad un’ossessione impossibile da soddisfare o da colmare”: se l’oggetto del desiderio è “per definizione, assente” allora vi è una saggezza propria del desiderare che consiste nel desiderare ciò che non ci appartiene. “Desiderare fa segno ad un movimento di disappropriazione che obbliga […] che consente di rispondere adeguatamente ad una sollecitazione esteriore a sé, a degli effetti venuti d’altrove”: questa saggezza è un tutt’uno con il desiderio, e si tratta di una saggezza pratica che il greco antico, con Aristotele e con Platone, esprime con la parola φρόνησις (phronesis). La φρόνησις, saggezza pratica, consiste in una saggezza etica, che va pensata come apertura e come incontro con l’Altro, nella linea del pensiero di Emmanuel Levinas: il desiderio di quello che non ci appartiene consiste, per l’appunto, in un movimento di spossessamento del sé e di apertura. “Desiderare – scrive Cohen-Levinas – significa spalancare grandi finestre sul mondo, unica possibilità per noi di essere vivi e di rimanere tali”.
L’incontro con l’Altro è dunque il momento fondante dell’etica, che dischiude tale saggezza pratica. Ma perché, torniamo a chiederci, proprio l’incontro? E perché il desiderio?
La nostra soggettività è sinonimo di desiderio; desiderio metafisico dell’altro – questa alterità dell’altro che non possederò mai. Il desiderio di spossessamento – e non di possesso – ci rende capaci di alzare lo sguardo o (di indirizzare) la parola verso l’assenza di stelle, finché l’illuminazione profana o trascendente si palesa.
“Perché associare due termini, saggezza e desiderio, che la nostra tradizione filosofica ha piuttosto avuto la tendenza a opporre, o quantomeno a separare?”.
Desiderare non significa infatti altro che “stare di fronte all’assenza delle stelle”, non perché queste ultime siano scomparse, ma proprio in ragione della incolmabile distanza che da esse ci separa:
Non si tratta di desiderare un cielo vuoto, né di idealizzare la mancanza, l’assenza di trascendenza che peserebbe sulla nostra psiche al punto di paralizzare il desiderio di esporsi a un’esperienza radicalmente altra […]. Questa condizione significa essere in grado di stare di fronte a ciò di cui non possiamo appropriarci.L’immagine di questo desiderio, che è sopportazione dell’assenza, è quella della carezza, particolarmente cara sia al pensiero fenomenologico tout court sia, in particolare, alla riflessione levinassiana. Il simbolo che la carezza dischiude è quello del tocco, momento di avvicinamento tanto quanto della dimostrazione radicale della separazione – rappresentata a propria volta dall’ambivalenza della pelle, che espone e racchiude, permette il tocco e tuttavia proprio nel tocco marca la distanza.
Accontentandosi di non impadronirsi di nulla, di non possedere nulla, la carezza è il luogo di una donazione assoluta, senza ritorno, né reciprocità, né pretesa di ottenere qualcosa in cambio. La carezza non accarezza che ciò di cui non potrebbe mai appropriarsi o avere il controllo […] non è invadente, non comanda nulla, non aspira a nulla, neppure il proprio desiderio di accarezzare rivolto ad altri.Il passaggio attraverso la rilettura del Cantico dei Cantici, l’Inno biblico del desiderio, traducibile dall’ebraico anche come Eccedenza delle eccedenze, Traccia delle tracce, permette ancora una volta, nella parte conclusiva del saggio, di insistere sui caratteri di generosità e di abbondanza del desiderio, e della sua spinta di uscita dal sé. Questo racconto di un “desiderio immemoriale” insiste sull’aspetto carnale (e incarnato) del desiderio, che le pagine dedicate alla carezza avevano anticipato.
Il paradosso dell’alterità viene illuminato grazie alla riflessione sul desiderio, che mette in luce come non sia mai possibile appropriarsi dell’Altro.
Non desiderio di saggezza, dunque, ma la saggezza del desiderio: il tocco di “un oggetto che non si materializza mai completamente, tra fenomeno e non fenomeno, tra carne e corpo, tra pelle e una nudità che può giungere fino all’invisibile”. Il saggio di Cohen-Levinas procede dunque in una direzione che è tesa a mettere in luce l’etica del desiderio e i suoi aspetti incarnati e relazionali – e non è forse un caso che l’ultimo decennio abbia visto un fiorire di statistiche e report che ci descrivono come sempre più soli, sempre più infelici, e con vite erotiche sempre meno soddisfacenti: c’è un nesso forte tra la solitudine e quella che è stata chiamata “recessione sessuale”, che ha a che fare con un isolamento psichico che si trasforma nell’orrore del tocco, della carezza.
Nonostante Cohen-Levinas non indaghi esplicitamente questi aspetti eminentemente sociali, mi sembra che il suo saggio si possa leggere in consonanza con lavori di altre discipline che in qualche maniera lo completano, guardando allo stesso tema a partire da un’altra prospettiva. Uno di questi è il saggio Il declino del desiderio (2022) dello psicoanalista milanese Luigi Zoja. Il “desiderio” del titolo di Zoja potrebbe essere sostituito con “relazione” molto più che con Eros.
Eppure, come mostra Danielle Cohen-Levinas, tra relazione ed Eros c’è una continuità, costituita dalla saggezza annunciata nel titolo: la saggezza etica del desiderio che si svolge a partire dall’accettazione della separazione e della distanza; un secondo elemento di questa saggezza, che il saggio non esplora fino in fondo, è quello del rischio che deriva dall’esposizione del Sé all’Altro: rischio che, come dicevamo, in una contemporaneità nevroticamente ossessionata dal mito dell’autonomia e dell’indipendenza non può che trasformarsi nel terrore di farsi toccare dall’Altro e dal suo sguardo, di vedersi riconosciuti e di riconoscere la propria vulnerabilità.