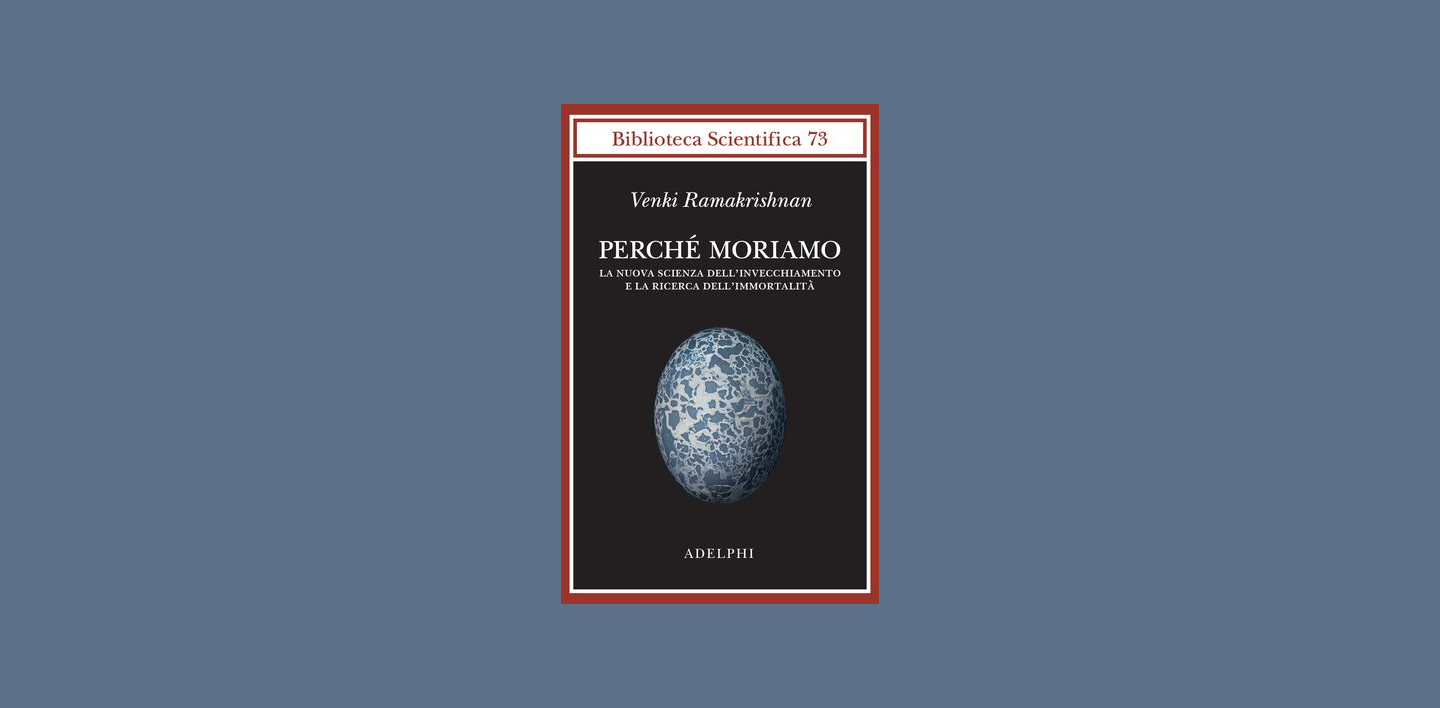
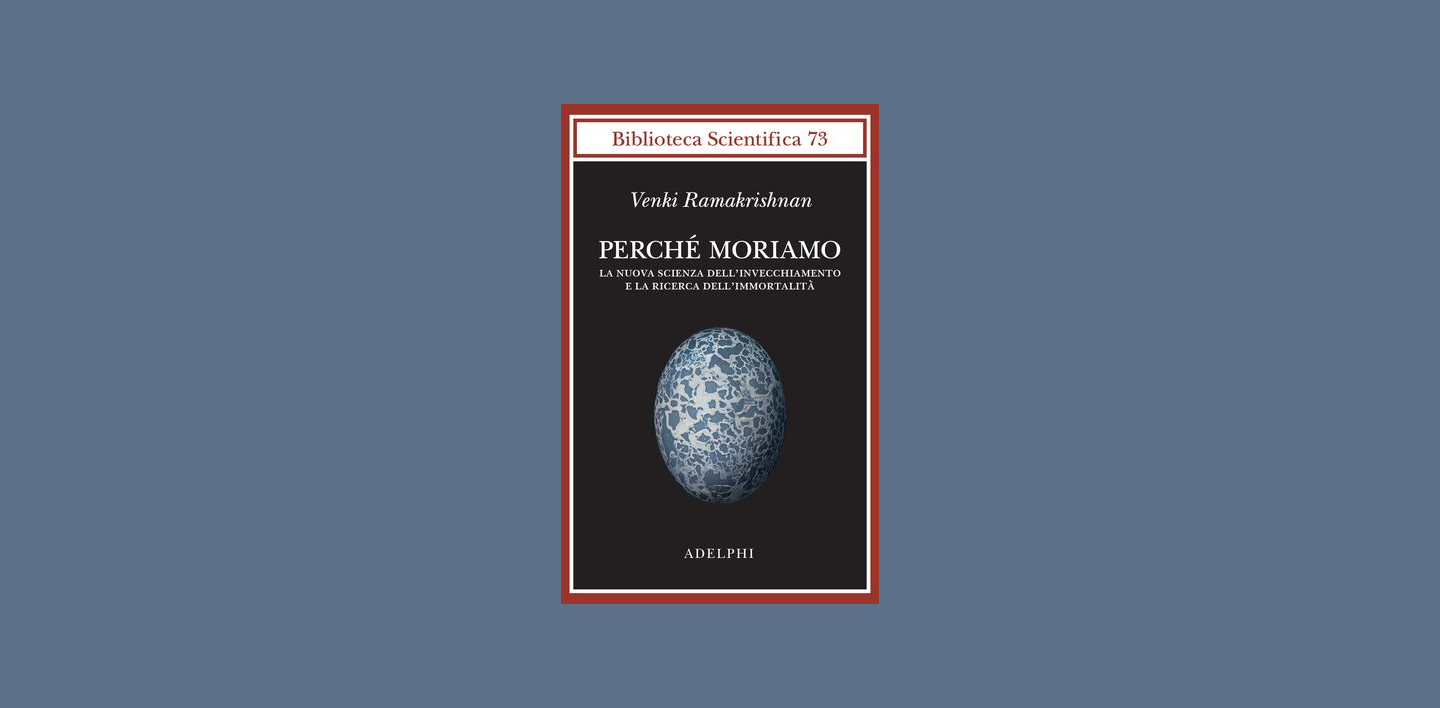
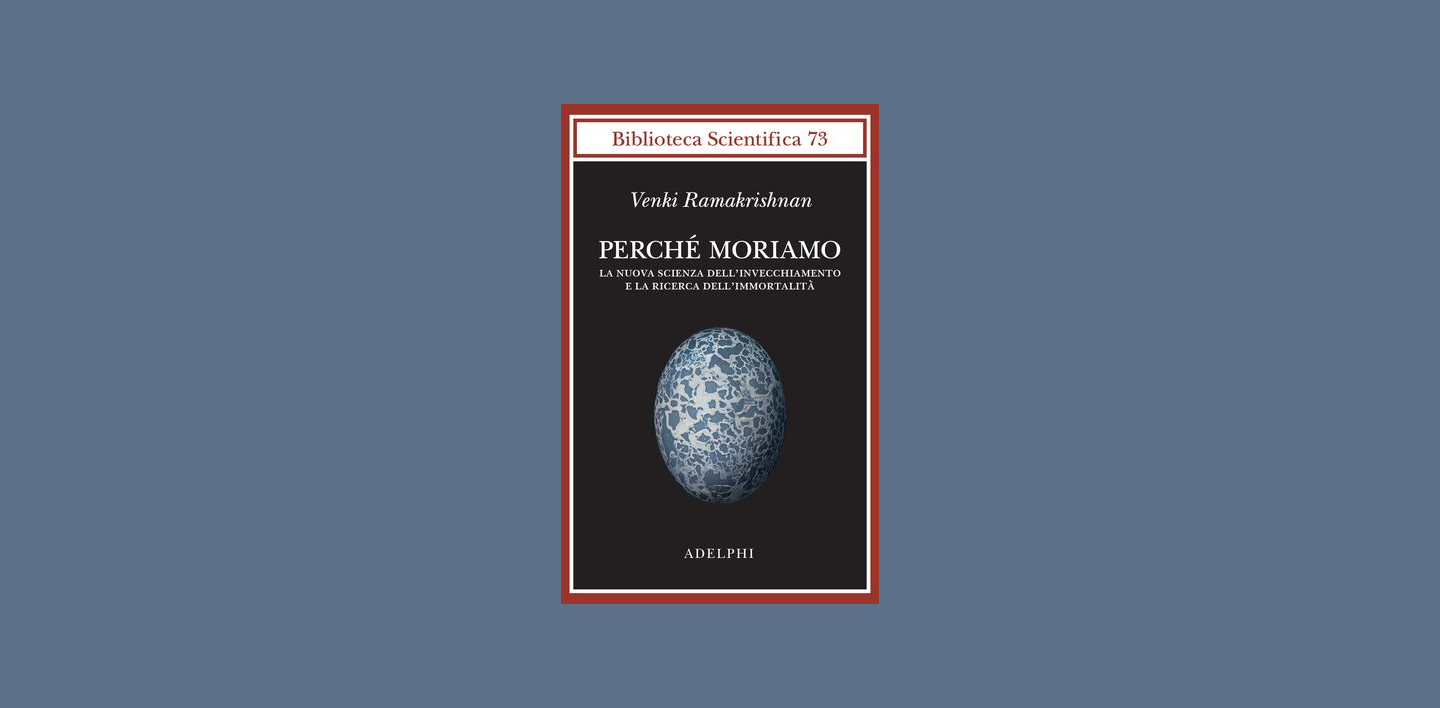
P erché moriamo è la domanda delle domande, l’opposto naturale di un altro quesito altrettanto radicale: perché esistiamo. Moriamo perché siamo vivi, ed è proprio nel cuore della vita che bisogna cercare le ragioni della sua fine. Dietro a questa questione, che tocca il senso dell’esistenza, si apre un’indagine scientifica complessa, che coinvolge biologia, chimica e genetica. Per capire cosa ci uccide, dobbiamo prima comprendere cosa ci tiene in vita. In molti manuali di biologia, la vita umana trova una prima definizione nella cellula, la più piccola unità vivente. Dire che siamo fatti di cellule significa riconoscere che un corpo non è un’entità indivisibile, ma una moltitudine organizzata, un insieme di unità che si replicano, reagiscono, cooperano e, infine, muoiono. Alcune si rinnovano ogni giorno, altre restano intatte per anni; alcune si ribellano e rischiano di diventare pericolose, altre si sacrificano per proteggere l’equilibrio dell’insieme.
A guardarle da vicino, queste cellule somigliano a città: si affidano a centrali energetiche, si muovono lungo strutture interne che ricordano strade, dispongono di magazzini, di barriere di controllo, di segnali chimici che ne regolano traffico e comunicazione. Finché questa rete funziona, siamo vivi. Quando le istruzioni iniziano a confondersi, i segnali a perdere efficacia e le riparazioni a fallire, si avvia un processo lento, spesso impercettibile, che chiamiamo invecchiamento.
È da qui che parte Perché moriamo (2025), il secondo saggio di Venki Ramakrishnan, biologo molecolare e premio Nobel, che dalla metafora della cellula come città propone un’analisi scientifica ampia e dettagliata sull’invecchiamento e sulla morte, intrecciando dati biologici, riflessioni personali e implicazioni sociali.
Dire che siamo fatti di cellule significa riconoscere che un corpo non è un’entità indivisibile, ma una moltitudine organizzata, un insieme di unità che si replicano, reagiscono, cooperano e, infine, muoiono.
L’analogia tra cellula e città, da cui prende avvio Perché moriamo, si estende con discrezione al racconto personale dell’autore. Due città vere, in particolare, emergono nel testo. Londra, dove Venki Ramakrishnan lavora, è descritta come una metropoli pulsante, efficiente, regolata. Un sistema che funziona, apparentemente destinato a durare. Hampi, sito archeologico nel sud dell’India e antica capitale di un impero, è invece una rovina silenziosa, il frammento di una civiltà un tempo potente e oggi cancellata, da cui l’autore contempla la possibilità del crollo di una civiltà, così come di un corpo biologico: “Nel corso della storia tra i più potenti fattori di disgregazione di una società ci sono stati il caos e l’illegalità determinati dalla perdita di controllo del governo. Proprio come nel caso della società, in biologia la perdita di controllo e regolamentazione porta al decadimento e alla morte, non solo della cellula ma dell’intero organismo”.
Nel raccontare cosa significhi invecchiare, Ramakrishnan propone una narrazione che intreccia la biologia molecolare con le storie di chi ha preso parte alla ricerca scientifica sulla senescenza e, in alcuni casi, ha creduto possibile superare i limiti biologici della vita.
Nel raccontare cosa significhi invecchiare, Ramakrishnan propone una narrazione che intreccia la biologia molecolare con le storie dei suoi protagonisti. Ricostruisce esperimenti, rivalità, intuizioni, ma anche ambizioni, fallimenti e velleità di chi ha preso parte alla ricerca scientifica sulla senescenza e, in alcuni casi, ha creduto possibile superare i limiti biologici della vita. Come Alexis Carrel, il medico francese che parlava di immortalità cellulare, e che negli anni Trenta arrivò a elogiare le camere a gas per criminali e malati mentali. O John Craig Venter, figura chiave del sequenziamento del genoma umano, accusato di usare i dati pubblici per fini privati. Nel volume, quest’ultimo rappresenta la nuova frontiera del potere bioeconomico, la scienza dell’invecchiamento come affare per pochi. A differenza di molti testi tecnici, Perché moriamo non teme di esplorare questi snodi etici, né di mostrare i limiti della ricerca quando è guidata da troppa ambizione, interessi personali o visioni ideologiche. Pur riconoscendo i progressi della scienza dell’invecchiamento, Ramakrishnan invita il lettore a interrogarsi su come questi vengono narrati, finanziati e distribuiti.
In tal senso, uno dei filoni più controversi esplorati è quello legato alle trasfusioni come possibile fonte di ringiovanimento. Gli esperimenti di parabiosi, in cui il sangue di un topo giovane sembra migliorare le condizioni di un topo anziano, sollevano non pochi interrogativi. La scienza non ha ancora risposte definitive, ma intanto miliardari si sottopongono a trasfusioni familiari e cliniche private vendono trattamenti non validati, rispetto a cui lo scienziato invita alla prudenza, mettendo in guardia contro la spettacolarizzazione della longevità come nuova promessa per ricchi.
Nessuna persona crioconservata è mai tornata in vita, e molte di queste ipotesi non hanno basi scientifiche solide. Ma la domanda è un’altra: anche se fosse possibile vivere per sempre, sarebbe giusto farlo?
L’analisi si fa ancora più densa quando l’autore passa in rassegna i volti pubblici dell’industria dell’anti-aging contemporanea: Aubrey de Grey, con un passato da informatico e una barba da guru, è diventato celebre per le sue affermazioni estreme: sostiene che l’invecchiamento sia un problema ingegneristico e che l’uomo possa vivere fino a mille anni. Il suo stile provocatorio gli ha garantito visibilità e finanziamenti, così come forti critiche e, in anni recenti, de Grey è stato accusato di molestie da più colleghe, circostanza che ha portato alla sua estromissione dalla fondazione da lui stesso creata. Il secondo e controverso volto legato all’industria dell’anti-aging è David Sinclair, genetista di Harvard, noto per i suoi studi sull’epigenetica. Anche per lui la senescenza è un fenomeno reversibile, e su questo ha costruito una presenza pubblica piuttosto marcata. Parte della comunità scientifica lo ha criticato per i toni eccessivi, a tratti quasi promozionali, ma lui prosegue, investendo e brevettando, convinto che il ringiovanimento cellulare sia una frontiera reale.
Ramakrishnan prende posizione contro questa retorica della longevità illimitata, alimentata da slogan, investimenti privati e aspettative sproporzionate; e mantenendo un tono misurato sottolinea come, al momento, vivere più a lungo non equivalga a vivere meglio. Stando ai dati di ONS (Office for National Statistics) e dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), gli anni vissuti con quattro o più patologie sono infatti aumentati in proporzione alla vita media. Il concetto di compressione della morbilità, ovvero quello di vivere sani il più a lungo possibile per poi morire rapidamente, resta nella maggior parte dei casi un ideale. “Quasi tutti pensiamo che sarebbe vantaggioso aumentare il numero di anni vissuti in buona salute”, scrive, ma è possibile che stiamo facendo il contrario. Viviamo più a lungo, sì, ma spesso più malati. E anche le scoperte più promettenti non hanno ancora prodotto un cambiamento paragonabile a quello che, nel Novecento, ha trasformato radicalmente la speranza di vita.
La maggior parte dell’aumento dell’aspettativa di vita si deve ai miglioramenti nella sanità pubblica piuttosto che a progressi rivoluzionari in medicina. Johnson ha identificato tre fattori chiave in questa trasformazione: le moderne condizioni igieniche e i vaccini, che hanno drasticamente ridotto la diffusione delle malattie infettive, e i fertilizzanti chimici. Altre innovazioni significative sono stati gli antibiotici, le trasfusioni di sangue (cruciali in caso di incidenti e interventi chirurgici) e la sterilizzazione dell’acqua e degli alimenti mediante clorazione e pastorizzazione.
Insieme alla vita media è aumentato anche il numero di anni che viviamo affetti da patologie. Il concetto di compressione della morbilità, ovvero quello di vivere sani il più a lungo possibile per poi morire rapidamente, resta nella maggior parte dei casi un ideale.
Quindi, le ricadute dell’estensione della vita vanno oltre il piano biologico. Una vita media che si prolunga, come osserva l’autore, trasforma tutto il sistema sociale, dalla demografia all’etica del lavoro. In una società sempre più anziana e in cui si fanno figli sempre più tardi, l’unica risposta sostenibile è quella di prolungare gli anni di lavoro. Ma, come si chiede il sociologo Paul Root Wolpe, l’idea di svolgere mansioni fisicamente usuranti a settantacinque o ottant’anni, è davvero una prospettiva accettabile? Già oggi l’aumento dell’età pensionabile produce forti tensioni, e anche laddove la longevità favorisce la produttività, non sempre produce innovazione. Facendo riferimento alla sua esperienza diretta in laboratorio, Ramakrishnan ammette: “Io, per esempio, ho avuto la grande fortuna di poter assumere giovani di talento grazie ai quali il mio laboratorio continua a pubblicare articoli su riviste di alto livello”. Inoltre, pur senza determinare il valore individuale, l’età influenza la posizione nel potere: i vertici politici e finanziari, per esempio, sono sempre più occupati da ultraottantenni, e il rischio, sottolinea lo scienziato, è che le nuove idee vengano soffocate prima ancora di emergere.
Una vita media che si prolunga trasforma tutto il sistema sociale, dalla demografia all’etica del lavoro.
Forse, allora, non viviamo meno di quanto ci serva per vivere bene.