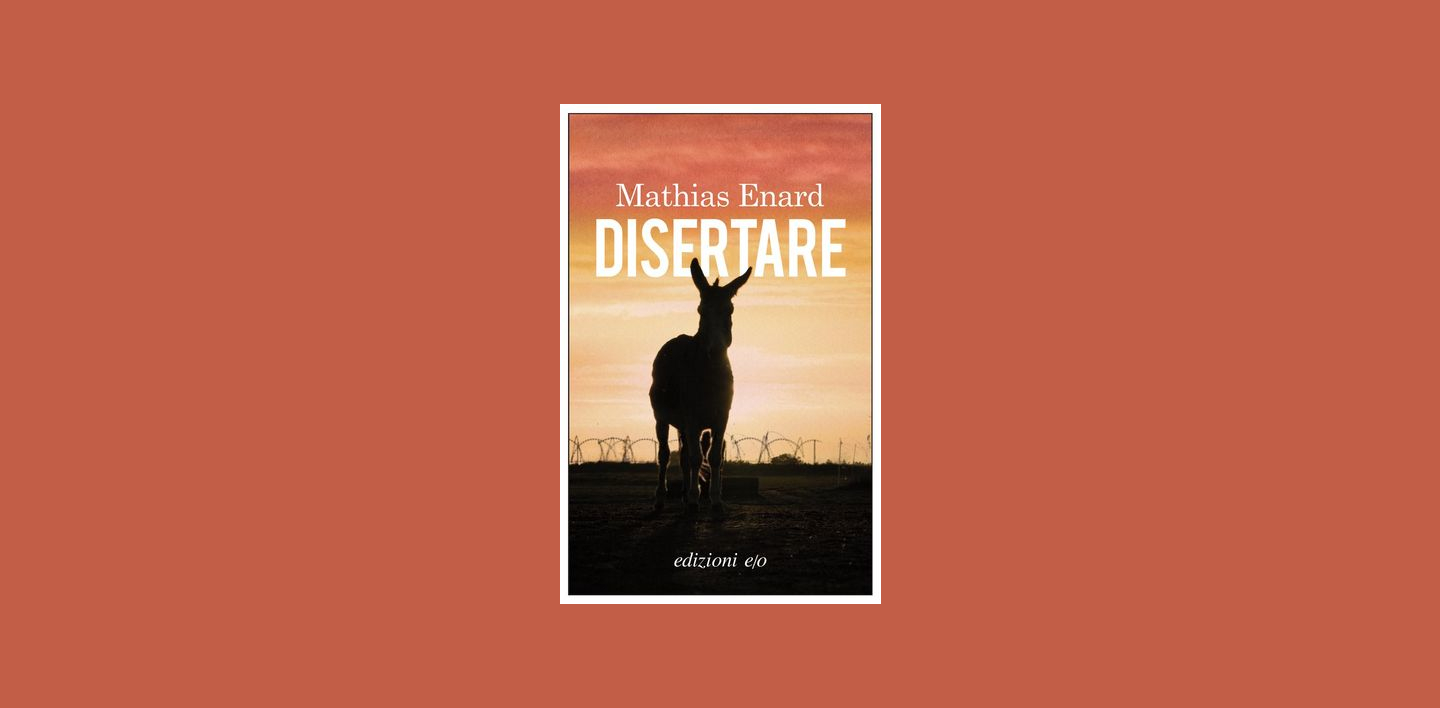
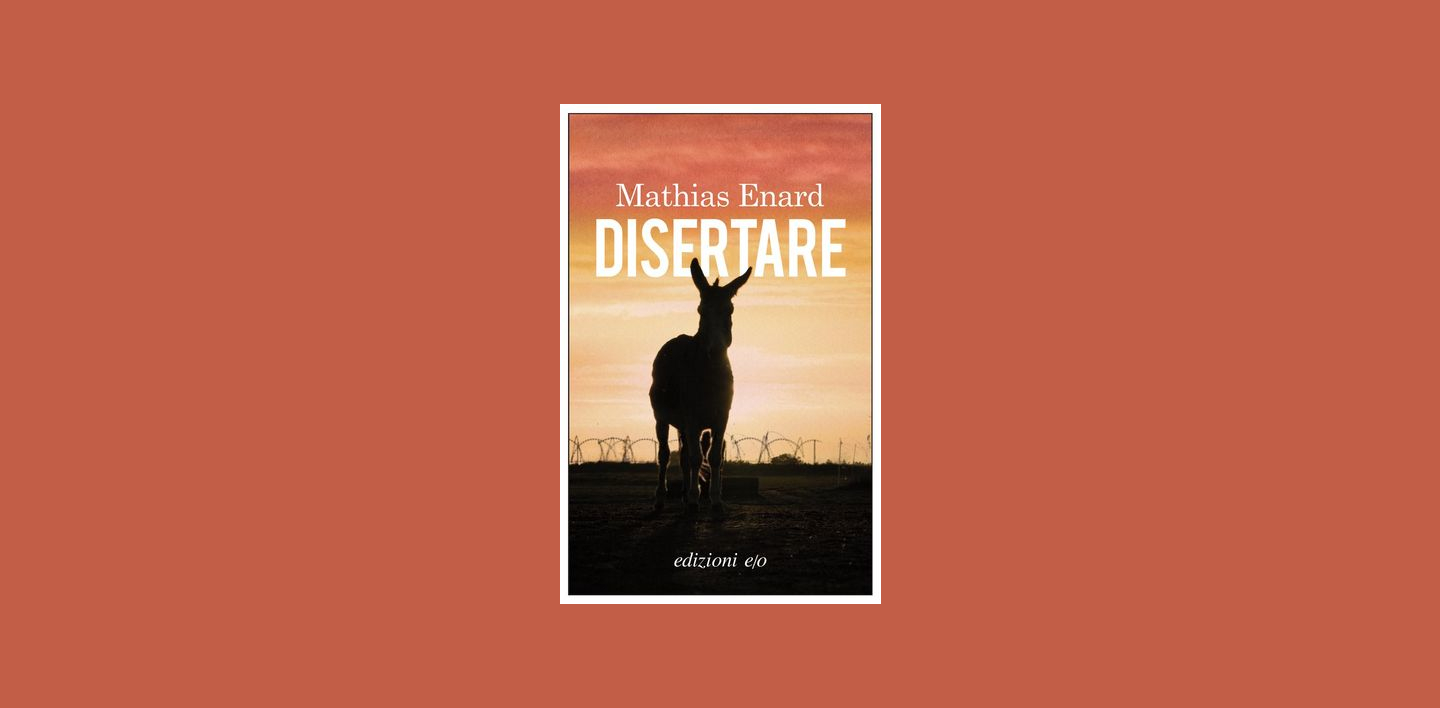
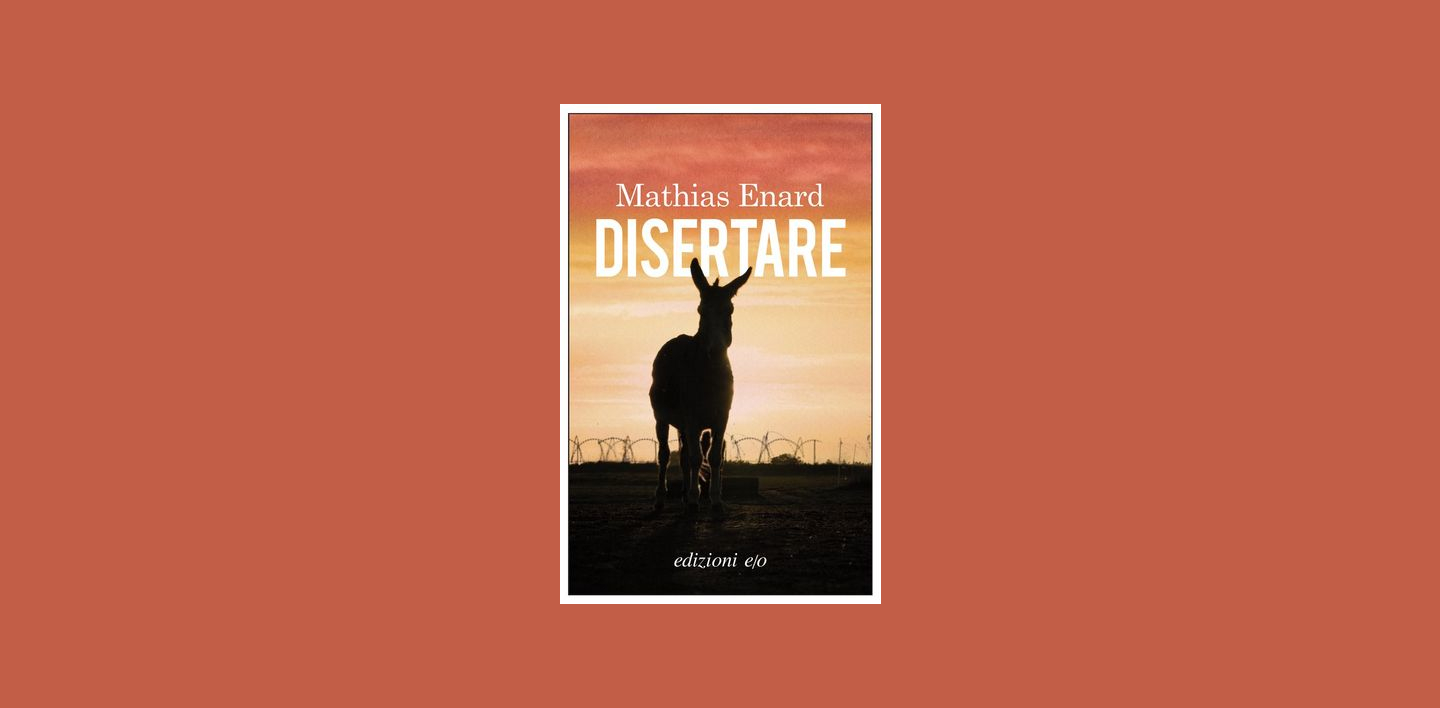
I n una recente intervista Mathias Enard ha detto che molti degli accadimenti di questi ultimi anni a livello internazionale sembrano ricordare o quanto meno riportare tutti noi a un’atmosfera da anni Dieci del Novecento. Le guerre che stanno colpendo l’Europa Orientale con l’aggressione Russa all’Ucraina e la violenta repressione dello Stato d’Israele ai danni del popolo palestinese, oltre che impressionare giorno dopo giorno per la loro gratuita violenza e per la loro spudorata brutalità, obbligano a ripensare in profondità sia lo sguardo sul mondo sia quello su noi stessi e sulla società in cui viviamo, che forse da troppo tempo si è concessa una pausa (insensata quanto irresponsabile) dalla storia.
Credendo in fondo alle assurdità accomodanti e seducenti di Francis Fukuyama, per quanto relativamente presto facilmente sconfessate, l’Occidente ha inseguito la fine della storia come un desiderio mai del tutto esplicitamente dichiarato, ma fortemente voluto a livello quanto meno inconscio. Isolandosi ‒ o quanto meno provandoci ostinatamente ‒ dal tumultuoso movimento del mondo che veniva e che viene dall’Africa come dall’Asia, l’Occidente si trova nel nuovo secolo come un oggetto rotto, un’ideologia desueta incapace di reagire e di percepire pienamente la complessità globale.
Quello occidentale è oggi spazio dai confini labili e dalla coesione ridotta ai minimi termini, ma ancora capace di produrre facili e diffuse illusioni, mentre attorno tuona violentemente una storia che non si è mai fermata e che ora si presenta più di prima in tutta la sua terrificante violenza e la sua cruda realtà. Gli ottanta anni di pace tanto sbandierati in Europa appaiono ora come non solo il frutto di una classe dirigente consapevole di una sconfitta storica e sul campo delle potenze europee, ma anche come l’esito di un equilibrio che vide l’Europa dell’Ovest beneficiare di una pace in virtù di guerre per conto terzi in Paesi altri. Conflitti violentissimi sparsi nel mondo che hanno costellato il pacifico dopoguerra europeo.
Quello occidentale è oggi spazio dai confini labili e dalla coesione ridotta ai minimi termini, ma ancora capace di produrre facili e diffuse illusioni, mentre attorno tuona violentemente una storia che non si è mai fermata e che ora si presenta più di prima in tutta la sua terrificante violenza.
Disertare è costruito da due vicende apparentemente estranee l’una all’altra, ma in realtà connesse anche simbolicamente da elementi che lo scrittore francese di Niort sparge tra le sue pagine con grande godimento per chi vi s’inoltra. Una storia vede protagonista un professore emerito di matematica, il tedesco Paul Heudeber, reduce dal campo di concentramento di Buchenwald e che, rimasto fedele alla sua ideologia comunista, ha deciso di restare a vivere e insegnare per tutta la vita in quella che fu la Germania dell’Est, la DDR. La sua compagna l’amata Maya ha invece superato il confine non sostenendo la disillusione di una società che stava ricalcando un regime e non una possibile liberazione. Maya è divenuta così una collaboratrice di Willy Brandt e un elemento centrale della politica della Germania dell’Ovest. La voce narrante è quella della figlia Irina che racconta il convegno in memoria del padre il cui svolgimento è previsto per l’11 settembre del 2001 a bordo di una piccola nave da crociera ancorata nei dintorni di Berlino. L’idea del convegno su nave è stata proprio di Maya: “Jürgen Thiele era imbarazzatissimo (me l’ha spiegato dopo) perché non voleva rifiutare nulla a mia madre, per quelle giornate di omaggio, ma le sue risorse erano limitate ‒ questa storia di un convegno fluviale continuava a sembrargli assurda, un capriccio da vecchi”.
A questa vicenda si affianca come immersa in un mondo post-apocalittico, la storia di un soldato, un disertore che attraversa una natura selvatica tentando di mettersi in salvo. La narrazione assume il movimento caotico e ansioso di una camera mobile e questa parte del romanzo è fortemente cinematografica e non priva di citazioni. La storia del matematico Paul Heudeber ‒ puntellata dall’epistolario che contiene le sue lettere all’amata Maya ‒ sembra denotare invece una forma quasi classica e un tono pienamente novecentesco, ma è solo un’apparenza, un gioco di prestigio frutto dell’abilità narrativa di Mathias Enard, perché per l’appunto la costruzione narrativa è ricca e complessa così come affascinante.
La parte che riguarda il soldato contiene le tracce di un mondo che è certamente assurdo, ma anche fortemente e seppure in maniera straniante, molto vicino alle cronache di guerra dei nostri giorni. Scritto infatti nei giorni dell’aggressione russa all’Ucraina, Disertare porta su di sé i segni di una cronaca che non può lasciare indifferenti, al punto da prendere corpo e vita nel discorso letterario di Enard, che ne traduce le sensazioni senza alcuna forma minimamente retorica o didascalica. Disertare ha così contemporaneamente il respiro di un romanzo classico e potentemente evocativo così come l’immediatezza di una guida sui nostri tempi e la nostra contemporaneità: “Avevo voglia di scendere dalla nave, di sciogliere le sue enormi cime, di spingere con il piede la prua dell’imbarcazione e di guardarla andare alla deriva, verso Potsdam, poi verso il Brandeburgo, raggiungere l’Elba e scomparire nel mare, come Paul, come una barca funeraria caricata di ricordi perché se li portasse via”.
Disertare ha contemporaneamente il respiro di un romanzo classico e potentemente evocativo così come l’immediatezza di una guida sui nostri tempi e la nostra contemporaneità.
Mathias Enard recupera così una figura simbolica e fortemente emblematica, già rielaborata da Jerzy Skolimowski, quella dell’asino che il regista polacco ridefinisce nel bellissimo e struggente film EO del 2022, recuperandolo a sua volta dall’immaginifico capolavoro Au hasard Balthazar di Robert Bresson del 1966. L’asino giustamente riportato in copertina sia nell’edizione francese che in quella italiana è così alla fine il vero protagonista assoluto del romanzo. Protagonista di quella fuga che non scappa, ma insegue una salvezza e una vita possibile. L’asino sfugge ‒ portando in salvo chi è con lui ‒ la guerra, ricercando una via d’uscita senza però mai ignorare il conflitto in corso e le sue conseguenze.
Un andare via necessario per ritrovare quella via di casa ora smarrita sotto il peso di uno sconfinato dolore e di un’annichilente nostalgia: “Domani o dopodomani arriverò alla frontiera, mi ci porterà l’asino, il cielo è all’improvviso un calderone di nuvole, un cumulo di ovatta: il sole è sparito dietro la montagna, sopra la Roche Noire passano cumuli lattiginosi, una nebbia umida e veloce”.