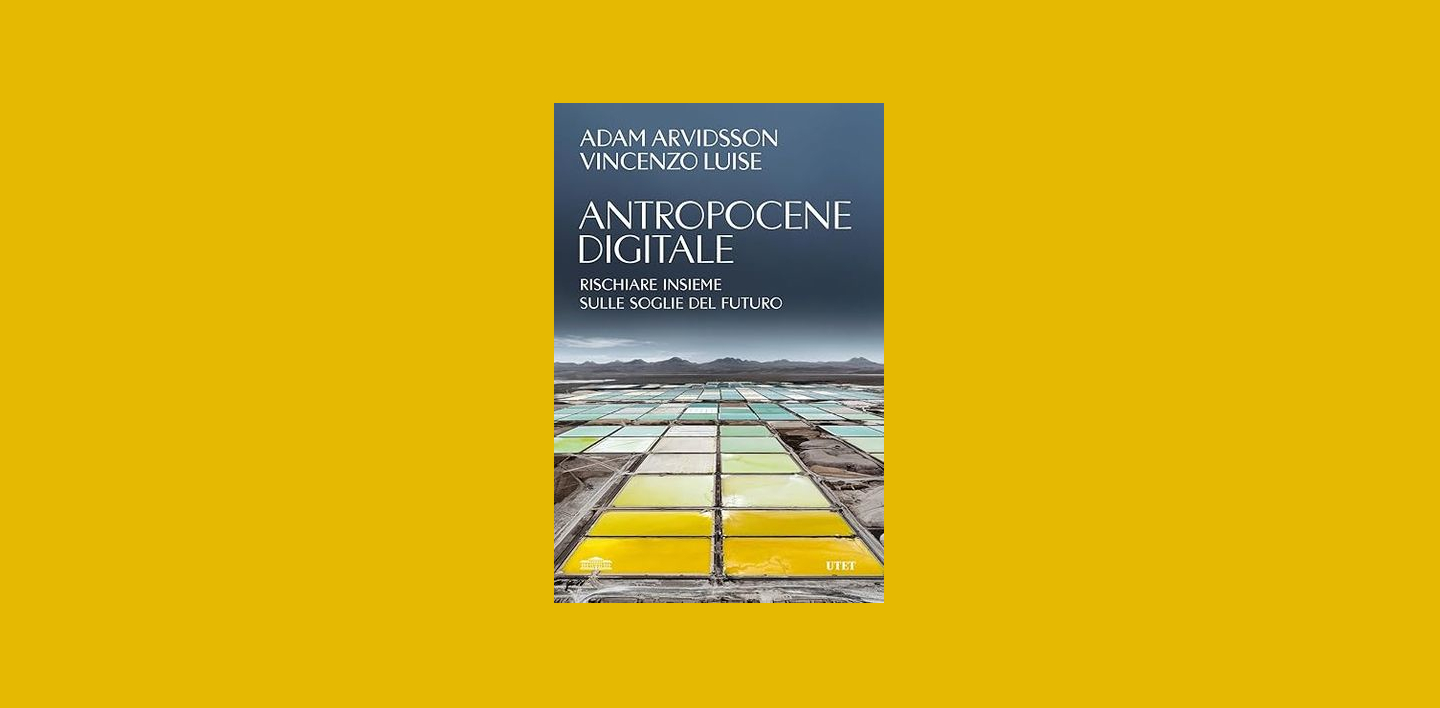T
ra le varie distorsioni cognitive che compromettono il nostro sguardo occidentale sul mondo c’è una tendenza alla compartimentalizzazione dei saperi e delle problematiche che spesso finisce per nascondere la reale portata di una crisi. Joseph Henrich l’aveva raccontato bene nel suo WEIRD (2022): di fronte a un segnale d’allarme, si tratti della crisi climatica, della trasformazione digitale o di una pandemia globale, la nostra prima tendenza è quella di trattare il problema come se fosse circoscrivibile e isolato dal contesto. Solo in un secondo momento ci preoccupiamo di individuare le interconnessioni che collegano questi fenomeni tra loro; ma spesso a questa fase nemmeno ci arriviamo.
In questi anni stiamo attraversando un’emergenza ecologica, una rielaborazione di un trauma pandemico globale e uno stato avanzato di digitalizzazione delle transazioni economiche e sociali, territori che vengono spesso raccontati come lontani e poco sovrapponibili, condizioni che per puro caso si sono trovate all’interno della stessa cornice congiunturale.
In Antropocene digitale (2025), Adam Arvidsson e Vincenzo Luise provano a rendere visibili queste interconnessioni, e lo fanno partendo proprio dalla presa d’atto di una distorsione cognitiva, quella di un capitalismo estrattivista che continua ad alimentare il mito di una crescita sostenibile esternalizzandone i costi su soggetti (umani e non umani) che spesso non si trovano nella condizione di reagire. In tempi in cui chi si oppone al capitalismo fossile viene accusato di perseguire una non ben specificata “ideologia ecologista”, Arvidsson e Luise specificano fin da subito che il miraggio di un estrattivismo sostenibile, così come la progressiva individualizzazione e digitalizzazione di ogni aspetto del nostro stare in società, è tenuto in vita da un’ideologia ben più pericolosa, un’ideologia che parte dal presupposto che possa e debba esistere una separazione tra essere umano e natura.
Il risultato è che, per quanto la maggior parte delle persone sia in grado di riconoscere le iniquità e le ingiustizie che caratterizzano questa congiuntura storica, molti vivono nella rassegnata convinzione che non ci siano alternative davvero esplorabili: “Un’ideologia è qualcosa di molto simile a un’idea fissa. Una modalità di pensiero radicata che riflette alcuni aspetti della realtà ma ne nasconde altri. Un’ideologia è ‘una verità che nasconde la verità’, ha scritto Umberto Eco. Di solito, lo fa nell’interesse di attori potenti”.
In questo contesto, la pandemia ha rappresentato una sospensione di questo incantesimo, uno squarcio nel velo su cui abbiamo imparato così bene a dipingere una realtà immutabile: da un momento all’altro ci siamo trovati a prendere atto, in modo diretto o indiretto, che la “normalità” su cui abbiamo edificato un intero modo di vivere non era affatto scontata, che il futuro probabilmente assomiglierà sempre di meno al presente, e che molte delle dinamiche che davamo per acquisite potevano essere messe in pausa, se non totalmente rovesciate.
Durante la pandemia ci siamo trovati a prendere atto che la “normalità” su cui abbiamo edificato un intero modo di vivere non era affatto scontata e che molte delle dinamiche che davamo per acquisite potevano essere messe in pausa, se non totalmente rovesciate.
Poteva essere un punto di svolta, e in molti all’epoca non hanno indugiato ad annunciare l’avvio di un cambio di paradigma, che avrebbe approfittato della plateale inadeguatezza del modello capitalistico fossile per favorire una transizione ormai considerata inevitabile. Ma come già era successo ai tempi dell’influenza spagnola, anche questa volta i sogni covati durante il lockdown sono evaporati in una rincorsa verso una nuova normalità. Una volta rientrata l’emergenza sanitaria, i due anni di pandemia sono diventati una parentesi da rimuovere il prima possibile dalla coscienza collettiva, ma non senza prima averla sfruttata per spostare ancora di più il baricentro delle nostre vite verso un’individualizzazione digitalizzata.
La diffusione di app e soluzioni digitali per affrontare problemi in ogni ambito della vita, e il nostro utilizzo di esse per operazioni quotidiane come la gestione bancaria, l’acquisto del pane o la prenotazione dei viaggi, rinforza la convinzione che le tecnologie digitali possano risolvere i problemi più vari. […] Vivere con il digitale non ci promette più qualcosa di nuovo e radicale, ma piuttosto un perpetuo “di più”: restiamo bloccati in un presente che sembriamo incapaci di cambiare.
Nella lettura di Arvidsson e Luise, la pandemia è stata un’occasione perfetta per chi aveva interesse a puntellare il sistema estrattivo che già prima della pandemia aveva mostrato segni di cedimento. D’un tratto era possibile rendere ancora più pervasiva una “ideologia digitale sempre più mirata e adattata ai nostri bisogni e desideri […], diventati sempre più dipendenti dalle stesse tecnostrutture che dovrebbero soddisfarli”.
Una volta rientrata l’emergenza, la pandemia è diventata una parentesi da rimuovere il prima possibile dalla coscienza collettiva, ma non senza prima averla sfruttata per spostare ancora di più il baricentro delle nostre vite verso un’individualizzazione digitalizzata.
Per rendersene conto è sufficiente dare una scorsa ai
dati sulla quantità di tempo che passiamo online (in media 6,40 ore al giorno, una cifra in costante aumento negli ultimi 20 anni) e la fetta di tempo libero che dedichiamo agli schermi (ormai più del 60%). Com’è intuibile, questo processo è stato affiancato da una riduzione costante delle interazioni nel mondo reale, e da una conseguente riduzione della capacità delle persone di percepirsi come parte di una comunità. Siamo connessi come mai prima, ma si tratta di connessioni virtuali e, appunto, circoscrivibili, a cui ci si può prestare e sottrarre nel giro di un click. Per certi versi, ci rapportiamo più con le app, che con gli utenti che le utilizzano, questo ha reso particolarmente semplice creare un ambiente digitale in cui le persone si sentano “a casa”, e in cui ognuno ha la possibilità di coltivare e rafforzare la verità che più si adatta alle proprie esigenze: “Si è verificata una vera e propria frammentazione dei tipi di fiducia che possano fondare la credenza in una realtà comune, mentre è avvenuta anche una relativizzazione della realtà, con le persone che tendono a riporre maggiore fiducia nei loro coetanei e nella loro interpretazione di ciò che sta accadendo”.
In quest’ottica, le teorie cospirazioniste non nascono tanto da una mancanza di informazioni corrette, quanto da una eccessiva quantità di informazioni, un sovraccarico cognitivo che, in assenza di una narrazione unificatrice, finisce per creare bolle di verità alternative che riescono a farsi più robuste proprio in forza della loro lontananza dalle verità ufficiali (in primo luogo quelle fornite dalla scienza).
Per certi versi, ci rapportiamo più con le app, che con gli utenti che le utilizzano, questo ha reso particolarmente semplice creare un ambiente digitale in cui le persone si sentano “a casa”, e in cui ognuno ha la possibilità di coltivare e rafforzare la verità che più si adatta alle proprie esigenze.
Non è difficile comprendere quanto questo processo faccia gioco a chi ha interesse a minimizzare la crisi climatica o a strumentalizzarne i tentativi di affrontarla. Da ormai decenni gli scienziati di tutto il mondo insistono compatti nel certificare le cause, il decorso e le prospettive della crisi climatica, indicando come chiare responsabili quelle aziende e quelle nazioni che dal secolo scorso a oggi hanno tratto profitto dall’estrazione, trasporto e vendita di combustibili fossili. Chi conosce un minimo il mondo scientifico sa che è raro trovare una simile convergenza. Ma paradossalmente il fatto che ci sia un fronte così compatto, per chi si è arredato la bolla con una verità alternativa, è prova del tentativo di confezionare una “realtà ufficiale” che consenta di imporre un’agenda politica “green”.
Che fare, dunque? Arvidsson e Luise sono i primi a individuare nella frammentazione digitale della sfera pubblica un ostacolo all’azione climatica, ma sono anche i primi a riconoscere una varietà di nuove tendenze e movimenti che si muovono in direzione opposta, spesso puntando a una riappropriazione a una “depiattaformizzazione” delle tecnologie digitali (è il caso ad esempio dell’agroecologia), e prefigurando una sottrazione del progresso tecnologico al dominio della crescita per metterlo al servizio della ricerca di quello che Adam Smith definiva “equilibrio naturale”.
Chi oggi vive in condizioni di povertà relativa e assoluta, è spaventato tanto dalla crisi climatica quanto da una transizione iniqua che rischia di tradursi in una riformulazione in chiave verde del capitalismo, e in un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di vita.
Un simile cambio di paradigma dovrà necessariamente passare dal tracciamento di ponti che sopperiscano all’attuale frammentazione delle pratiche e dei movimenti, ma prima ancora richiederà l’emergere di una narrazione collettiva che possa risultare sia inclusiva che allettante, in particolare per quella parte sempre più ampia di popolazione che oggi versa in condizioni di povertà e marginalità. Persone che oggi, comprensibilmente, sono spaventate tanto dalla crisi climatica quanto da una transizione iniqua che rischia di tradursi in una riformulazione in chiave verde del capitalismo, e in un ulteriore peggioramento delle loro condizioni di vita.
In un mondo che si avvia a essere sempre più esposto ai rischi, un primo passo, secondo gli autori, è de-individualizzare il concetto di rischio:
Dobbiamo pensare a nuovi modi di socializzare il rischio, basati sull’esperienza concreta delle condizioni materiali, e aprirci alla possibilità che i livelli accettabili di rischio emergano da interessi contrastanti, ciascuno riconosciuto come legittimo. […] Dovrebbe anche riuscire a trasformare il rischio da principio apolitico in qualcosa attorno a cui le persone possano unirsi in lotte collettive e solidarietà.
Quando parlano di “rischiare insieme”, Arvidsson e Luise non si riferiscono solo all’antroposfera, e dunque agli esseri umani, l’ambizione è piuttosto quella di fare rientrare nell’equazione tutti i viventi, non solo per ragioni di principio, ma per una questione molto pratica: l’illusione di poter separare l’essere umano dall’ambiente in cui vive non ha portato solo alla degradazione degli ecosistemi, ma anche all’occultamento di tutte le interconnessioni che rendono quegli ecosistemi vivi e funzionali.
In un mondo davvero compartimentalizzato non avremmo potuto prosperare. In un mondo artificialmente compartimentalizzato rischiamo di non sopravvivere.