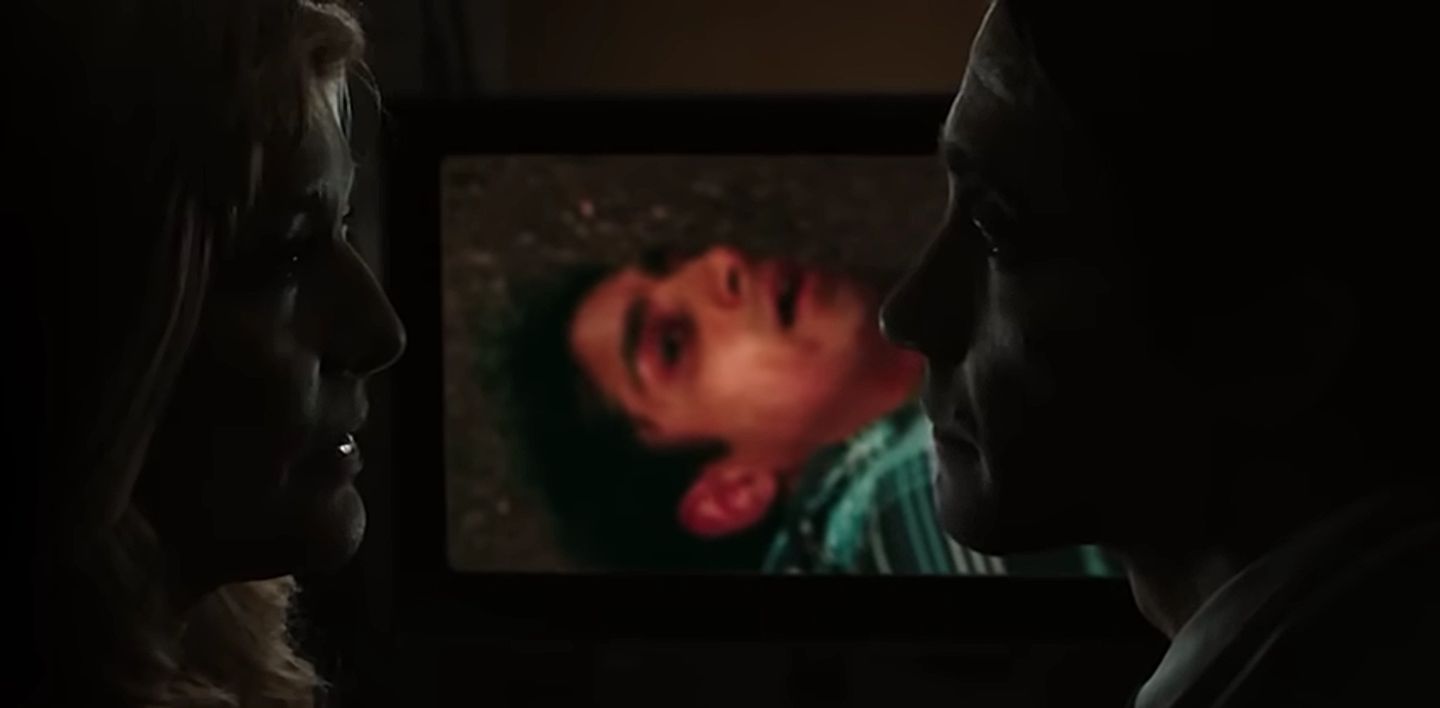
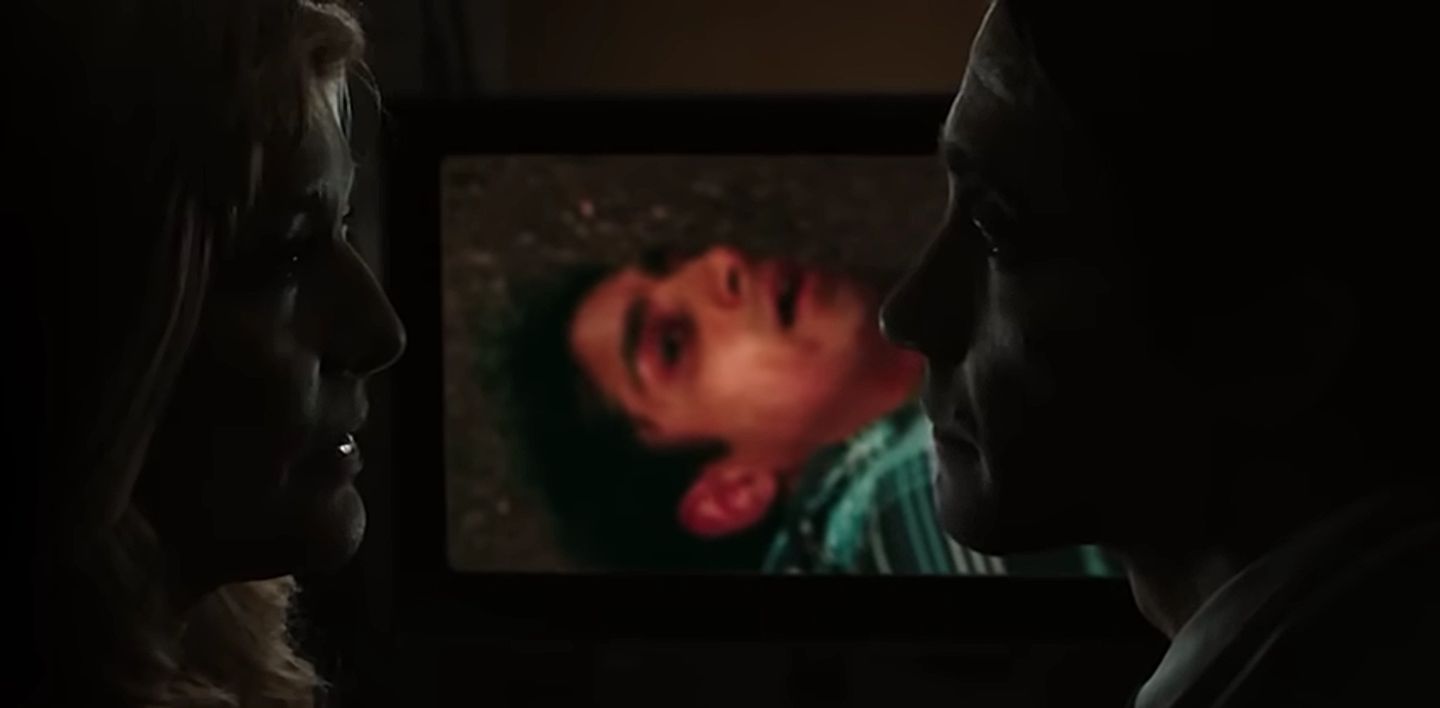
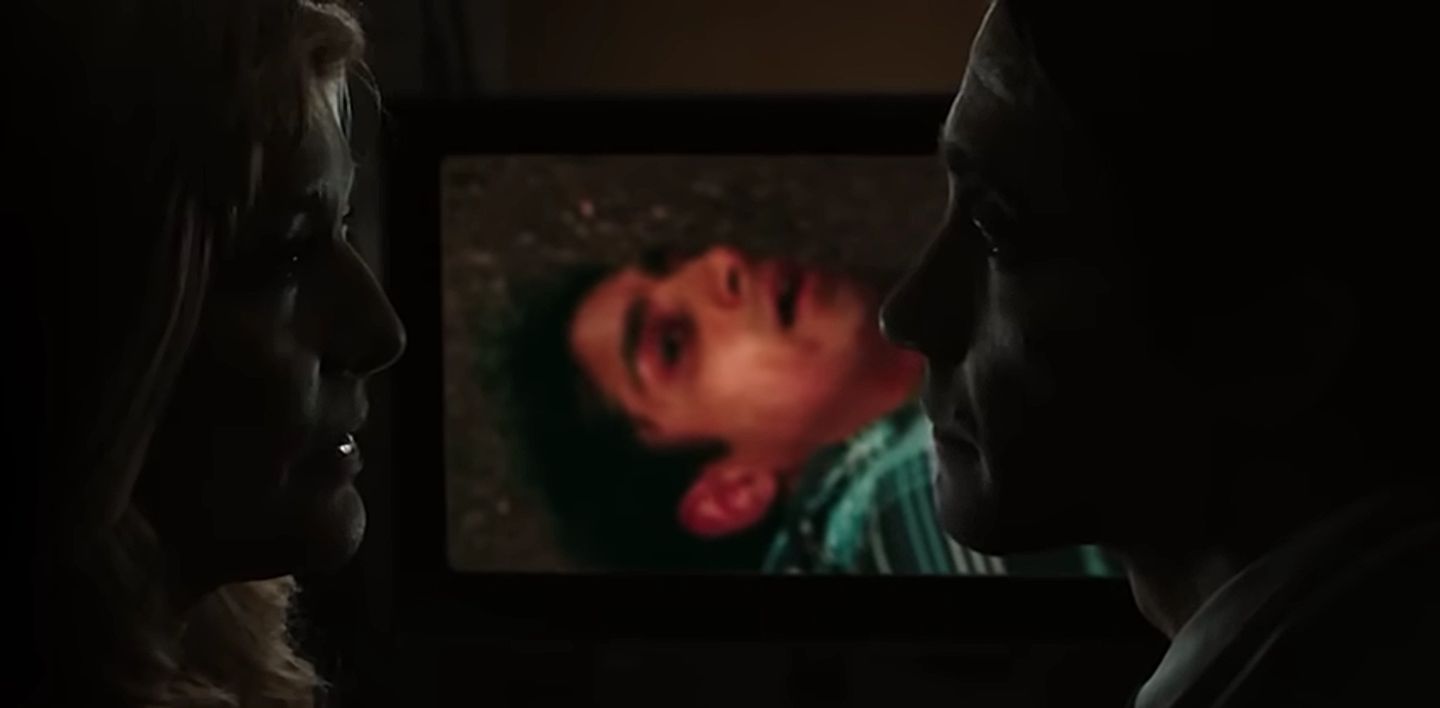
I mmagina un domani molto vicino: ogni casa equipaggiata con sorveglianza audio‑video h24, di proprietà delle forze dell’ordine. Nessuna spina da staccare, nessun interruttore d’emergenza: una scatola nera domestica che si apre solo quando c’è un’ipotesi di reato. Ora immagina le prime crepe nel sistema. Hacker dall’etica elastica e whistleblower in cerca di gloria iniziano a far filtrare quel girato. Video HD, nitidi come un incubo, che immortalano i crimini più feroci. Non più true crime narrato, ma crime reale ‒ live, in presa diretta, senza anestesia.
Un passo oltre: i network generalisti fiutano l’odore del sangue e strappano la preda al dark web. Palinsesti hard‑core, prime serate dedicate a omicidi veri e stragi familiari. Il paradosso? A spingere la diffusione non sono i carnefici, ma le stesse forze dell’ordine ‒ ansiose di mostrare efficienza ‒ e i parenti delle vittime, convinti che la memoria vada nutrita di share.
E non serve nemmeno spingersi tanto avanti con l’immaginazione: la montagna di atti giudiziari già oggi è un buffet perfetto per le prossime generazioni di LLM (Large Language Model) capaci di generare, in tempo reale, ricostruzioni video iper‑realistiche dei casi di nera più celebri. Il mostro di Firenze, il massacro del Circeo, la Uno bianca, la strage di Erba, Cogne, Avetrana, Yara Gambirasio, le Bestie di Satana ‒ una Via crucis secolare in cui la morbosità sostituisce la devozione. Le coltellate diventano grani di un rosario laico, e ogni nuovo modello linguistico promette di farci rivivere, in 8K e Dolby surround, l’ossessione che i vecchi martirologi cristiani sapevano evocare solo con la parola scritta.
Ora smetti di immaginare. Perché quel futuro, in una certa forma, è già accaduto. Non serve la scatola nera governativa per assistere all’irruzione della violenza nella sfera pubblica: basta tornare alla sala di un tribunale, anno 2007, Angelo Izzo davanti ai giudici. Un mostro conclamato, condannato per il massacro del Circeo, accusato di nuovi omicidi. Seduto davanti alla corte, Izzo racconta senza scomporsi come ha ucciso due donne. E poi aggiunge, con glaciale assurdità “Mi sembra che poi, mentre stavo ammazzando Valentina, sono tornato a dare un’occhiata per vedere Luca come stava, perché ero molto preoccupato per Luca”.
Non c’è pathos, né follia. Solo un male che si racconta da solo, senza causa, senza raptus, senza trauma, e proprio per questo ancora più perturbante. La scena è pubblica, registrata, trasmessa, archiviata: è un pezzo reale di quel futuro iper-sorvegliato che temiamo, solo più grezzo, meno tecnologico, ma già spettacolarizzato. Izzo non viene mostrato da una telecamera nascosta: è lui stesso che, consapevole della messa in scena, fornisce il contenuto. Ed è questo che apre la strada a tutto il resto.
Il quid di Francesca Fagnani consiste nel portare il pettegolezzo nel contesto dell’interrogatorio poliziesco e pretesco, trasformando la celebrità in un imputato, costantemente al cospetto delle sue dichiarazioni e alla miseria di una vita votata all’eccesso normalizzato.
A quel punto Fagnani fa scattare il doppio dispositivo: da un lato il confessionale – luci basse, campo controcampo serrato, tempo dilatato finché l’ospite non sente il silenzio rimbombargli dentro – dall’altro il tribunale – l’agenda rossa che si apre, la voce che cita verbatim post, interviste, sentenze social. L’effetto è una compressione implacabile: l’intervistato viene chiamato a ricomporre la frattura tra ciò che ha venduto in pubblico e ciò che ha rimosso in privato. Non c’è via di fuga nelle smorfie o nei discorsi di circostanza, perché la vergogna diventa lo strumento chirurgico con cui la conduttrice scava. Il risultato è un’anamnesi crudele ma necessaria del mito moderno del vip: il racconto dell’eccesso non è più glamour, è cartella clinica; la vanità viene pesata al grammo, alla luce dei criteri di verità giornalistica che l’agenda rossa certifica.
Così Belve ridefinisce l’intervista come atto istruttorio: non intrattenimento, ma raccolta prove; non talk show, ma processo culturale in diretta. Vi è qualcosa di repulsivo nella posa giornalistica della padrona di casa, che non ha disdegnato, in molteplici occasioni, di mettere alla berlina gli ospiti più trash, mostrando un sadismo spietato e giudicante. Resta il fatto che il format sia un assalto al cielo della celebrità, diventando il canto del cigno dello star-system italiano, che non più protetto dalla distanza garantita dal vecchio sistema mediatico si rivela un pantheon misero che non è riuscito a fare i conti con lo tsunami delle microcelebrità che ha spanato i meccanismi di esclusività dei media tradizionali.
Belve ridefinisce l’intervista come atto istruttorio: non intrattenimento, ma raccolta prove; non talk show, ma processo culturale in diretta.
Grazie ai prologhi di Stefano Nazzi, lo spettatore viene illuso di partecipare a un’indagine civile. Ma appena l’inquadratura si allarga, ecco il tuffo nel torbido: il programma smette di essere servizio pubblico e diventa servizio voyeuristico. Fagnani, fedele alla sua agenda rossa, non si cura del punto di vista della vittima; preferisce colpire l’imputato con la clava del “dossier sessuale”, rovistando fra fantasie, deviazioni e traumi alla ricerca dell’archetipo perfetto che spieghi l’innominabile. È la stessa gramigna che infesta il true crime di bassa lega: la pornografia del dolore sostituisce l’analisi sociale, l’empatia viene sacrificata sull’altare del clic bait.
I contraddittori con Massimo Bossetti o Mario Maccione? Puro innesco memetico. L’ospite, irrigidito da déjà‑vu processuali, recita un copione di autodifesa; la conduttrice, coltello fra i denti, rincorre lo scarto virale – la smorfia, il lapsus, la lacrima. Ne esce un rito di colpevolizzazione‑redenzione senza vera catarsi: il pubblico gode del fango ma non riceve strumenti per comprenderlo. In questo cortocircuito il narcisismo da ergastolo e quello da rotocalco si specchiano l’uno nell’altro, mentre il ruolo di “servizio pubblico” scivola in un circo del cattivo gusto che, anziché illuminare la cronaca nera, la sfrutta per il prossimo reel da 30 secondi.
Il crimine in diretta è già qui, sotto mentite spoglie, rimontato con garbo da prime serate che travestono l’interrogatorio da intervista e la confessione da contenuto virale. Belve Crime, trasforma i media in un’aula di tribunale e mostra in filigrana le continuità profonde tra gli sguardi inquisitori: quello del prete, del poliziotto, del giornalista. Tutte posture retoriche nate per estorcere verità ‒ o almeno brandelli utili di racconto ‒ a corpi già segnati da colpa, dolore o clamore. La videocamera si fa confessionale e sala d’interrogatorio insieme: il crimine non viene solo esposto, ma interpretato e metabolizzato attraverso uno sguardo che finge neutralità mentre insegue l’effetto, la reazione, il reel. Così, mentre crediamo di assistere alla rappresentazione del male, ci stiamo abituando a consumarlo.
Non siamo lontani dallo scenario delineato in Nightcrawler – Lo sciacallo, film di Dan Gilroy del 2014 con Jake Gyllenhaal, che ha descritto la metamorfosi del cronista in predatore. Lou Bloom non si limita a filmare gli incidenti: li provoca, li orchestra, li manipola per trasformarli in contenuti vendibili alle TV locali. Non documenta il male: lo produce. Ogni corpo a terra è un’inquadratura da perfezionare, ogni agonia un’occasione di storytelling. È il Cristo invertito del giornalismo: non si immola per raccontare la verità, ma sacrifica gli altri per raccontare qualcosa. E questo qualcosa, guarda caso, è sempre vendibile. È il primo vero telegiornalista del futuro: freelance, amorale, perfetto.
La videocamera si fa confessionale e sala d’interrogatorio insieme: il crimine non viene solo esposto, ma interpretato e metabolizzato attraverso uno sguardo che finge neutralità mentre insegue l’effetto, la reazione, il reel.
Blu Notte di Lucarelli costruiva una mitologia del male italiano: complotti, stragi, verità sepolte. Un giorno in pretura, al contrario, mostra il processo nella sua ritualità spoglia: ossessivo, ripetitivo, ma affascinante proprio per la sua forma liturgica. Anche Chi l’ha visto?, in apparenza più sobrio, partecipa al rito: la sparizione come racconto collettivo, una messa laica dell’assenza. Tre format partecipi di una stessa dinamica: prendere il male e farne racconto. Non per guarirlo, né per risolverlo, ma per renderlo compatibile con il nostro bisogno di ordine simbolico. Il crimine, il processo, la sparizione: tre modalità con cui l’oscuro entra nella sfera pubblica, e diventa intrattenimento catartico, il sublime del cittadino comune.
Ma la fascinazione per la morte filmata ha radici più antiche. Già nella Prima guerra mondiale, The Battle of the Somme di Geoffrey Malins e John McDowell (1916) ibridava realtà e messa in scena. Negli anni Settanta, la leggenda dello snuff movie prometteva filmati reali di omicidi: nessuno li aveva visti, ma tutti ne parlavano.
Oggi quella leggenda è diventata realtà. Oggi è il tempo in cui la telecamera di uno smartphone riprende un suicidio in diretta, un omicidio in mezzo alla folla, un femminicidio trasmesso come un reel qualsiasi. È il tempo delle Instagram stories di ragazzi israeliani che ballano e brindano mentre missili si slanciano sopra le loro teste per massacrare dei loro coetanei palestinesi, o – come accaduto pochi giorni fa, nel giugno 2025 – della diretta Instagram a Kfar Yassine di un sassofonista libanese che intona una melodia mentre l’Iran lancia razzi su Tel Aviv. Non c’è più bisogno di effetti speciali: la morte è già montata, sonorizzata, distribuita. È contenuto. È virale. È normale.
Il video è la nuova teca che custodisce la reliquia. Così la morte spettacolarizzata compie il suo passaggio di stato: da contenuto a culto.
Come nei martirologi medievali, anche nella cronaca nera il dolore viene ritualizzato, sezionato, messo in fila. Si narra la passione della vittima attraverso un’iconografia precisa: il corpo martoriato, l’agonia minutamente descritta, il dettaglio delle ferite che diventa rivelazione. Come i santi venivano trafitti, scorticati, arsi vivi sotto gli occhi estatici dei fedeli, così le vittime di femminicidi, stragi familiari, omicidi seriali vengono riesumate nei racconti giornalistici con una cura quasi liturgica per il dettaglio cruento.
Il delitto, come il martirio, ha una sua funzione pedagogica. Serve a edificare l’opinione pubblica, a rinsaldare un ordine morale che si finge scosso, ma in realtà si nutre del racconto dell’orrore per riaffermare la propria superiorità. Il santo è testimone della verità divina; la vittima lo è di una verità sociale altrettanto indiscutibile: quella che ci ricorda quanto sia fragile il confine tra ordine e caos, tra casa e inferno, tra normalità e crimine.
E proprio come il martirologio si costruiva su una drammaturgia della reiterazione – stesso schema, stesse torture, stesso esito glorioso – anche la cronaca nera si regge su formule fisse, cliché che rassicurano mentre inquietano: il movente passionale, la dinamica familiare, l’assassino insospettabile, il vicino che “sembrava tanto tranquillo”. Ma ogni tanto lo schema salta, e l’inquietudine prende il sopravvento. È il caso di Un giorno in pretura, quando mandò in onda il processo ad Angelo Izzo. Nessun raptus, nessuna follia: solo la gelida, mostruosa razionalità di un uomo che, mentre uccide, si preoccupa del disagio emotivo dell’amico. “Ero tutto preso dalla questione di Luca Palaia perché avevo paura che facesse qualche sciocchezza”, dice in aula, come se fosse il custode della sensibilità altrui in mezzo a un bagno di sangue. È in quei momenti che lo schermo riesce davvero a catturare qualcosa di perturbante: non l’eccesso emotivo, ma l’assenza totale di una causa. Il male senza fondamento, senza trauma, senza perché. Un male che, proprio per questo, resta sospeso, non assimilabile, incapace di chiudersi in narrazione – e dunque, forse, il solo veramente reale.
Il delitto, come il martirio, ha una sua funzione pedagogica. Serve a edificare l’opinione pubblica, a rinsaldare un ordine morale che si finge scosso, ma in realtà si nutre del racconto dell’orrore per riaffermare la propria superiorità.