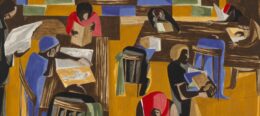C
hi era veramente Jacques Lacan? Provare ad avvicinarsi alla natura di questa esistenza potrebbe forse rivelare i segreti sepolti in un pensiero coraggiosamente oscuro, che procede per folgorazioni e illuminazioni e non sembra poter essere ridotto alla più tranquillizzante e canonica catena di causa-effetto. Studiare la parte più sommersa della psiche umana, come ha fatto Lacan, plasma inevitabilmente anche il modo di raccontarla, ma alla grigia intransigenza dell’analista fa da controcanto un’esistenza spumeggiante e sempre tesa al superamento dei limiti, una dissonanza in realtà solo apparente perché mostra come l’uomo e il suo pensiero non siano del tutto divisibili.
Catherine Millot, allieva e poi compagna di Lacan, nel suo Vita con Lacan (2017), offre un ritratto inedito dello psicoanalista francese catturato nella sua esistenza quotidiana, tra lo studio a Parigi nel settimo arrondissement e la casa di Guitrancourt, tra le corse folli con la macchina (Lacan non sopportava le code e superava le altre auto in corsia di emergenza o abbandonava la sua in mezzo alla strada se la cosa era inaggirabile o un semaforo rosso troppo a lungo) e gli imprescindibili bagni nella piscina della sua casa di campagna qualsiasi fosse la stagione. Ma scoprendo i tic e le fissazioni di Lacan emerge pian piano il fondamento che è alla base del suo lavoro, l’idea, cioè, di un movimento inesorabile verso lo sconosciuto, una spinta sempre in avanti, la forza di protendersi fino al limite. Così come le forme del desiderio che la sua psicoanalisi ha mirato a definire, a questo anelito verso l’infinito che muove l’uomo e il pensatore, Lacan ha offerto, sempre, la sua dedizione più assoluta.
Nell’inverno del 1971, settantenne, affermato già in tutto il mondo come uno dei più grandi eredi di Sigmund Freud e sempre al centro di critiche che ne contestano l’insegnamento o la pratica di analisi tanto da venire a un certo punto scomunicato dall’IPA (International Psychoanalytical Association), Jacques Lacan viene chiamato all’Ospedale Sainte-Anne di Parigi per tenere una serie di conferenze per i medici psichiatri dell’istituto. Il Sainte-Anne, situato nel quattordicesimo arrondissement e dal 1863, per volere di Napoleone III, dedicato alle cure psichiatriche, di cui usufruiranno anche Antonin Artaud e Paul Celan, non era un posto qualunque per Lacan perché alla fine degli anni Venti in quelle sale cominciò a esercitare la professione medica come psichiatra. Tornarci quindi, dopo quasi mezzo secolo e dopo aver fondato due scuole centrali per la storia della psicoanalisi e delle scienze umane tutte, l’École freudienne de Paris che poi scioglie e l’École de la Cause freudienne, significava per Lacan guardarsi indietro, capire il luogo da dove si era sviluppato il suo pensiero e, per certi versi, fare i conti con la strada che fino a quel momento aveva percorso.
All’interno di un’opera che è quasi esclusivamente orale e basata sui suoi seminari affollatissimi Lacan è consapevole dell’insufficienza della parola e dell’impossibilità di trasmettere attraverso i suoi significati i segreti dell’esistenza psichica umana. Eppure, non esiste altro modo.
La raccolta di quegli interventi ha un titolo emblematico, che nella sua icasticità rende bene le forme ermetiche, e per certi versi impenetrabili, della sua opera:
Io parlo ai muri, questo il titolo, è infatti un concetto in grado di restituire l’opacità di una parola che, andando a indagare gli spazi più reconditi dello spirito umano, quelli dell’inconscio, per sua stessa natura risulta inafferrabile e inspiegabile, una dichiarazione di poetica che accetta le difficoltà e ne assume tutto il valore per provare ad andare oltre alla limitatezza del parlare. Nell’incontro che tiene nella cappella dell’ospedale, Lacan prova a spiegare al suo uditorio il paradosso di tutta la sua esperienza: all’interno di un’opera che è quasi esclusivamente orale e basata sui seminari affollatissimi che tenne per tutta la vita e che videro affollarsi migliaia di studenti, personalità dell’intellighenzia mondiale e curiosi, Lacan è consapevole dell’insufficienza della parola e dell’impossibilità di trasmettere attraverso i suoi significati i segreti dell’esistenza psichica umana. Eppure, non esiste altro modo.
Perché però provare? Perché tentare di forzare i limiti del linguaggio davanti a un’impresa che si preannuncia, sin dall’inizio, impossibile? In queste domande è racchiuso il senso intero di un’opera lanciata verso l’impossibile, sfidare il monito di Wittgenstein su quello su cui si dovrebbe tacere: nel suo desiderio di sondare l’insondabile l’opera di Lacan è rivoluzionaria e non solo si ricollega al magistero di Freud (attraverso il suo celebre e auspicato “ritorno a Freud”) ma in un certo senso lo oltrepassa perché lo studio dell’inconscio finisce per superare abbondantemente i confini della psicoanalisi e incrociare proficuamente la sua strada con altri campi del sapere, dalla letteratura alla filosofia fino alla matematica. Il segno probabilmente più evidente di questo slancio verso l’impossibile è testimoniato dalla natura orale e seminariale del suo lavoro: l’unica opera scritta pubblicata nel corso della sua vita sono i due volumi degli Scritti (che comunque sono una raccolta di testi già pubblicati altrove o di discorsi e conferenze pronunciate in giro per il mondo) mentre tutto il cuore del suo insegnamento e della sua eredità sta proprio nei seminari che tenne a Parigi tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta e che sono dapprima un’analisi dei concetti di Freud e poi, a partire dal celebre seminario I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, una riscrittura di Freud con la lenta e inesorabile emersione dell’originale pensiero lacaniano.
Nel suo desiderio di sondare l’insondabile l’opera di Lacan è rivoluzionaria e non solo si ricollega al magistero di Freud ma in un certo senso lo oltrepassa perché lo studio dell’inconscio finisce per superare i confini della psicoanalisi e incrociare la sua strada con altri campi del sapere.
Come uno dei suoi maestri,
Alexandre Kojève, le cui lezioni parigine su
Hegel ebbero una ricaduta fondamentale per tutta la cultura del secondo Novecento e a cui partecipò anche Lacan in compagnia di personaggi come
Raymond Queneau,
Georges Bataille,
André Breton,
Hannah Arendt e molti altri, Lacan ripone una fiducia massima nell’ambito seminariale che diventa da un lato la messa alla prova più estrema dell’uso della parola e, dall’altro, l’unico mezzo attraverso il quale diffondere le proprie idee, difficilissime da ingabbiare sulla pagina scritta. Riveste quindi un ruolo centrale, che emerge bene anche da
Io parlo ai muri, l’insegnamento, un gesto non riducibile solo alla trasmissione del sapere, ma che si tinge di una relazione decisiva con chi ascolta, chiamato a collaborare alla costruzione della conoscenza: “Mi sforzo – dice Lacan – affinché non abbiate un accesso troppo facile al sapere, così che voi dobbiate metterne del vostro”. Jacques-Alain Miller, durante una delle conferenze che tenne in Brasile su Lacan e che sono raccolte nell’importante volume
Delucidazioni su Lacan (2025) spiega bene come l’insegnamento di Lacan “impedisce di credere che lo si possa comprendere immediatamente”: in questo senso leggere Lacan, provare a cogliere il mistero più profondo del suo pensiero, e quindi il segreto intero dell’essere umano, è un atto di fede assoluto.
La parola è quindi lo strumento fondamentale dell’insegnamento di Lacan nonostante per lui la verità sia per sua stessa natura impossibile: “Io dico sempre la verità: non tutta! Perché a dirla tutta non ci si arriva. Dirla tutta è impossibile materialmente: sono le parole che mancano! È proprio per questo ‘impossibile’ che la verità tocca il reale”. “I muri in fondo sono fatti per circondare un vuoto” dice Lacan e in effetti insegnare rappresenta proprio lo sforzo di circoscrivere questo vuoto, di dargli una forma e fare in modo che nell’aula, nelle quattro mura che la costituiscono e che custodiscono gli uditori, si possa formare un sapere da condividere che oltrepassi i confini della verità, la limitatezza del parlare.
In questo senso la parola assume un valore decisivo e un’importanza ancora maggiore all’interno di un pensiero che considera e studia l’inconscio come un linguaggio: qui sta la novità assoluta del pensiero di Lacan che riprendendo la distinzione del linguista De Saussure tra langue e parole (e cioè tra il linguaggio come sistema e la sua espressione) in un saggio fondamentale, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicanalisi, espone come il linguaggio venga legittimato solamente dall’incontro con l’altro: “non v’è parola senza risposta, anche se non incontra che il silenzio, purché abbia un uditore”. Se quindi la langue può esistere anche senza soggetti, la parole necessita dell’intervento di un altro soggetto per poter funzionare: questo rivela come per Lacan l’intera esistenza umana, di cui l’analisi e il rapporto analista-paziente non è che un epifenomeno, sia segnata dalla necessità dell’Altro.
Negli ultimi anni della sua vita Lacan diventa ostaggio della sua ossessione per il nodo Borromeo (fa comprare ogni tipo di corde e dissemina il pavimento del suo studio e della sua camera da letto di questi nodi, oltre a mostrarne tutte le implicazioni a un Heidegger oramai anziano che non sembra coglierne l’importanza) e anche i suoi seminari cominciano a scivolare verso un silenzio che appare molto lontano dalla teatralità degli anni precedenti. Maillot racconta un evento accaduto in quegli anni che oltre a rivelarsi commovente testimonia anche lo scivolamento dell’uomo e del suo pensiero verso il silenzio. Una notte il vecchio Lacan esce dalla sua casa parigina in rue de Lille, per andare da suo genero, nonché successivamente esecutore testamentario, Jacques-Alain Miller e dalla figlia Judith per infilarsi nel letto del piccolo nipote Luc: sembra trattarsi di un’estrema richiesta di compagnia che si tinge, come ha scritto Massimo Recalcati, della “forma della supplica, della preghiera” diventando la concretizzazione assoluta di quell’invocazione dell’Altro che aveva segnato tutta la sua vita.
In questo senso le fasi finali della vita di Lacan sono attraversate da una lacerazione insanabile: se dal punto di vista teorico lo studio della topologia dei nodi borromei lo allontana sempre di più dalle spire umanistiche, dall’altro avverte radicalmente il suo essere inerme e solo, abbandonato a un’afasia simbolica che trova corrispettivo nell’opera di James Joyce (da ragazzo aveva assistito, poco prima della pubblicazione francese dell’Ulisse da Shakespeare and Company, alla lettura di alcuni passi del romanzo) e, in particolare, nel Finnegans Wake, a cui dedicherà importanti analisi nei suoi ultimi seminari (Il sinthomo e Ancora), ritrovando in Joyce lo stesso rigore e lo stesso coraggio con il quale aveva rinnovato la clinica. In una lettera al padre un Lacan diciassettenne, difendendo la sua strenua opposizione alle idee dello zio, scrive: “la mia personalità consiste nel fatto che mi rifiuto nel modo più assoluto di farmi riempire la testa”. Questa ostinata fiducia nel proprio pensiero trasforma Lacan in Edipo perché il suo desiderio di sapere diventa il desiderio di conoscersi. Ma questo itinerario non è individuale, non è una lunga ricerca solitaria perché la mediazione dell’Altro è imprescindibile ed è solo attraverso un confronto con la sua immagine che può pian piano emergere la propria.
Se dal punto di vista teorico lo studio della topologia dei nodi borromei allontana Lacan sempre di più dalle spire umanistiche, dall’altro avverte radicalmente il suo essere inerme e solo, abbandonato a un’afasia simbolica che trova corrispettivo nell’opera di James Joyce.
Il nodo Borromeo che ossessiona Lacan negli ultimi anni della sua vita, quella in cui, per contrasto, riconosce la natura distruttiva della solitudine, viene soprannominato “nodo Bo” che, con un gioco di parole assimilabile alle acrobazie linguistiche del
Finnegans Wake, rimanda da un lato al “neud-bo” ma, dall’altro, al “mont Nébo”, il monte Nebo, il luogo in cui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa e dove, secondo l’Antico Testamento, Dio stesso lo seppellì. Lacan ha provato a scalare questa montagna per tutta la sua vita in una lotta con il reale che terminò nel 1981 a causa di un cancro all’intestino a cui, come raccontò la figlia Judith, decise di non opporre alcuna resistenza “così, per capriccio”. La morte non lo spaventò mai, tant’è che quando un ladro entrò nel suo studio durante una supervisione Lacan gli disse di non avere alcuna paura di morire (alla fine fu il suo paziente a dare i soldi al malvivente e Lacan cominciò a viaggiare sempre con un tirapugni di ferro), poiché la considerava non tanto un evento distruttivo quanto una tendenza ultima a ritrovare la quiete definitiva. Così la sua morte si pone all’ombra di
Edipo a Colono, il vecchio che svanendo lascia al mondo una domanda che non può avere una risposta se non lo stesso mutismo della fase finale della vita di Lacan. In questo Lacan ricorda il protagonista di un racconto di
Maurice Blanchot in cui un uomo, in attesa della scarica di fucili del plotone di esecuzione che gli si para davanti, comprende, per un istante, il tutto: “restava in attesa soltanto della scarica dei fucili, quella sensazione di leggerezza che non saprei tradurre: liberato dalla vita? L’infinito che si apre? Né felicità, né infelicità. Né l’assenza di timore e forse già un passo al di là”.