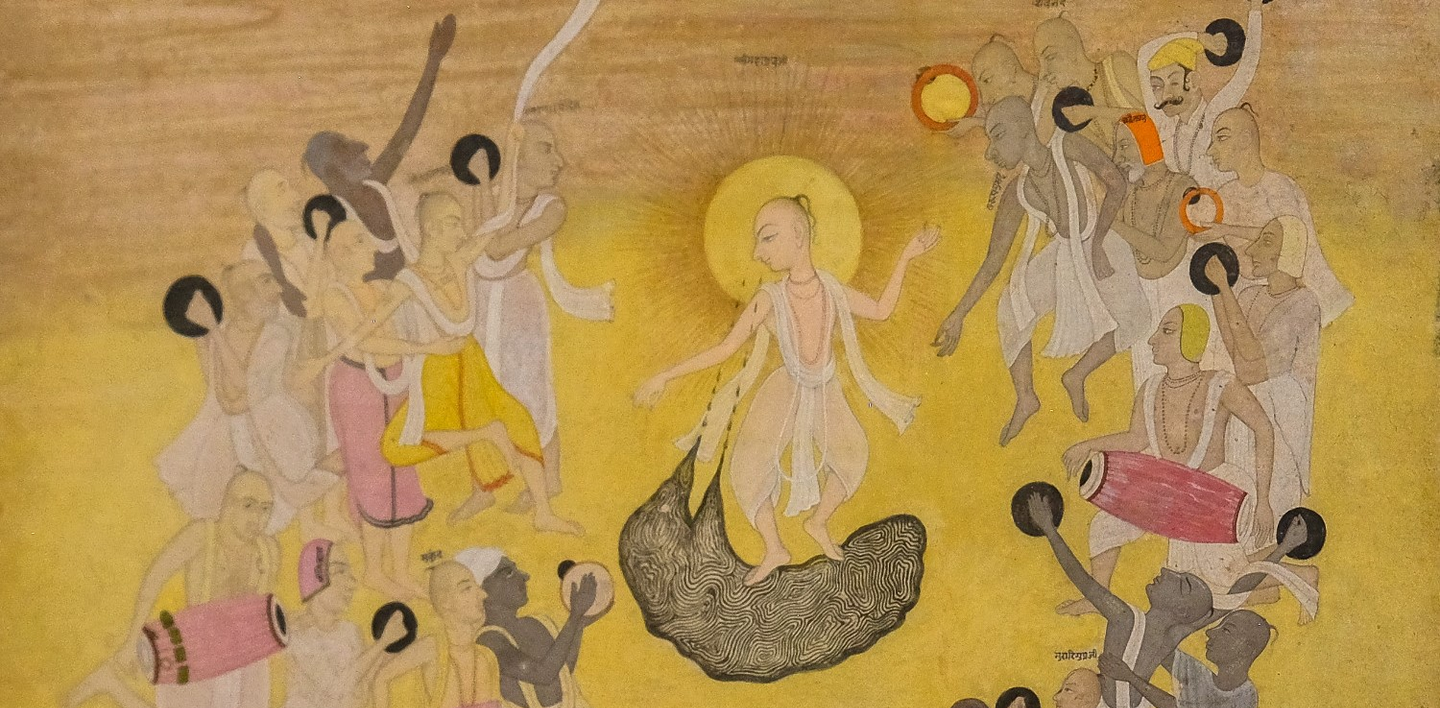
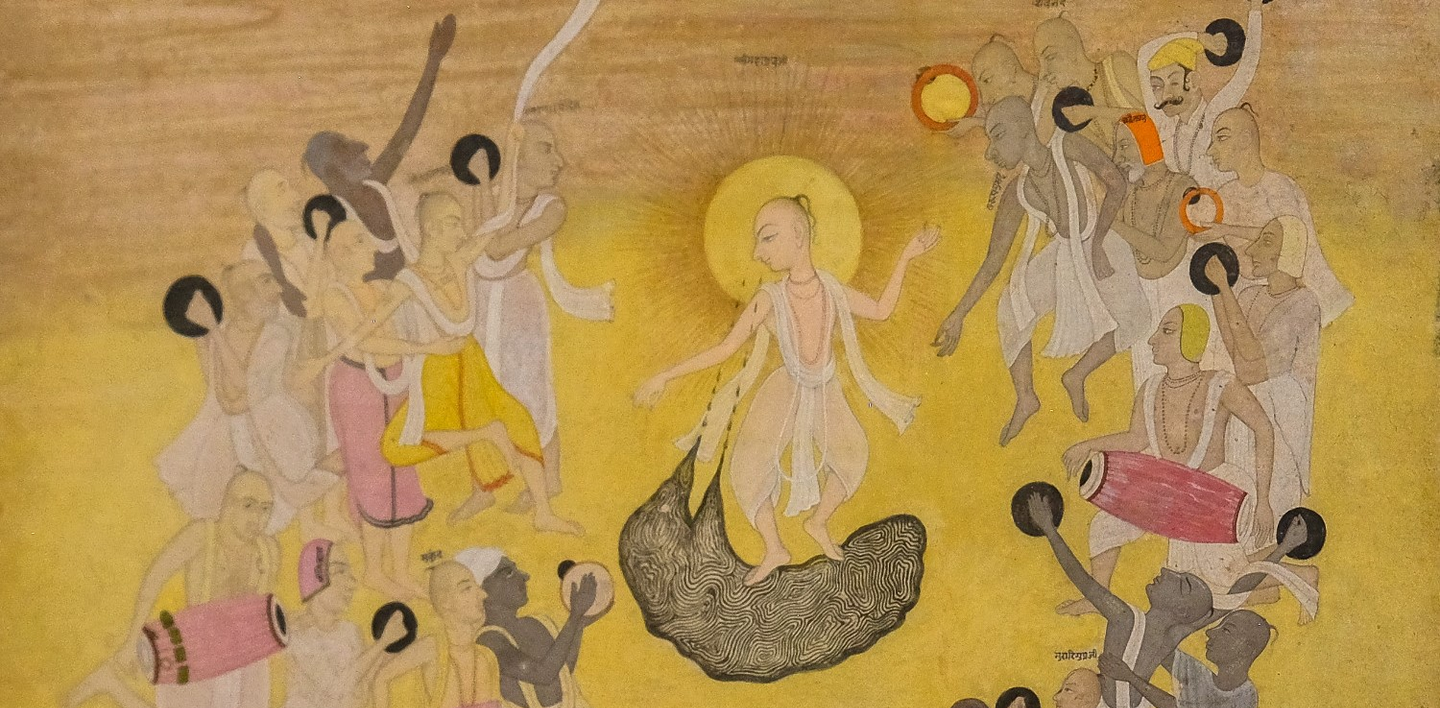
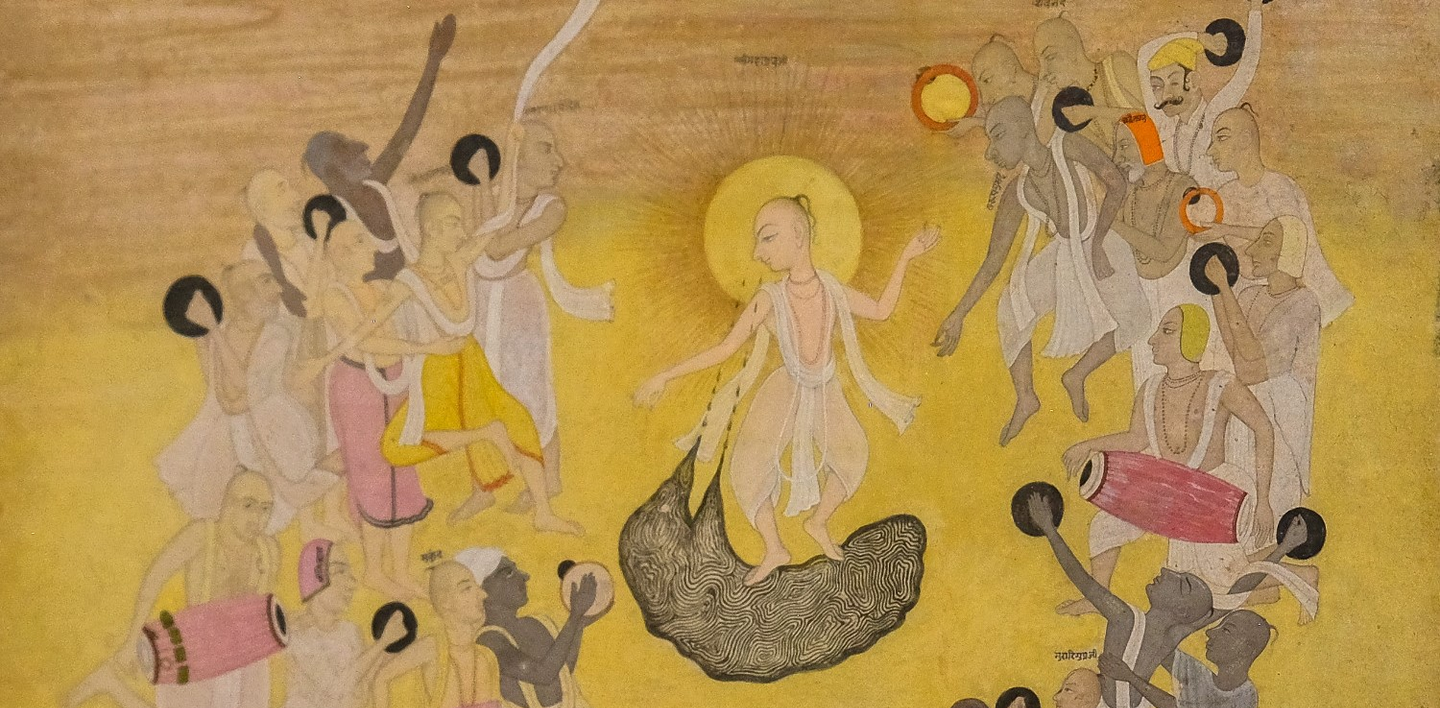
a llora, l’altro giorno stavo con due amici alla street contro il decreto sicurezza a Roma, no? (carri-murodicasse, 30 gradi, facce rotte, tekno dritta, la A cerchiata sugli striscioni), in corpo un’acquetta leggera di 5-MAPB, giusto il necessario per indurre uno sparlio più avvincente ed empatico, che ha però l’effetto di farmi diventare sonnambula. Nel senso, camminiamo camminiamo e arriva notte – forse montano alla Caffarella; ma ‘sta musica è cringe; siga; forse agli Acquedotti; nah, troppo lontano; che gelo senza felpa; siga; birrino?; il notturno per Termini perso; tipo come Jean Genet; pizzetta?; quando avevo sedici anni; siga; fratello una monetina?; era tutta piena di sangue; siga; oh, ripassa la metro; last birrina? – e mi sento l’NPC di una raver, intrappolata nell’inseguimento videoludico di una sottocultura già esausta nel setting di una Roma ripulita dal giubileo. Come un’intelligenza artificiale che aggrega gesti e parole in termini probabilistici, senza comprenderne davvero l’ontologia. Come Martino, la voce narrante di Il detective sonnambulo (2025), l’ultimo romanzo di Vanni Santoni.
Martino è uno spatriato in Francia, artistoide inconcludente che, nella prima parte del libro, vaga per una Parigi scarica, la poesia degli scapigliati otto-novecenteschi svanita nei gesti ripetitivi di mediocri simulacri della jeunesse bohémien che paiono anche loro più NPC (Non Player Character) di un videogame che la rappresentazione di una nuova scena tardo-decadentista alla Tropico del Cancro o alla Rayuela. Tra questi c’è la – chiamiamola – manic pixie dream girl Johanna, di cui Martino è innamorato e che, ovviamente di natura raminga, dopo qualche tempo, non può far altro che sparire. Le ricerche disperatissime di Martino per la città, in un rigurgito morente del flâneuring epifanico alla Pynchon dell’Incanto del Lotto 49, gli fanno incontrare a un certo punto un cartellone per strada che lo porta a mettersi in contatto con la militante anarchica Tanya.
Insieme decidono di cercare tal Manfredi Contini Della Torre – cryptoguru diventato miliardario in un mix di ingenio e fortuna investendo nella prima wave di bitcoin – che compare nella foto sul cartellone in compagnia di Johanna, e che ha fatto una misteriosa donazione all’organizzazione antispecista di Tanya. Da quel momento il libro si distacca totalmente dall’ideale romantico dell’artiste maudit (che appunto è portato fin da principio come un insieme di gesti grotteschi e morenti) andandosene nella molto meno poetica Davos (capitale finanziaria svizzera) perché ormai l’ideale è marcescente e non ha più nulla da raccontare, al di là forse di una nostalgia masturbatoria che finisce sempre e solo con una fiacca mano sfibrata nel buio. Questo il primo consapevolissimo movimento: il rito funebre del romanzo novecentesco, anche per questo il rimando a I detective selvaggi di Bolaño nel titolo (che guarda caso esce a solo due anni dalla fine del secolo).
Martino è uno spatriato in Francia, artistoide inconcludente che, nella prima parte del libro, vaga per una Parigi scarica, la poesia degli scapigliati otto-novecenteschi svanita nei gesti ripetitivi di mediocri simulacri della jeunesse bohémien.
Sai quante ne ho finanziate, delle tue “realtà”? Dai consorzi indigeni della Bolivia alle critical mass, sai quelli con le bici?, agli hacker a Bilbao, dagli squat di Lubiana a Extinction Rebellion a Londra… Ho dato soldi pure ai Valdesi, fai tu. Con la Pomegranate Foundation, un’altra struttura che avevo messo su con dei cryptomillionaire che per un po’ mi erano sembrati idealisti veri, ho spinto persino delle comunità spirituali a sfondo psichedelico. Risultati, pochissimi.
Anche il più strutturato progetto dello Schloss, però, lascerà infine Manfredi profondamente insoddisfatto poiché i grandi cambiamenti del mondo non si articolano attraverso quella scienza psicostorica teorizzata da Asimov nel Ciclo delle Fondazioni – la rivoluzione non si può sintetizzare in vitro – ma anche e soprattutto attraverso i nessi acausali della sincronicità junghiana di cui infatti il romanzo è gremito (lo conferma Santoni in un’intervista su Azione.ch). Ma prima di analizzare più a fondo le velleità demiurgiche di Manfredi, e capire che ne sarà di lui e del suo “guruismo”, dobbiamo tornare indietro. A quel passaggio del libro sui primi filantropismi del “cryptobro” e ancora più indietro, al precedente romanzo di Santoni.
Santoni da buon amante degli ipertesti e della cultura fantasy/otaku, negli anni ha costruito un universo narrativo in cui i personaggi dei suoi libri si incrociano, si attorcigliano e riprendono nuova vita.
Sebbene il legante tra universi narrativi tra La verità su tutto e Il detective sonnambulo sia più flebile rispetto ad altri libri di Santoni, quello simbolico è invece potentissimo. In entrambi i romanzi i protagonisti diventano guru di organizzazioni chiuse che partono dalla volontà di fare del bene, ma che poi inevitabilmente assumono dei tratti da setta, attorno ai quali si accentra appunto un conglomerato di devoti. La differenza tra Cleo/Shakti Devi e Manfredi è che la prima diventa leader spirituale suo malgrado, dopo aver inseguito per anni la morte dell’ego attraverso la psichedelia e la meditazione, mentre il secondo costruisce consapevolmente lo Schloss e se ne elegge, di fatto, demiurgo e re (nonostante anche lui sia un gran bel psiconauta).
Vanni Santoni è un nomen omen così potente che sottolinearlo sembra pleonastico, come un meme del 2010 rigurgitato su una pagina Facebook per boomer, ma in effetti su di lui nel corso degli anni si è sviluppato un vero e proprio culto. Per questo ora farò quell’operazione che spesso è mero veleno dell’industria dell’arte: ovvero, vestire i panni della detective paparazzo e indagare lo scrittore dietro alla scrittura, comprendere quali sono i punti di collisione fra la vita e la fiction. Non in un’ottica voyeuristica ma olistica – o, se vogliamo, sincronica.
Vanni Santoni: lo scrittore anarchico che per più di vent’anni ha bazzicato nella scena dei free party, il mangia-cartoni che pubblica con Mondadori e alle presentazioni ci va ancora con le Globe, quello che ha scritto il trittico di saggi narrativi sulle sottoculture, uno dei maggiori rappresentanti del rinascimento psichedelico, il toscanaccio che ha reso celebre Mircea Cărtărescu in Italia, quello che presenta scrittrici e scrittori internazionali al Salone del libro ma poi presta la voce per il docufilm Antirave (2024), proiettato negli squat, quello che se sei un esordiente e gli chiedi una mano manda due mail e ci prova ad aiutarti a svoltare. Chiaro? Quello che “letteralmente nostro padre” (meme tanto abusato quanto accurato in real life), dove il noi rappresenta tuttə quellə giovani artistə che si sono formatə a suon di sottoculture, libertarismo e cassa drittissima.
Sia in La verità su tutto sia in Il detective sonnambulo i protagonisti diventano guru di organizzazioni chiuse che partono dalla volontà di fare del bene, ma che poi inevitabilmente assumono dei tratti da setta, attorno ai quali si accentra appunto un conglomerato di devoti.
Quando uscii ci fu un “Oooh!” generale e si avvicinarono. Quando uscì Kumari partì un “Oooh!” anche più forte e qualcuno si buttò in ginocchio.
Non mi piace, ti dico che non mi piace, dissi volta verso di lei.
Ma se sono qui tutti i giorni.
Prima non avevano poster con le nostre facce. E non erano così tanti.
Nell’ingenuità risiede la purezza.
Non raccontare ‘ste cose a me, Kumari, ti prego… ti dico che oggi sono diversi, è come se fosse stata passata una linea…
Dalla folla si staccò un gruppo più piccolo, come uscito da un’oscura fantasia medievale: le donne scarmigliate si lamentavano, gli uomini si battevano la fronte, e al centro, in mezzo a quella angosciosa simmetria di supplicanti, c’era una donna che teneva in braccio una bambina che si sarebbe potuta dire viva solo per i piccoli spasmi che a tratti ne scuotevano il corpo pallido, con le labbra blu come quelle di un’annegata e delle occhiaie che erano le orbite di un teschio.
La tocchi! La tocchi!
Gridavano questo. Dicevano a me.
Pietà, Shakti Devi, la tocchi!
Pietà? Ma…
La tocchi, la tocchi!
… Toccala, su, mi disse Kumari mettendomi la mano sulla spalla mentre quella gente invitava anche lei a toccarla. Non avere paura.
Non ho paura, le dissi nell’orecchio. Solo, a differenza di te, non sento la seduzione di simili scene.
Che vuoi farci. Il mondo sta andando come sta andando. Toccala, su.
Dagli quel che vogliono, Shakti Devi. Se morirà, vorrà dire che doveva andare così.
Non ho paura che muoia, Kumari, ho paura che guarisca.
Durante la tappa romana del tour di presentazione di Il detective sonnambulo, alla Libreria AltroQuando, si riunì come di rito una piccola coorte attorno a Santoni. Oltre ad amiche, amici, artiste ed artisti affermati, detective sonnambuli come Martino che tentano la metamorfosi in detective selvaggi all’Arturo Belano. Una fumettista underground; una guida psichedelica; una mezza scrittrice (che poi sarei io). Tutte flesse nello strillo interiore “Pietà, Shakti Devi, la tocchi!”. Perché, per quanto possa essere umiliante flettersi in una posizione di subalternità, “tutti i poeti hanno bisogno di un padre”; e se, come continuava Arce, alcuni poeti sono “orfani per vocazione” e come Belano non tornano più, in realtà è solo perché hanno annusato l’austerità di un padre che per il timore di sporcarsi nella melma altrui e viceversa, diventa anaffettivo (Santoni, in ogni caso, la subalternità proprio cerca di obliterarla, del resto, appunto siamo tuttə libertarə). “L’uomo più insignificante è in grado di prendere decisioni che spettano soltanto ai re” scrive Bernhard in Gelo, e continua poi, attraverso la voce di un pittore ritirato fra i monti in preda a un male dell’animo: “Attorno a me s’era riunita un’intera generazione d’usurpatori formata da tre quattro cinque sei persone in cerca, come me, di ciò che è straordinario, che erano precipitate nell’indigenza dei loro sentimenti”.
Anche attorno a Santoni si è riunita questa generazione di “usurpatori” sonnambuli alla ricerca di ciò che è straordinario, ma lui decide di non seguire l’esempio di Arce: non rifugge dal tocco, perché il rifiuto innesta una gerarchia e allora, come Shakti Devi, “prende in braccio la bimba, le mette una mano sulla fronte e sillaba un mantra adatto alla situazione”, così si trasforma in un Manfredi Contini Della Torre in potenza, che le sue fortune non se le tiene strette covandole come un dragone, ma le condivide, le investe in filantropismo. Ma anche l’aiuto innesta una gerarchia e quindi se, parafrasando Cortázar, fare letteratura significa scrivere attorno a una domanda, nel senso più tormentoso del termine, la domanda di Santoni è forse: quando hai un potere, come usarlo per il mutuo soccorso? Come abolire le gerarchie? Come non sprofondare nei deliri di onnipotenza di demiurghi e demagoghi? Domanda riassunta perfettamente nel titolo di una canzone dei La Quiete, Cosa sei disposto a perdere?
Se fare letteratura significa scrivere attorno a una domanda, nel senso più tormentoso del termine, la domanda di Santoni è forse: quando hai un potere, come usarlo per il mutuo soccorso? Come abolire le gerarchie? Come non sprofondare nei deliri di onnipotenza di demiurghi e demagoghi?
Santoni non è Shakti Devi, e non è Manfredi Contini Della Torre. Come i personaggi creati dai romanzieri non sono mai i romanzieri stessi, ma degli oggetti magici da incantare e in cui inscrivere le proprie paure (interessante a questo proposito la riflessione sulla magia alchemica vs autotrascendente nella scrittura nell’articolo Santoni come educatore – Logomachia postmoderna tra Zandomeneghi e Santoni intorno a Dilaga ovunque.) Ma Santoni, si diceva, è una figura di riferimento. E non credo nel corso degli anni di essere stata l’unica a interrogarlo – un po’ alticcia, un po’ disperata – sui compromessi fra anarchia, lavoro culturale e arte. Cosa sei disposto a perdere? Non c’è nulla di più pericoloso, del resto, che perseguire la strada del bene. Che più che di bene di per sé, poi, si tratta sempre di morale autonoma. Da “anarcobomber” come Alfredo Cospito, Francisco Solara, Theodore Kaczynski – per il bene, il compromesso della violenza, della reclusione – passando per il neoculto di Luigi Mangione; fino ad arrivare alla comune Rajneeshpuram di Osho e alla setta della Manson Family. Cosa sei disposto a perdere?
Santoni è una figura di riferimento. E non credo nel corso degli anni di essere stata l’unica a interrogarlo sui compromessi fra anarchia, lavoro culturale e arte. Cosa sei disposto a perdere? Non c’è nulla di più pericoloso, del resto, che perseguire la strada del bene.
Ricordi quando Elon comprò Twitter e mise le “spunte blu”, ovvero l’autenticazione degli account, a pagamento invece che fondate sulla reputazione effettiva? A un certo punto la gente cominciò a creare falsi account di multinazionali, a verificarli con cinque dollari, e a condizionare il mercato… Uno di questi adorabili pirati creò l’account della Eli Lilly Pharmaceuticals e scrisse che di lì in poi l’insulina negli Stati Uniti sarebbe stata gratuita, e woom, ventidue miliardi di dollari bruciati in un attimo. Ti dirai, ma quale investor può essere tanto scemo da credere a un tweet così chiaramente fasullo? La risposta è: nessuno. Il tweet era stato processato dalle intelligenze artificiali, che ormai investono da sole: vedendo la spunta blu, e non conoscendo ancora l’ironia, il paradosso lo hanno preso per buono, del resto alimentano il sogno con frammenti di realtà già spuri, privi di una loro coerenza… La creazione è un’altra cosa, è tutt’altro potere.
Il romanzo diventa l’autopsia del sonnambulismo, una tassonomia della disfatta perché, insomma, non è che si deve affrontare l’esistenza come una guerra, ma sempre meglio conoscere il proprio nemico.
e allora torniamo alla street, la tekno, la notte, al mio sentirmi emulazione sonnambula di una sottocultura morente, alla costante ricerca di spettri da mettere sotto resina. Sicuramente più Martino, ma anche un poco Manfredi nel suo essere talvolta più algoritmo che umano, e perché ricordo quel senso di scottatura gassosa nel retro della nuca quando lessi Il ciclo delle Fondazioni di Asimov e pensai che non ci fosse nulla di più sensato e rassicurante della psicostoria, e ricordo il senso di sbenedicenza marcescente quando scoprii che era tutta una grossa cazzata. Ma ricordo ancora meglio una grossa piazza nel centro di Roma infestata da carrozzoni-murodicasse, centinaia di facce rotte a ballare e di fronte a noi una piramide che in realtà non guarda quasi più nessuno: il monumento funebre a una gerarchia estinta, dimostrazione che molte altre ancora se ne possono ribaltare, abolendo le dicotomie, le tripartizioni, spandendosi capillarmente nell’orizzonte. E la musica che riverbera anche quando l’impianto è spento e la 5-MAPB è scesa, beviamo due, tre, cinque birre, senza dire niente, solo bevendo e guardandoci a vicenda, finché dal sonnambulismo siamo già stati, di nuovo, risucchiati.