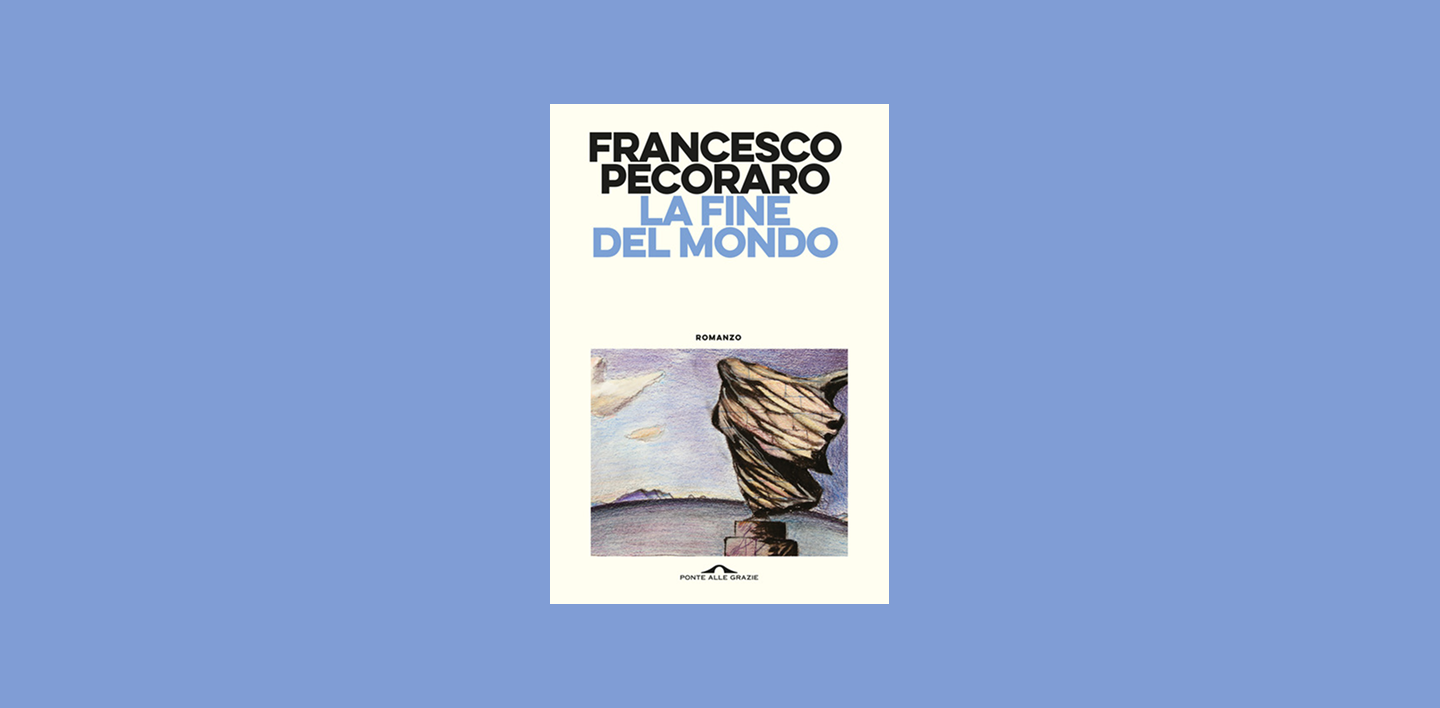
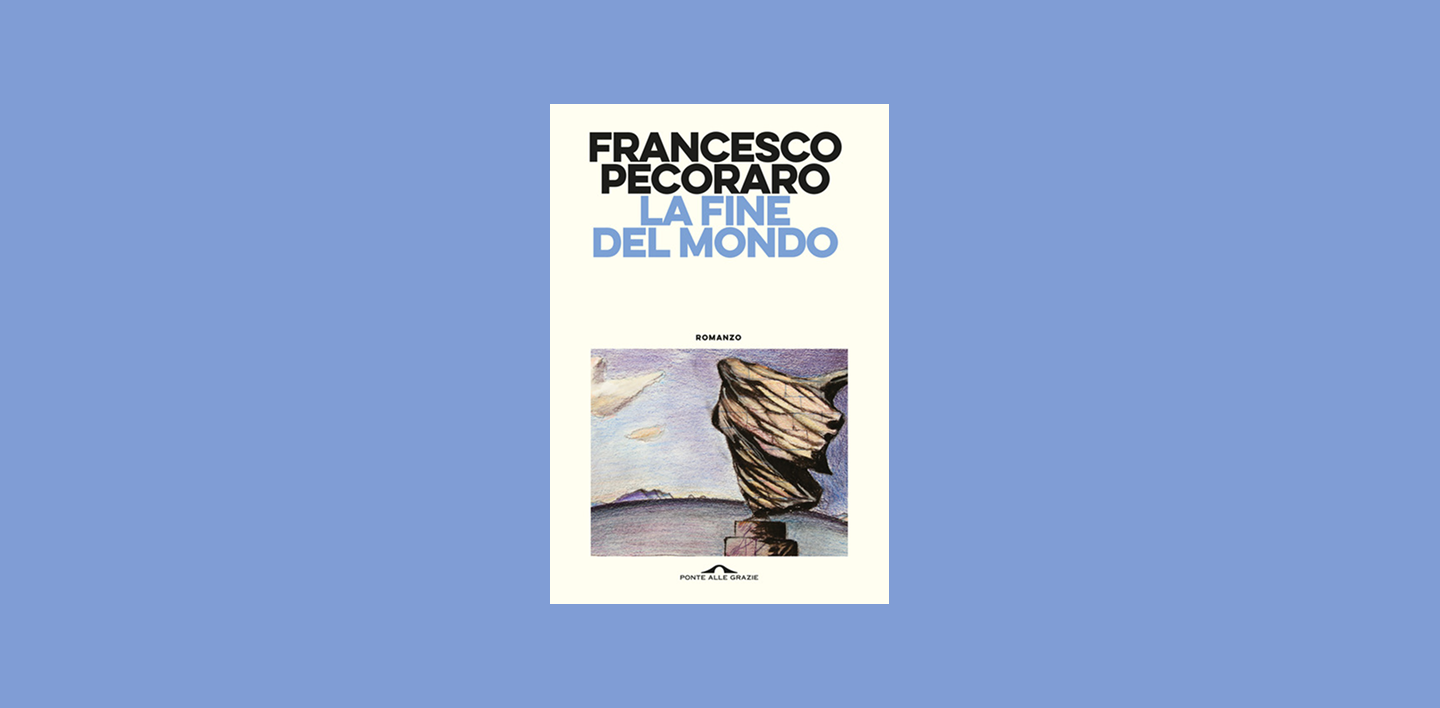
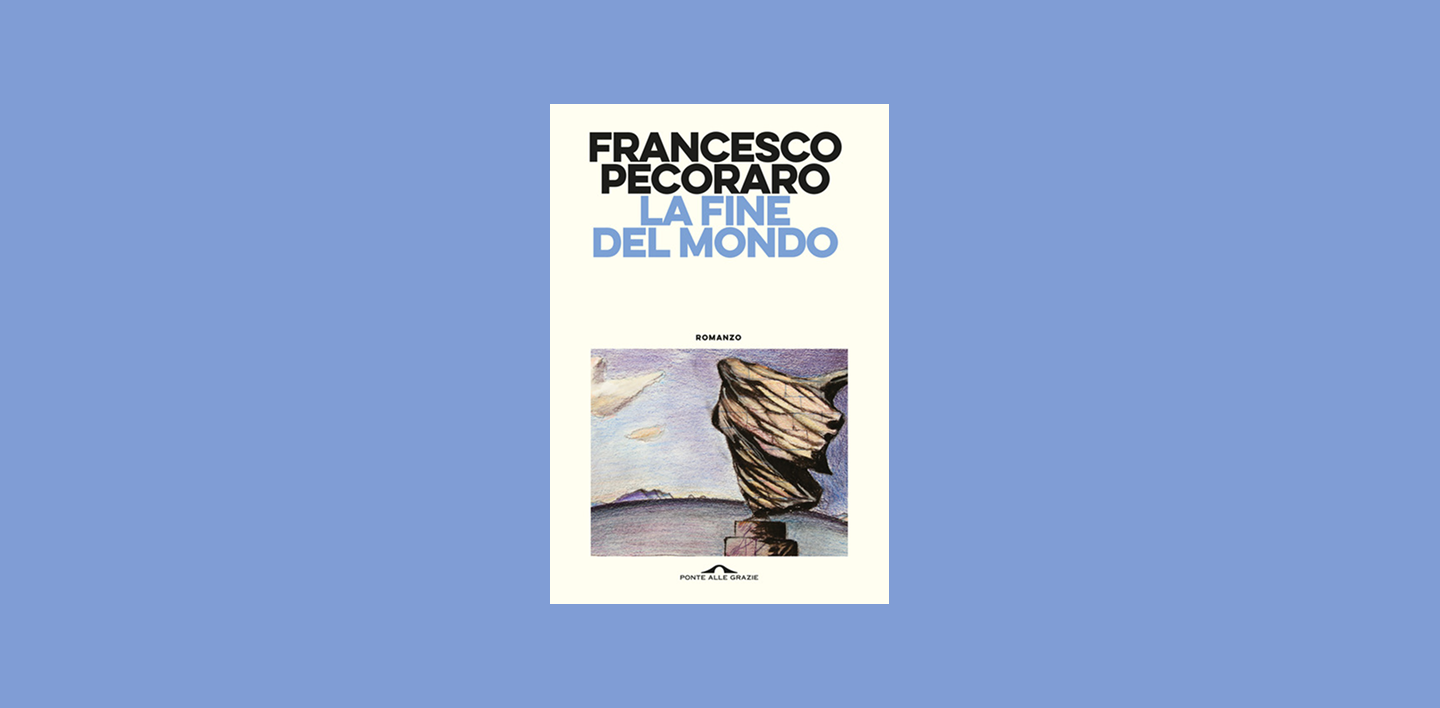
B isognerebbe farci l’abitudine alla fine e invece nonostante gli anni che passano e nonostante un mondo ‒ quello degli umani ‒ capace di rendersi sempre più inospitale ecco che l’idea della fine si annuncia sempre nella forma di un’apocalisse, alle volte di un’apocalisse stanca, ma sempre segnata da un carico di memoria che con il sopraggiungere degli anni appare insostenibile, come un vecchio solaio carico di bauli e valigie a cui improvvisamente cede la soletta riversando il suo peso di carte e ricordi direttamente nel salotto di casa, dove ci si credeva ancora protetti e dove ancora si sperava di prolungare, forse inconsciamente il proprio addio alla vita portandolo fino all’infinito.
Da sempre liminare all’apocalisse e in particolare alla vertigine che viene generata dalle ossessioni della vita urbana nell’epoca contemporanea, Francesco Pecoraro tocca con il suo ultimo poderoso romanzo punti nevralgici di un tempo che ormai si è convinto di essere contemporaneo, ma la cui inconsistenza ‒ confusa e vergata di ferocia ‒ non appare più in grado di reggere una memoria che diviene potentemente attuale proprio perché si assume il compito di preannunciare la fine come forse unica e vitale possibilità di salvezza.
La fine del mondo pare contenere nel suo corpo i romanzi precedenti, non per mezzo d’inclusione, ma per fagocitosi.
Il raggiungimento della fine si capovolge così in un presente apparentemente infinito, ma di certo ostinato, a cui una post-oloturia offre un appiglio, ma soprattutto una parte in scena sostanziale. Non si tratta, o non solo, di memoria viva e pulsante, di quello che nel tempo che fu analogico poteva essere definito trasmissione e in chiave marxista più specificatamente quale cinghia di trasmissione, ma di un passaggio post digitale e ormai del tutto biologico che punta a un’immortalità dettata dalla possibile fine della fine ovvero la mutazione delle forme.
La realtà si fa violenta tra gli uomini per garantirsi una bolla di possibilità all’infuori della quale esiste una crisi climatica non più rimandabile e che non può più essere assoggettata all’umore e all’inconscio, così come allo squadrismo individualista quanto all’ideologia collettiva.
Pensiamo alla città come qualcosa di costruito secondo ragione e coscienza, cui naturalmente ci sottomettiamo come si fa con un dato di realtà inconfutabile, mentre per lo più si tratta di una poltiglia irrazionale dove regnano l’interesse e l’inconscio delle generazioni di post-oloturie che l’hanno costruita: non so se la parola inconscio sia adatta a definire l’indefinibile, vale a dire la sommatoria di irrazionali aspirazioni individuali, comprese quelle dei pianificatori e dei loro maestri e dei teorici, ma per lo più della gente che consideriamo “comune”, che non lo è affatto, perché esprime la volontà potente che realizza la città e continuamente la modifica e, più o meno lentamente, la distrugge e la ricostruisce a seconda di vicende storiche che sono praticamente tutto inconscio.
La fine del mondo gode però al tempo stesso di un’inquietante solarità, tipica del risveglio e della giornata nuova. L’ossessione, così come la vertigine, non sono sentimenti che si prestano al buio, ma esplodono nella luce e così è, come se la voce che accompagna pagina dopo pagina il lettore volesse in qualche modo rilevare una comune sorpresa, uno stupore che è sempre più diffuso in chi nell’incombere di segnali pessimi per la propria salute si ritrovi a godere di un sole fuori stagione, un regalo insperato che pure è conseguenza naturale di un veleno ormai ampiamente in circolo. Una forma di razionale storicismo meteorologico: “La sua mente novecentesca faceva quello che ormai facevano solo i pochi, provinciali, derisi, comunisti silenti come lui: leggevano dietro e sotto gli accadimenti del presente e del passato prossimo, la forza trasformativa, cieca, brutale & instancabile, per certi versi incolpevole, del capitale”.
Una leggerezza solida e per nulla calviniana quella di Pecoraro, che guarda al passato con il distacco dell’errore compiuto e concluso e al futuro come un possibile risveglio, dalla memoria e dai suoi obblighi tutti così rigidamente sterili.
La fine del mondo riporta anche una leggerezza che risale dai racconti ‒ tutti splendidi ‒ di Dove credi di andare (2007), che furono l’esordio di Francesco Pecoraro. Una consapevolezza priva di ogni retorica, di ogni archetipo e quindi di ogni trama. Tutto è così fisico da apparire soprattutto verso la conclusione assolutamente gassoso. Una leggerezza solida e per nulla calviniana quella di Pecoraro, che guarda al passato con il distacco dell’errore compiuto e concluso e al futuro come un possibile risveglio, dalla memoria e dai suoi obblighi tutti così rigidamente sterili. Forse si può essere certi dell’arrivo della fine preceduta poco prima dall’apocalisse, ma intanto la paura entra nel corpo lasciandolo finalmente totalmente libero di immaginare:
Qualcuno ha detto, molti anni fa, una cosa che oggi mi pare molto ovvia: ha coraggio chi non ha immaginazione. Mi sono sempre sinceramente considerato un vile, quindi questa asserzione mi ha sempre consolato: sei un vile perché sei pieno di immaginazione, pensavo, compensando la vergogna con una facoltà che non è detto sia una virtù. Ma non importa, non mi è mai importato. Aver avuto paura nelle situazioni in cui nessuno sembrava averne, mi è sempre sembrata una vergogna. Immaginavo, è vero. L’ho sempre fatto. Ho immaginato e rivissuto. Per ciò che potevo, riuscivo a immaginare, a rivivere.