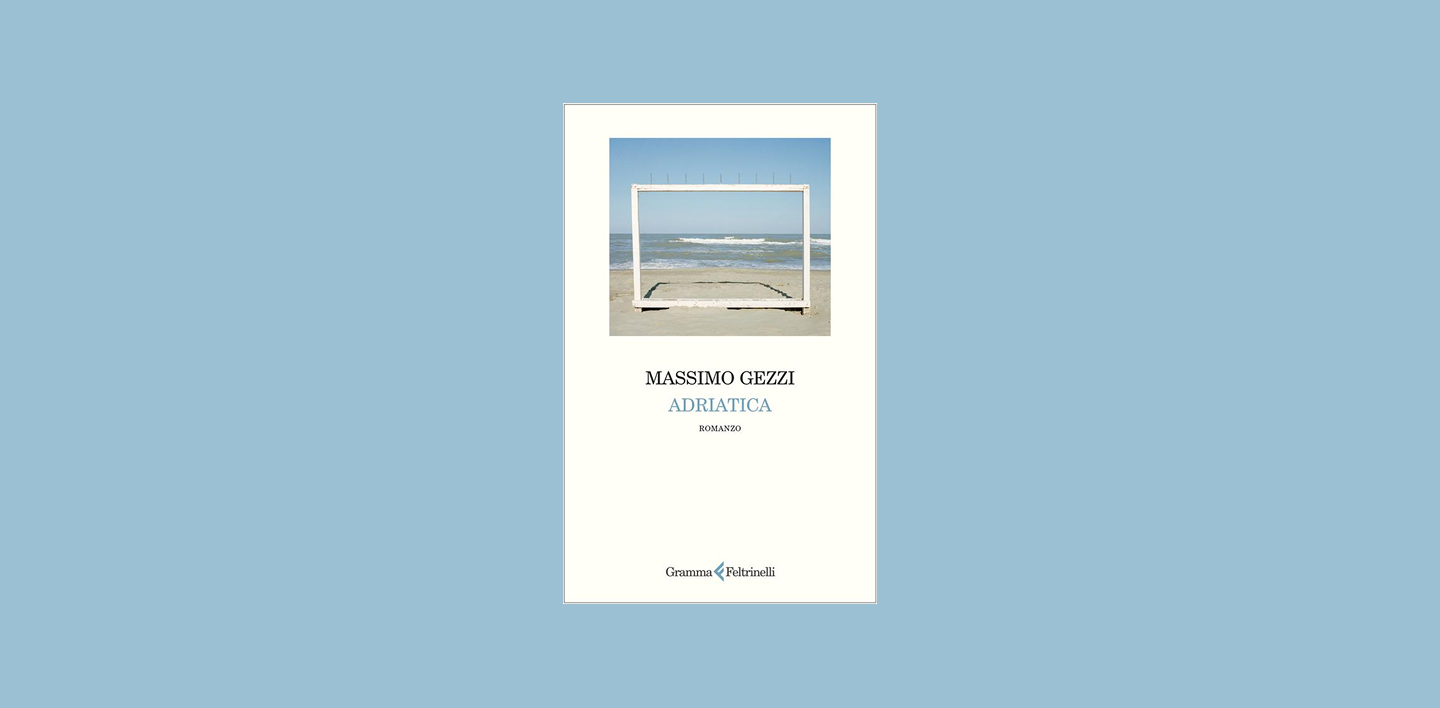
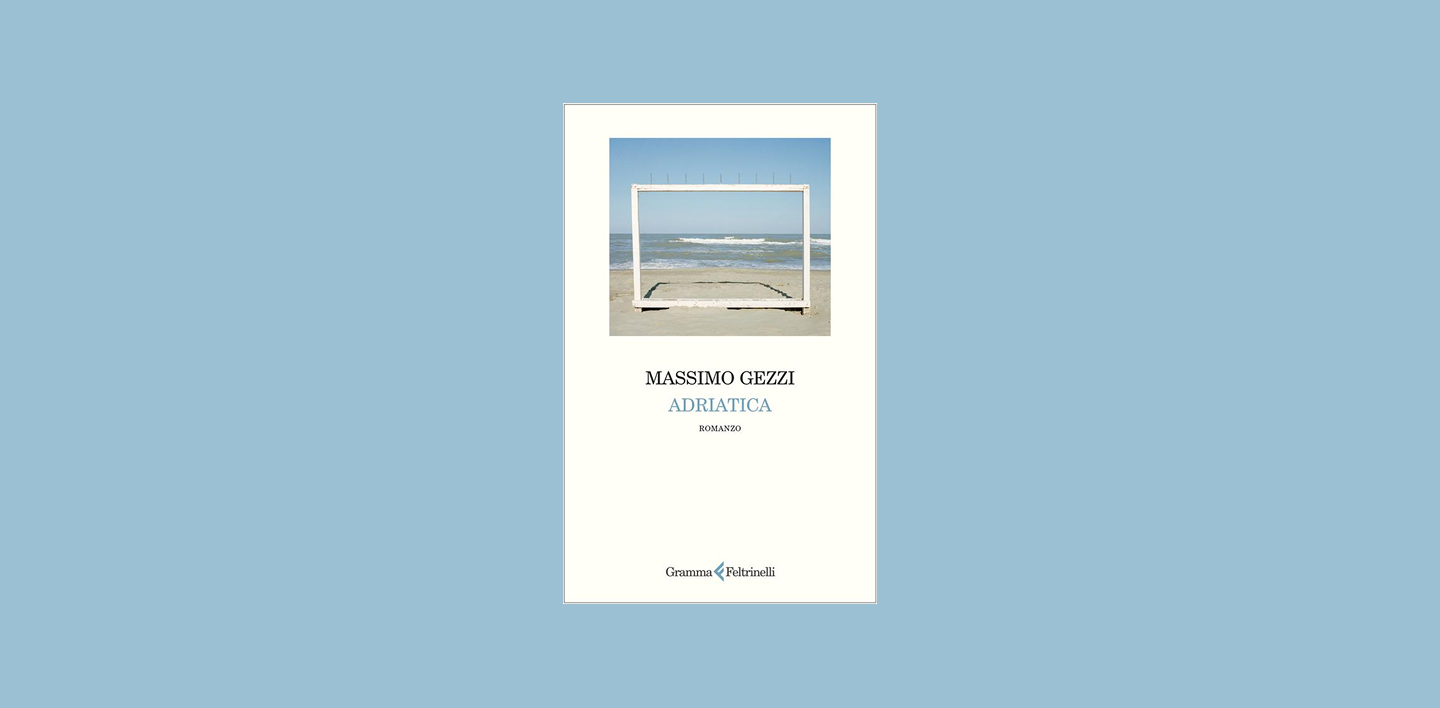
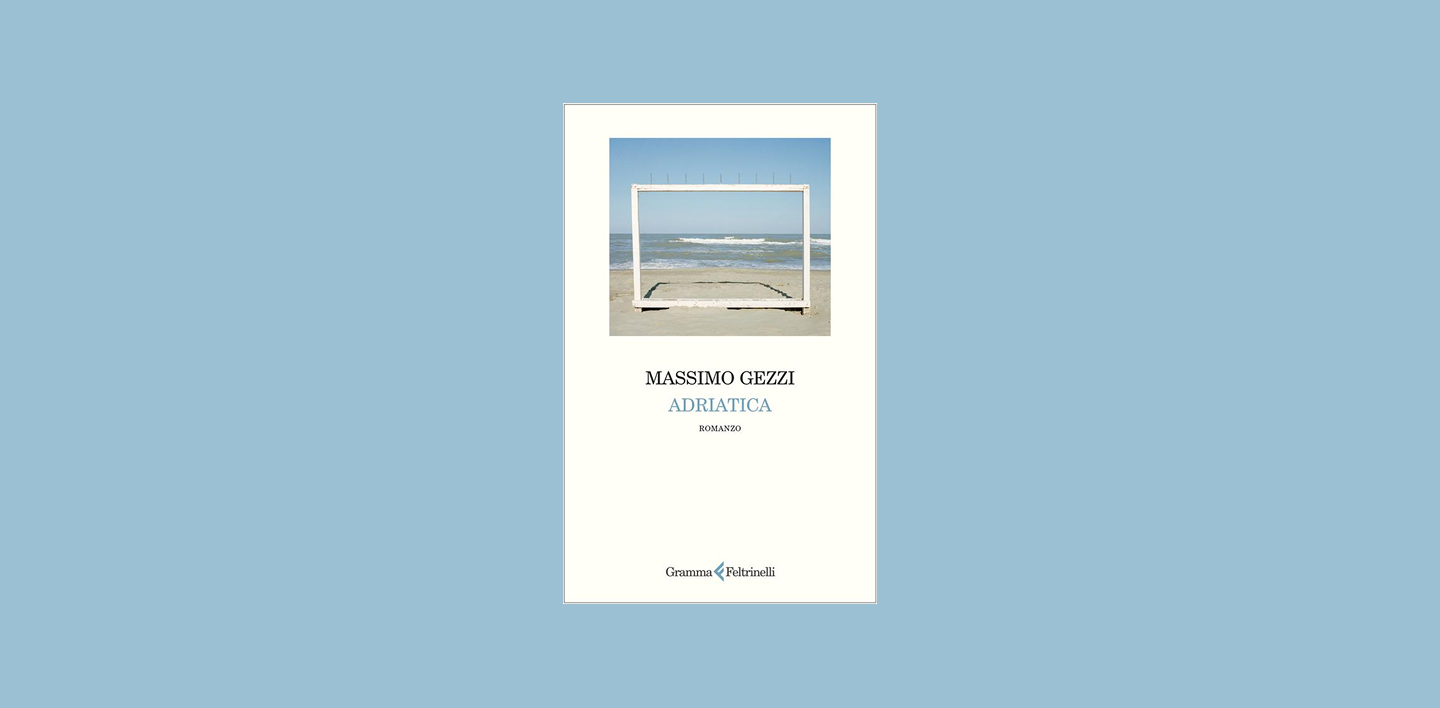
A driatica è una cittadina affacciata sul mare, un luogo estremo, posto là dove le cose sono sempre sul punto di esaurirsi, perdersi e lasciarsi andare. In questa immaginaria cittadina dell’ultraprovincia italiana Massimo Gezzi, critico e poeta, decide di ambientare la storia del suo primo romanzo, un dialogo tra una giovane donna, una ragazzina di nome Emilie e un uomo, non ancora vecchio, ma già destinato alla periferia della vita. Tullio è infatti ormai mal ridotto da sfortuna e inettitudine ‒ come spesso capita ai più maldestri più che ai più colpevoli ‒ a una vita di stenti in via di rapido esaurimento.
Adriatica (2025) è un romanzo invernale, gelato da una forma di asprezza inesauribile che attrae e respinge allo stesso tempo i suoi personaggi. Il loro legame vive fragilissimo su consuetudini e sguardi, incroci casuali eppure ripetuti. Gezzi sembra riprendere un discorso aperto dalla letteratura italiana a fine anni Ottanta e più compiutamente negli anni Novanta, quando ancora l’influsso delle mode e del conseguente hype tutto illusorio e utile solo a generare testi più figli di una sorta di traduttese (se così si può definire) che di un linguaggio originale, non si era ancora così diffuso, imponendosi nella letteratura italiana contemporanea.
Si stacca dunque Massimo Gezzi ‒ con una consapevolezza tipica di chi frequenta la poesia ‒ da una subalternità provinciale che impone anche alla narrativa di vivere all’interno di una bolla fatta di romanzi e romanzetti in cui il luogo comune viene continuamente confuso con un ipotetico centro del discorso. Sfugge dunque dal patetismo della narrativa milanese, berlinese, londinese, newyorchese per ritrovare una forma di onestà anche linguistica proprio ad Adriatica, città che potrebbe essere Riccione come Rimini come San Benedetto del Tronto. Un centro Italia liminale dove la tragedia ridicola di una quotidianità spiccia e dolorante coglie al meglio la tipicità di un territorio al punto da farne non solo uno sfondo, ma il vero protagonista, là dove l’immaginario dell’immaginaria Adriatica si impone nettamente agli occhi del lettore: “Sono le nove, il sole è tramontato da mezz’ora. Il faro ha appena cominciato a lampeggiare e continuerà a farlo per tutta la notte”. Sembra di ritrovare le pagine di Luisa e il silenzio (1997) di Claudio Piersanti. In quel caso una solitudine intransigente si mischiava a una fragilità disperata eppure sempre silenziosa. Là il nord Italia qui invece un centro Italia, entrambi però sempre con pochissima luce e con un notturno obbligato alle ombre delle lampade elettriche e dei neon di centri città semiabbandonati dalle otto di sera in poi.
L’immaginaria Adriatica si trova in un centro Italia liminale dove la tragedia ridicola di una quotidianità spiccia e dolorante coglie al meglio la tipicità di un territorio al punto da farne non solo uno sfondo, ma il vero protagonista.
La faccio ridere ancora, mentre mi sistemo e abbraccio il suo torace sotto il seno, che mi trema sulle dita a ogni movimento che fa. Dalle colline è spuntata anche la luna. E così la sera sembra ancora più bella, ancora più. Nostra. Perché quel pezzo di roccia che fluttua nell’aria è capace di darti l’impressione che stia guardando proprio te, qualche volta.
Il romanzo si muove a due voci, quella di Emilie diretta, in prima persona, sboccata e giovane, aggressiva eppure ancora tanto ingenua e poi quella che descrive l’esistenza monotona eppure sempre più vicina all’abisso di Tullio.
In un tempo di crollo demografico e di crisi delle nascite, con una popolazione sempre più vecchia e in difficoltà, sembrano ribaltarsi i ruoli tipici dell’immaginario letterario italiano. Ora sono i giovani che si prendono cura del passato e non più i vecchi che provano a dare una mano al futuro. Il futuro è infatti privo di reale concretezza, non esiste. Si sta immersi in un presente perenne, faticoso e rumoroso, obbligato ed estremamente incerto. Si fa presto a diventare passato pensando al futuro e così più che gli echi zurlianiani de La prima notte di quiete (1972) qui sembra di sentire il riverbero di un sentimento comune e contemporaneo che porta dritto dritto a Paternal leave (2025) di Alissa Jung. I ruoli sono saltati, i genitori non sono più genitori: non proteggono, non salvano, ma spesso ostacolano anche attraverso un’assenza priva di reali scelte, più o meno consapevoli che siano. L’espressione perenne è quella della bocca spalancata, uno stupore che è rivolto il più delle volte prima che agli altri a sé stessi, sempre così impreparati, sempre così in ritardo.
I ruoli sono saltati, i genitori non sono più genitori: non proteggono, non salvano, ma spesso ostacolano anche attraverso un’assenza priva di reali scelte, più o meno consapevoli che siano.