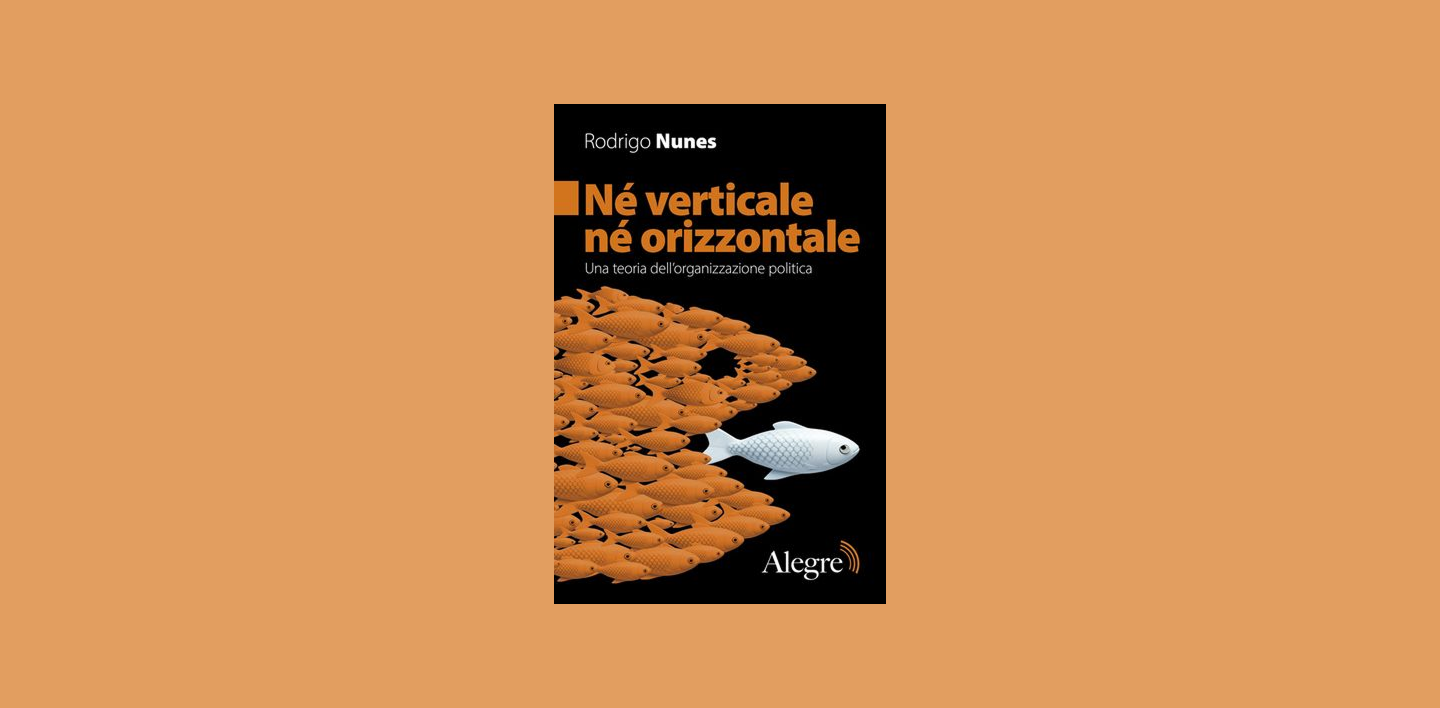
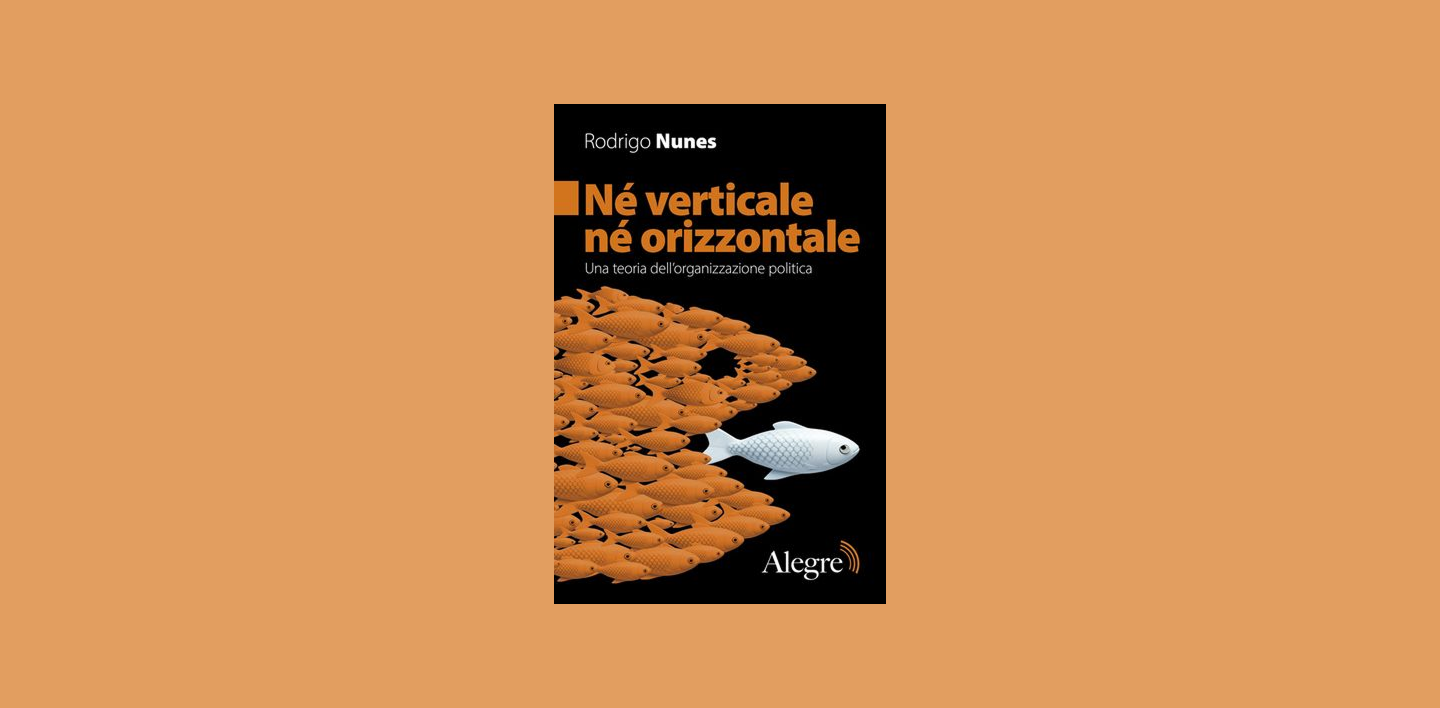
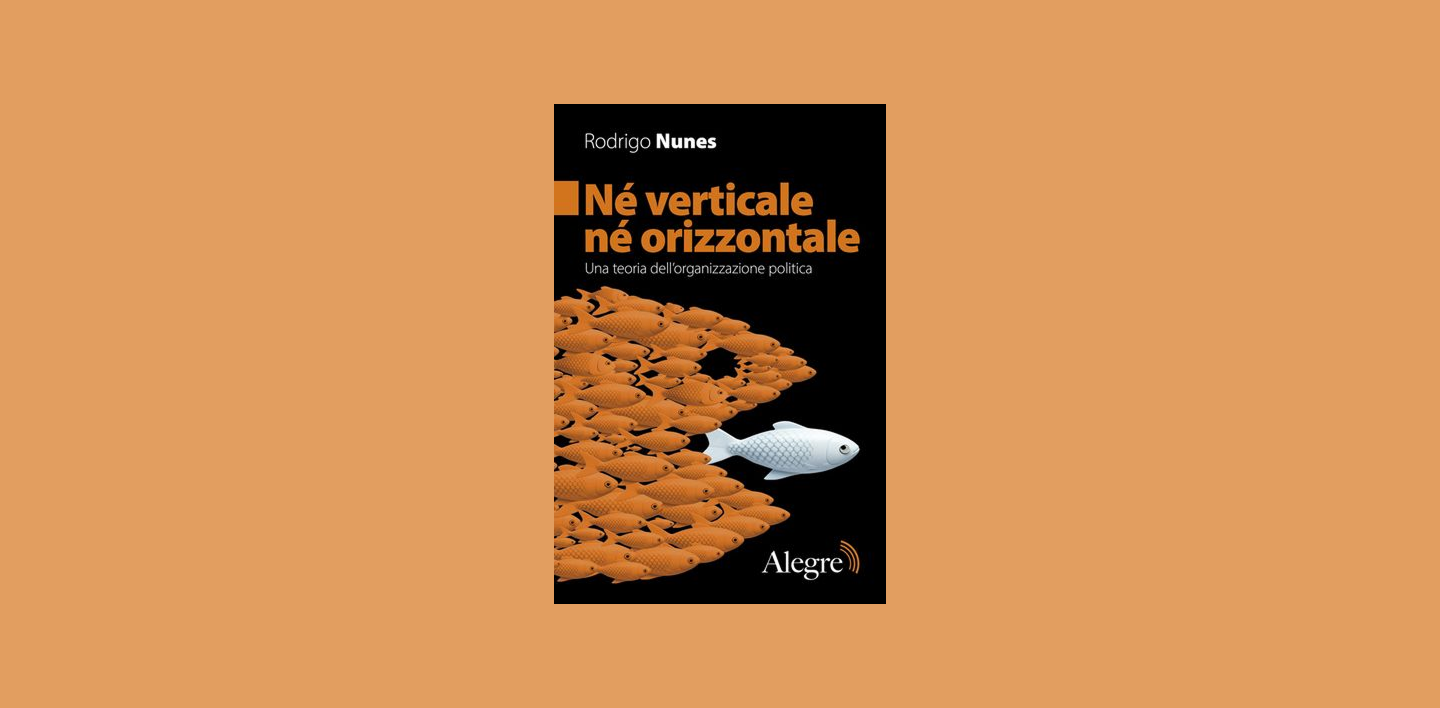
S crivo questo testo mentre nelle piazze italiane – e, a intensità variabile, di altri Paesi europei – divampano mobilitazioni moltitudinarie e scioperi massicci in sostegno alla liberazione del popolo palestinese, segnalando una forte crisi di consenso e di legittimità delle classi dirigenti europee, complici ed ipocrite di fronte al genocidio, ma prone alla corsa generale al riarmo. Potrebbe profilarsi all’orizzonte lo spazio per un’alternativa antifascista ed emancipatrice contro di esse.
Tattiche e pratiche eterogenee, unite via terra e via mare da un unico obiettivo comune, ma indipendenti le une dalle altre – flash mob, blocchi dei nodi logistici dell’invio di armi, boicottaggio delle università e delle aziende israeliane, blocchi delle infrastrutture della riproduzione, disobbedienza civile, aiuti umanitari, mozioni popolari, minuti di silenzio, minuti di urla, digiuno degli operatori sanitari – si rafforzano reciprocamente e si compongono all’interno di un movimento plurale e diversificato.
Già nel triennio 2019-2022, anche il movimento per la giustizia climatica – non a caso oggi “confluito” nel movimento di solidarietà internazionalista pro-Pal – aveva saputo combinare pratiche differenti all’interno di una lotta politica, poi polverizzata dalle impasse della congiuntura di guerra successiva al 25 febbraio 2022. Le “fiammate” degli ultimi mesi non sarebbero certo possibili senza il lavoro costante e paziente di collettivi, sindacati e associazioni che, da molti decenni e negli ultimi due anni, hanno tenacemente insistito sulla lotta al fianco della Palestina, anche quando le manifestazioni rimanevano isolate, scarsamente partecipate e quando su di esse calava lo stigma dell’antisemitismo, nell’ambiguità e nei silenzi dei cosiddetti progressisti.
La potenza accumulata nelle piazze dovrà ora costruire una propria continuità, coniugando l’allargamento con la capacità organizzativa, nella speranza di incidere sul lungo periodo e nella consapevolezza che in Palestina si consuma, accelerandola, una tappa di una tendenza imperialistica alla conquista militare di territori e risorse, sostenuta dalla riconversione bellica delle economie mondiali.
La potenza accumulata nelle piazze dovrà ora coniugare l’allargamento con la capacità organizzativa, nella consapevolezza che in Palestina si assiste a una tendenza sostenuta dalla riconversione bellica delle economie mondiali.
La diagnosi di Nunes muove dall’evanescenza dello straordinario ciclo di mobilitazioni globali del 2011 contro l’austerity e la rendita finanziaria, defluito velocemente, incapace di costruire una durata all’interno delle piazze occupate, indifeso di fronte alla torsione reazionaria e securitaria che gli si è poi contrapposta. La sua sensazione – scrive – è quella di aver mancato una grande e storica opportunità nel 2011, da cui è poi derivato un progressivo ridimensionamento dell’orizzonte e un senso di impotenza collettiva. Non a caso, nel decennio successivo, da più parti sia a livello teorico sia a quello pratico, è stata riproposta la questione dell’organizzazione, dell’articolazione e della durata. Da angolature eterogenee, irriducibili e talvolta in contrasto tra loro, si è discusso negli ultimi anni di “crisi dell’immanenza” e di “istituzioni plebee” (da una prospettiva neomachiavelliana), di “auto-affezione mediata della moltitudine” e di “effetto di trascendenza nell’immanenza” (da una prospettiva neospinoziana), di “insurrezione democratica” e di “dualismo di potere” (da una dichiaratamente neomarxista).
L’esigenza del nostro tempo, approfondita certo dalla crisi della pandemia e dalla dispersione che ne è succeduta, pare quella di “articolare” quei termini che, in altre epoche storico-filosofiche, sono stati invece separati: natura e politica, immanenza e trascendenza, orizzontale e verticale, unità e molteplicità, insurrezione e democrazia, autonomia ed egemonia, micropolitica e macropolitica. La gradazione di questo dosaggio, nonché la concettualità più idonea a esprimerla, resta questione viva e aperta, discutibile più nella pratica che nella teoria. Ed è all’interno di questo dibattito, che si colloca il libro di Nunes, redatto proprio tra la fine degli anni Dieci e la pandemia da Covid-19.
Per l’autore è necessario “pensare all’organizzazione come a un’ecologia”, in cui tutte le componenti, ciascuna nella sua autonomia, condividono un medesimo ambiente e possono così plasmare e favorire il campo d’azione delle altre.
Da un lato, all’interno di questa ecologia organizzativa, non vige un’orizzontalità piatta ed esasperata che annulla ogni differenza (di posizione oggettiva nella struttura sociale e di preparazione politica soggettiva) tra i nuclei, bensì vi sono prevalenti che possono (e devono) assumere la funzione di avanguardia in una data congiuntura e punti strutturalmente significativi della totalità sociale (alcuni più di altri) che possono destabilizzare il sistema. Dall’altro lato, di fronte ai limiti dell’orizzontalismo e dell’assemblearismo, non è certo sufficiente richiamare la necessità di un’ecologia organizzativa maggiormente articolata e integrata, ma vanno affrontanti anche tutti i limiti che, sull’altro versante, la dimensione organizzativa ha mostrato nel corso del Novecento, attirando su di sé sospetti e critiche.
Nunes vuole dunque offrire una terapia filosofica al cosiddetto trauma dell’organizzazione: se per Nunes tale paura dell’organizzazione è storicamente legata alla torsione autoritaria dei Paesi socialisti, l’inclinazione identitaria dei vari gruppi della sinistra radicale alle nostre latitudini ha perpetuato quel trauma anche tra le più giovani generazioni. Si può allora ripensare l’organizzazione non come la cristallizzazione di un’identità omogenea, da difendere dalle minacce esterne, ma come l’assemblaggio di parti molteplici in una potenza collettiva e la concentrazione di questa potenza su dei punti strategici condivisi. Obiettivi comuni e strategia condivisa segnano dunque un perimetro entro cui tattiche e “anime” differenti possono non solo coesistere, bensì arricchirsi reciprocamente: convergere. Per quanto nell’astrattezza di un libro teorico – il metodo di Nunes suggerisce il netto realismo di partire dalle forze già esistenti e dalla pratica dell’obiettivo comune.
All’interno di un’ecologia organizzativa, l’agire politico viene concepito nei termini dell’azione distribuita. Non si tratta né di un’azione aggregata, quella che viene spontaneamente ripetuta da molti soggetti senza alcun tipo di coordinamento, né di strategia comune, né di un’azione collettiva, pianificata intorno a un centro decisionale che ne stabilisce modi e tempi dell’esercizio. A lato di questi speculari eccessi – eccesso di dispersione e differenze non coordinate da un lato, di centralizzazione verticistica dall’altro – l’azione distribuita è promossa da un nucleo della rete e assunta dagli altri nuclei, ciascuno secondo le proprie caratteristiche, scale e temporalità, che in questo modo integrano e modificano lo stimolo iniziale.
Nunes non si abbandona a fantasticherie sulla creazione di una “nuova organizzazione”, ma, con un approccio mirabilmente pragmatico, è piuttosto impegnato a ripensare relazioni più virtuose ed efficaci tra le organizzazioni già esistenti.
Porre il focus sull’azione distribuita permette di partire non da quel che ci dovrebbe essere, ma da quel che c’è già, un irriducibile dato di pluralità ecologica, e sottoporlo alla disamina dei nostri obiettivi, non delle nostre identità. Effettivamente, nelle dinamiche “orizzontaliste” del movimento, i nuclei spesso si chiudono risentiti in sé stessi quando un altro prende l’iniziativa senza previo avviso e consenso di tutti gli altri, o senza averne prima discusso insieme, e così si perdono lo spazio di opportunità e “traducibilità” che quella ha aperto. O, altrettanto spesso, i vari collettivi competono nella gara a chi per primo promuove un’iniziativa, invece di concentrarsi sulla possibile moltiplicazione e risonanza che ogni azione genera. L’azione distribuita vorrebbe dissolvere questa competizione identitaria e il tic – tipico di una condizione di impotenza – di accusarsi o sfidarsi l’un l’altro.
Di fondo, l’orizzontalismo prevederebbe, nel suo ideale, che ogni decisione venga presa nell’assemblea generale alla presenza di tutte e tutti. Il principio (sano) della massima condivisione e allargamento scade nella tendenza (malsana) a rimandare le decisioni all’infinito, quando tutte/i sono presenti e vi è il tempo di discutere di tutto. Questo feticismo della presenza e sete di inclusività illimitata riproduce, secondo la critica di Nunes, quel principio di trascendenza della sovranità contro cui vorrebbe invece battersi. La presenza di tutte/i in assemblea configura infatti un’entità trascendente e separata, come se fosse qualcosa di superiore alle relazioni che la creano, che deve continuamente difendersi dalle minacce (esterne e interne) e affermare il proprio potere decisionale (fosse anche, per esempio, la decisione della data di un’iniziativa pubblica) nello spazio dell’ecologia con gli altri nodi.
Come si organizzano insieme i vari nuclei, senza fare assemblea sempre tutte/i insieme? Pare questa dunque una domanda che il libro ispira, senza darvi una risposta esaustiva. O – per slittare dal “come” al “chi”, sebbene non sia certo un passaggio lineare – chi articola l’ecologia e il processo convergente? Domande che reinterrogano la necessità di una mediazione capace di tessere e articolare insieme i differenti nuclei. Nunes distingue una mediazione come forma da una mediazione come forza, e optando per questa seconda, si distanzia dalle posizioni che vorrebbero elevare una certa forma (il partito) o un certo simbolo a cerniera tra le varie parti in gioco. La mediazione non è più concepita come una sintesi superiore tra due termini contrari, bensì come un equilibrio metastabile tra forze molteplici, variabile a seconda della situazione in cui si trova ad agire, che conserva tutte le forze in gioco in una certa proporzione.
Come in fisica due forze A e B che premono in direzioni opposte non si negano l’un l’altra, ma possono coesistere in un punto di equilibrio, allo stesso modo un’organizzazione politica non è chiamata a scegliere tra un picchetto, un comizio, uno spazio sociale o una petizione parlamentare, bensì può combinare differenti espressioni di una lotta a seconda delle condizioni date. “Se non è possibile avere tutto insieme (massima identità e massima apertura, massima centralizzazione e massima democrazia, massima autonomia e massimo coordinamento…), è necessario averli in misure diverse e in punti diversi, bilanciati a seconda delle esigenze dell’occasione” (p. 107).
Nunes vuole offrire una terapia filosofica al cosiddetto trauma dell’organizzazione: se tale paura è storicamente legata alla torsione autoritaria dei Paesi socialisti, l’inclinazione identitaria dei vari gruppi della sinistra radicale ha perpetuato quel trauma anche tra le più giovani generazioni.
“Pensare davvero le proprie azioni in termini ecologici – secondo Nunes – significa essere meno aggrappati alla propria immagine di sé” (p. 221): vale a dire, più concentrati sulle proprie funzioni che sulle proprie posizioni identitarie, e agire tenendo conto degli altri nuclei della rete, proponendosi di creare vantaggi e opportunità gli uni per gli altri. Le azioni molteplici possono rafforzarsi reciprocamente: la “differenziazione funzionale” è uno dei principi di un’ecologia, in cui ci sono diversi e vari ruoli (il rebel, azione diretta e conflitto; l’organiser, l’organizzatore politico; gli helpers; gli advocates, o figure istituzionali) e in cui maggiore è la differenziazione e la specializzazione dei singoli nuclei, più l’ecologia si espande ed è in salute.
La concezione di mediazione come distribuzione equilibrata di forze non risolve, nel libro di Nunes, interamente la questione del coordinamento strategico tra le varie parti: chi coordina, se certo il coordinamento non può darsi spontaneamente, ma nemmeno può farlo un’assemblea costante di tutte le parti in gioco? Un nucleo tra gli altri dell’ecologia? Un nucleo separato dell’ecologia, deputato a questa funzione? Come si forma quell’unità di azione strategica tra nuclei che tendono alla dispersione? Un mancato chiarimento di questi interrogativi ha reso spesso precarie le ecologie che abbiamo visto formarsi. La riflessione di Nunes mette per lo meno sulla strada giusta. Cinque indicazioni, in particolare, possono essere ricavate.
1) In primo luogo, una critica dell’immediatezza, tanto delle filosofie che la sostengono, quanto di quelle pratiche che la rivendicano. Se oggi è sempre più comune affermare il primato delle relazioni (la posizione teorica secondo cui ogni ente è costituito dalle sue stesse connessioni e soltanto nelle relazioni possa esistere, esprimersi o trasformarsi) contro ogni sostanzialismo ed essenzialismo, questa posizione spesso coesiste con una forte richiesta di immediatezza: l’idea secondo cui tutte le mediazioni debbano essere eliminate e che le differenze e le singolarità debbano esprimersi così come esistono “di per sé”. Si tratta di due posizioni inconciliabili. In virtù del fatto che ogni azione ed espressione è una composizione di molteplici parti, vincolate le une alle altre in un qualche punto di equilibrio, la struttura di questi “vincoli” determina una mediazione che connette le parti tra loro ma, al tempo stesso, le limita. Non è possibile collocarsi all’interno di un’ecologia e, insieme, rivendicare la piena e istantanea espressione di sé (che sia in una chat, in un coordinamento o in un’azione). Concepirsi come parzialità significa accettarsi come parzialità, rinviare la propria espressione ai momenti e alle forme adeguati agli altri termini della relazione. Un eccesso di immediatezza determina un sovraccarico del sistema e, con esso, un effetto di entropia non desiderato. L’ecologia è quella mediazione che espande e arricchisce l’essere delle sue parti soltanto se queste ne accettano i limiti. Ne deriva quella che potremmo riassumere come la “positività del limite”: si rinuncia a una libertà parziale e immediata, per conquistare una forza maggiore. L’autolimitazione reciproca delle parti di un’ecologia è quella pratica su cui si gioca l’efficacia di una struttura: la capacità di valorizzare e non di reprimere la massima forza di ciascun nucleo che ne fa parte.
All’interno dell’ecologia convivono più risposte possibili: se si pensa che esista una sola risposta si compete contro gli altri nodi al fine di estirpare le false alternative; se si ammettono più soluzioni possibili, si è meno incentivati a competere e più a cooperare.
3) Egemonia e cura, spinta e ascolto, non sono necessariamente pratiche alternative, ma possono combinarsi all’interno di relazioni ecologiche. Ogni attore può esercitare legittimamente il massimo di egemonia di cui è capace sugli altri nuclei, ossia il proprio potere di influenzare il corso dell’ecologia, ma al tempo stesso prendersi la massima cura di non metterla a repentaglio. Da un lato, qualunque spinta deve andare nella direzione dell’obiettivo comune e sostenere il processo, senza ambire a controllarlo interamente. Dall’altro, si riconosce l’egemonia – con la correlata “funzione” di leadership – come un aspetto ineliminabile della politica. Dare avvio a un comportamento collettivo ed “essere seguiti” non si traduce nella volontà di costringere gli altri a fare una cosa, ma in quella di moltiplicare la potenza collettiva su dei punti di lotta specifici, concentrati e non eccessivamente dispersi (qui la differenza tra funzione-di-leadership e posizione-di-leadership). Spingere i nuclei di un’ecologia verso un’azione fa parte di un’ecologia in salute, attraversata da inevitabili tensioni interne, quando questo non è finalizzato alla riproduzione di un’identità, ma alla concentrazione della potenza collettiva su qualche punto strategico, e si accetta che la propagazione di quell’azione non sia interamente allineata all’input iniziale.
4) Partito ed ecologia organizzativa non sono la stessa cosa. Il partito non rappresenta né la totalità dell’ecologia, la riunione di tutte le istanze, né la forma più avanzata della coscienza (e dell’organizzazione) della molteplicità. Nunes rinuncia a queste concezioni tradizionali del partito e lo circoscrive a una funzione per lo più comunicativa: il partito come megafono mediatico, dedito alla necessità di influenzare un’opinione pubblica esterna ai circuiti dell’attivismo, all’occupazione degli spazi mediatici mainstream, ad articolare interessi differenti in un’identità comune al di là di quelle già esistenti, e dunque a guadagnarsi il sostegno di quelle parti di società non politicamente attive.
Il partito raccoglie le istanze dei nuclei dell’ecologia, riceve da questi direzionalità strategica con apertura e flessibilità, al pari di ogni nucleo dell’ambiente condiviso, ma ciò che lo distingue dagli altri è la funzione precipua di comunicare quelle istanze all’esterno dell’ecologia, nei settori non-organizzati, dunque di fare mediazioni tra settori differenti e ottenere consensi trasversali. Non significa che questa funzione sia svolta solamente e interamente dal partito, ma che il partito ha questa come funzione principale, in un quadro di distribuzione delle funzioni sopra menzionato. Nunes esce dunque dallo schema tipico di un certo pensiero della sinistra radicale, quello della “verticalizzazione”: non si tratta di verticalizzare le lotte sociali nel campo della rappresentanza, ma di amplificarle nel campo della lotta mediatica e ideologica e di permettere così che queste crescano e diano maggior forza al partito stesso.
Non si tratta di verticalizzare le lotte sociali nel campo della rappresentanza, ma di amplificarle nel campo della lotta mediatica e ideologica e di permettere così che queste crescano e diano maggior forza al partito stesso.
5) Separare interno ed esterno non pare più realmente possibile, né tanto meno utile: isolare un soggetto politico dall’ambiente esterno, o pensarlo come sovrano di quello spazio (imperium in impero) e capace di plasmarlo interamente, è fallace e illusorio. Un sistema è sempre trasformato e modificato dalle informazioni e dagli stimoli esterni. Auto-organizzazione è sempre, in parte, etero-organizzazione, se una molteplicità di elementi all’interno di un ambiente condiviso si influenzano gli uni con gli altri, aprendo o limitando il campo di possibilità degli altri. Ne risulta che l’organizzazione sia sempre un dosaggio contingente e variabile, a seconda della congiuntura, di auto- ed etero-organizzazione, non la prevalenza di un termine sull’altro. Lo spinozismo di cui abbiamo bisogno oggi ci mostra proprio questa reciprocità del dentro e del fuori: molteplicità ed eterogeneità sono punti di forza se articolate all’interno di un dispositivo di etero-determinazioni reciproche, in cui ciascuna parte è al tempo stesso arricchita e limitata dalle altre.