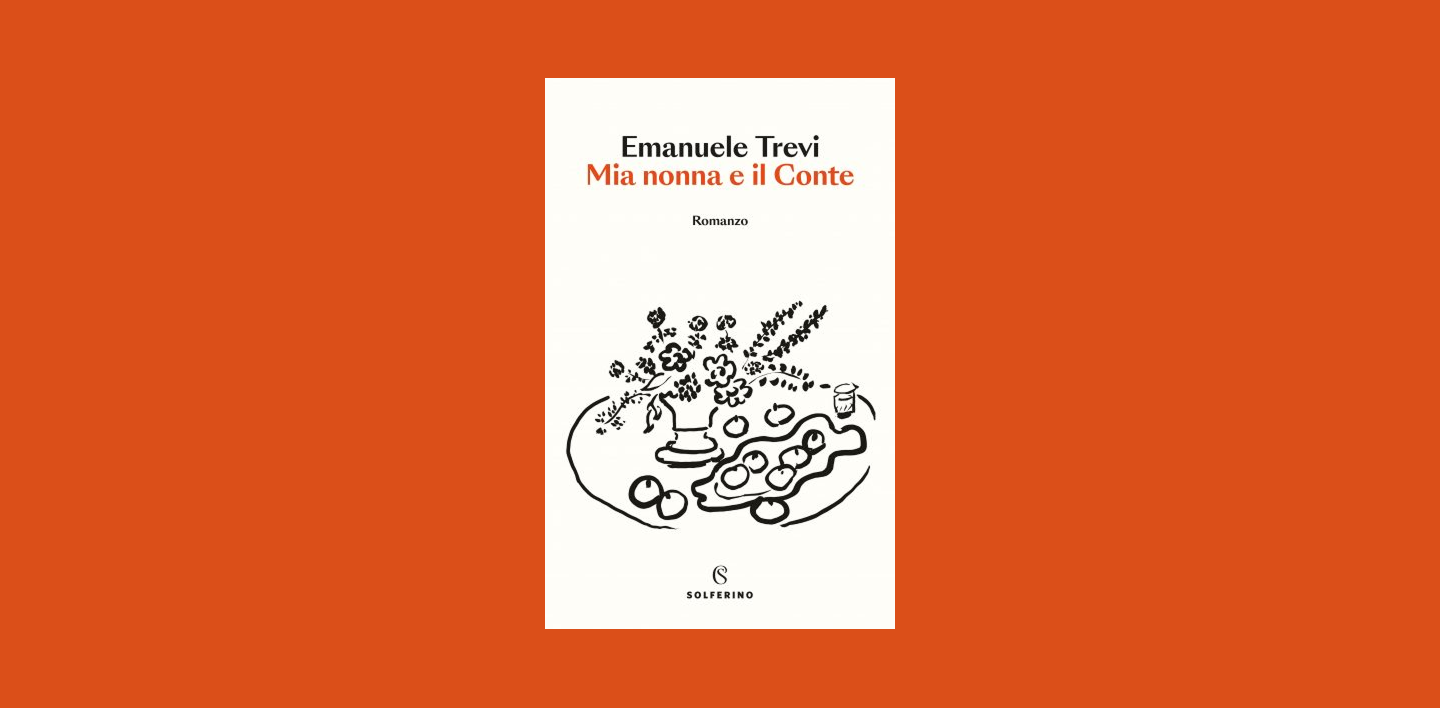
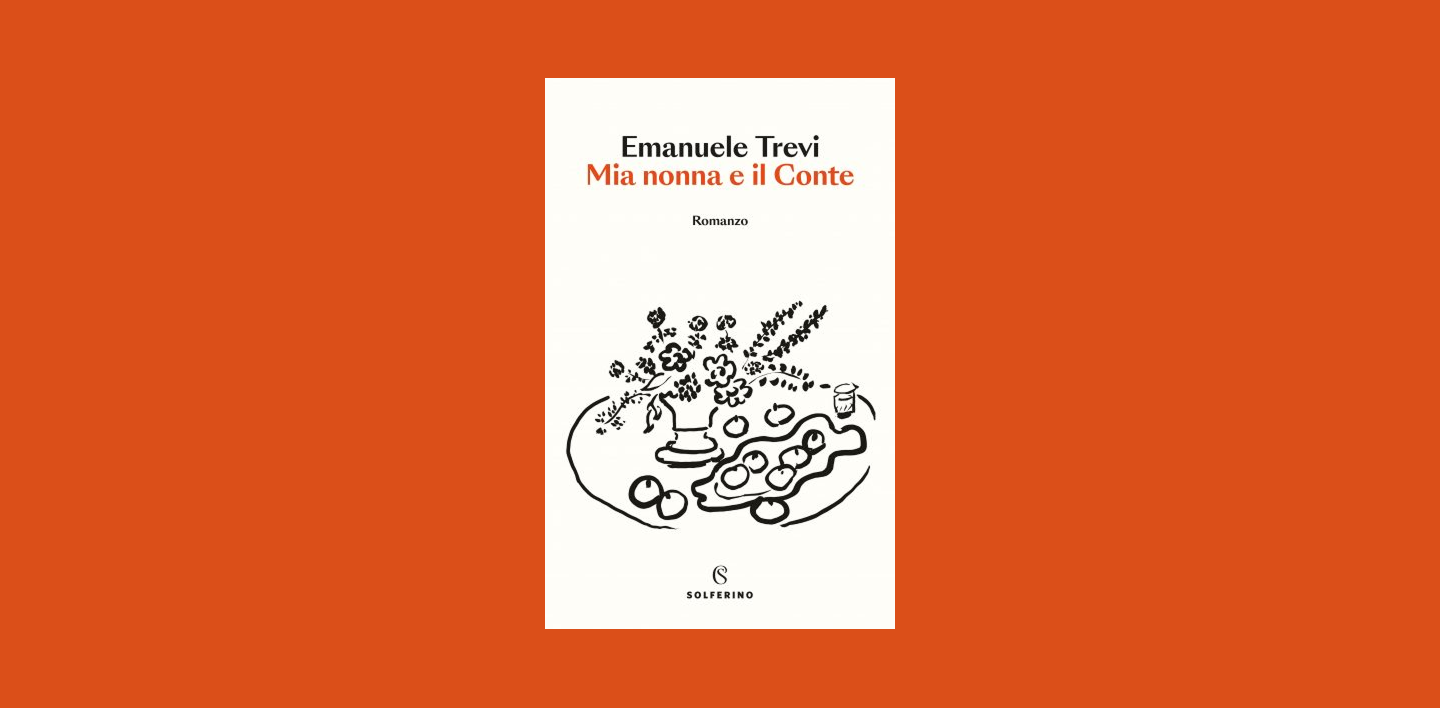
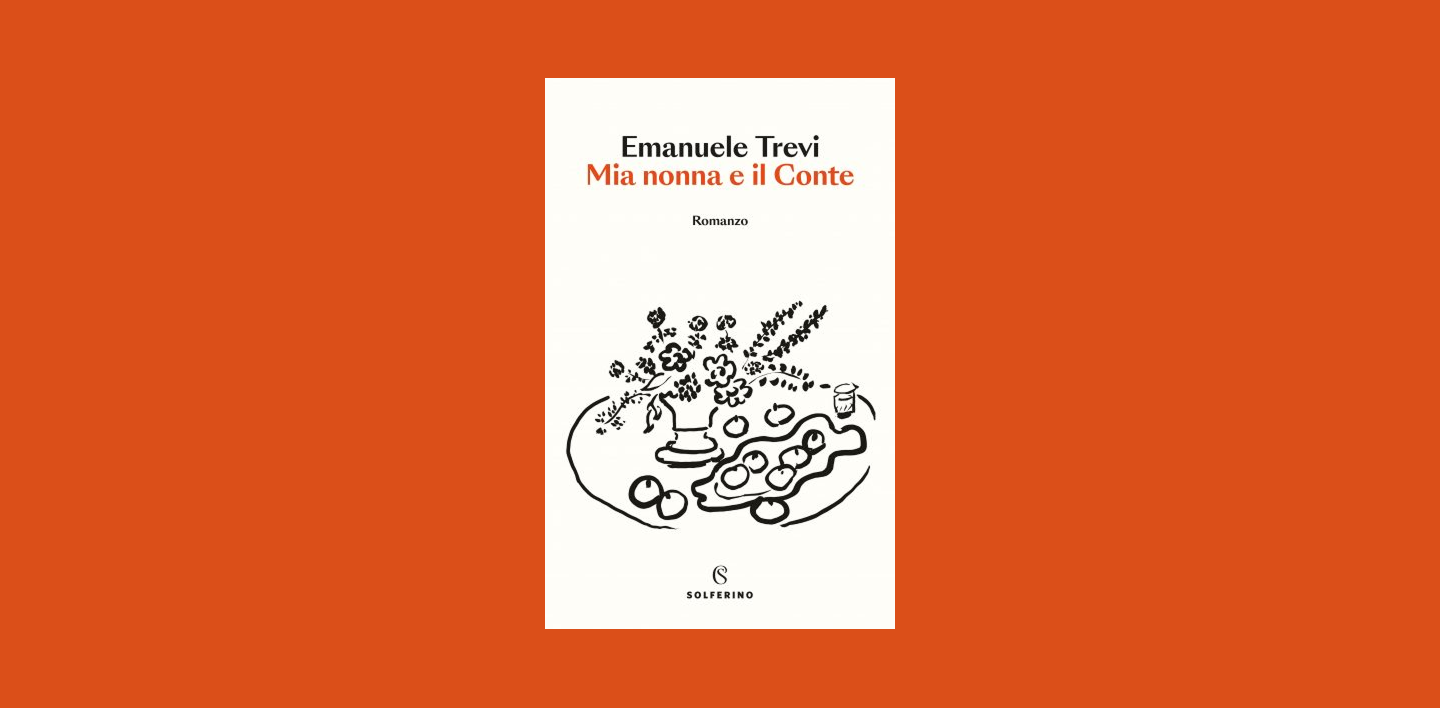
C ome spesso accade nei suoi libri, i ricordi per Emanuele Trevi assumono la forma del sogno e le memorie divengono un corpo vivo da scoprire e riconoscere pagina dopo pagina. Un corpo pienamente e solidamente letterario che abbandona rapidamente i confini ristretti dell’autobiografia e del reale per incamminarsi in uno spazio aperto al tempo stesso intimo e universale. Un luogo in cui reale e fantastico s’intrecciano senza alcun obbligo reciproco, dando forma a personaggi assoluti, mai stereotipati o semplificati e che si distaccano però inevitabilmente dalle figure reali divenendo potentemente personaggi letterari e quindi più veri del vero, in quanto portatori di segni indistinguibili, ossia quelli di un tempo finito e chiuso che offre però ancora un aggancio possibile. Un’universalità riconoscibile utile a liberare dall’angosciosa solitudine contemporanea.
Emanuele Trevi da sempre fa letteratura partendo dal proprio sé, da un’elaborazione comune della propria memoria percepita, che diviene così un campo del possibile totalmente rinnovato e sempre rinnovabile. Uno spazio letterariamente aperto e un luogo di condivisione e relazione che si muove tra gli elementi del ricordo. Dall’estate romana con Senza verso. Un’estate a Roma (2004), a Pier Paolo Pasolini e Laura Betti con Qualcosa di scritto (2012). E poi Cesare Garboli con Sogni e favole (2018) e infine Pia Pera e Rocco Carbone con Due vite (2020) solo per citare quelli che sono considerati i suoi libri più importanti, anche se probabilmente il testo che più contiene ‒ quasi fosse un manuale ‒ la poetica di Trevi è Viaggi iniziatici (2013-2021), un vero e proprio compendio dei riti di passaggio dello scrittore contemporaneo, tra scoperte, ingenuità e grande letteratura.
Emanuele Trevi da sempre fa letteratura partendo dal proprio sé, da un’elaborazione comune della propria memoria percepita, che diviene così un campo del possibile totalmente rinnovato e sempre rinnovabile.
Mia nonna e il Conte è un romanzo rapido, poco più di un centinaio di pagine, il racconto è quello di un autunno della vita lungo e luminoso, gratuito e splendido. Al centro spicca un giardino, protagonista della casa della nonna, collocata in un paesino calabrese poco lontano da Capo Palinuro. Il giardino è un luogo magico e di passaggio, lì Trevi trascorre gran parte delle sue giornate all’ombra di una nonna che appare millenaria, come una Grande Madre da cui tutto proviene. Una personalità totale e capace di ammaliare come una figura sacra o un oracolo. Dal giardino provengono gli odori e una vista sul mare che appare improvvisa e anch’essa vergata da magia. Come in un trucco perfettamente riuscito Trevi riporta ai lettori la sensazione di cosa è un giardino, rendendolo rappresentativo di un modo di vivere, di vedere e di percepire la realtà estremamente originale e al tempo stresso riconoscibile negli oggetti e nei luoghi che chiunque porta con sé nella propria personale memoria. Più figlio che nipote, Trevi ritrae con brevi tratti la figura della nonna dando corpo a una corte di parenti e compaesani degna di Vitaliano Brancati: “Come tutte le dee, troneggiava in compagnia di un suo fedelissimo seguito femminile, nel quale spiccavano due figure praticamente inseparabili da lei: zia Delia e Carmelina”.
Il giardino è un luogo magico e di passaggio, lì Trevi trascorre gran parte delle sue giornate all’ombra di una nonna che appare millenaria, come una Grande Madre da cui tutto proviene. Una personalità totale e capace di ammaliare come una figura sacra o un oracolo.
Le giornate passano così lentamente fino a quando il giardino diviene il luogo di un amore tanto esplicito quanto delicato; a coglierlo è Trevi in quella presenza ‒ che diviene quotidiana ‒ del Conte sotto il segno di una solarità che rifrange atmosfere proustiane, ma che in parte riporta alla memoria anche Peter Pan nei Giardini di Kensington di J.M. Barrie, là dove proprio il Conte appare proprio un Peter Pan ideale. Quello che corrisponde tra i due anziani, la nonna e il Conte, è infatti un amore pienamente e totalmente giovane, una lezione di volo non fuori tempo massimo, ma in un tempo nuovo e come tale carico di ardimento e meraviglia: “a loro non mancava nulla: come solo può accadere a chi sa essere reciprocamente gratuito, com’è gratuito, mettiamo, un bel pomeriggio tiepido e lucente d’autunno”.
Settembre è il tempo del loro incontro ed è anche il tempo della formazione di un autore, Emanuele Trevi che come racconta nel libro, allora quasi ventenne provava ancora a distanziarsi dagli altri ricercando un peso e una profondità diversa e solitaria. Un’originalità che fosse densa di un sapere urgente e necessario, una pretesa che franò però di fronte all’evidenza di una bellezza naturale e spontanea che gli farà comprendere ‒ anche grazie alla nonna e alla sua leggiadra corte di amiche e parenti ‒ il valore del tempo perso così come della chiacchiera priva di peso e valore apparente.
Quello tra i due anziani, la nonna e il Conte, è un amore pienamente e totalmente giovane, una lezione di volo non fuori tempo massimo, ma in un tempo nuovo e come tale carico di ardimento e meraviglia.