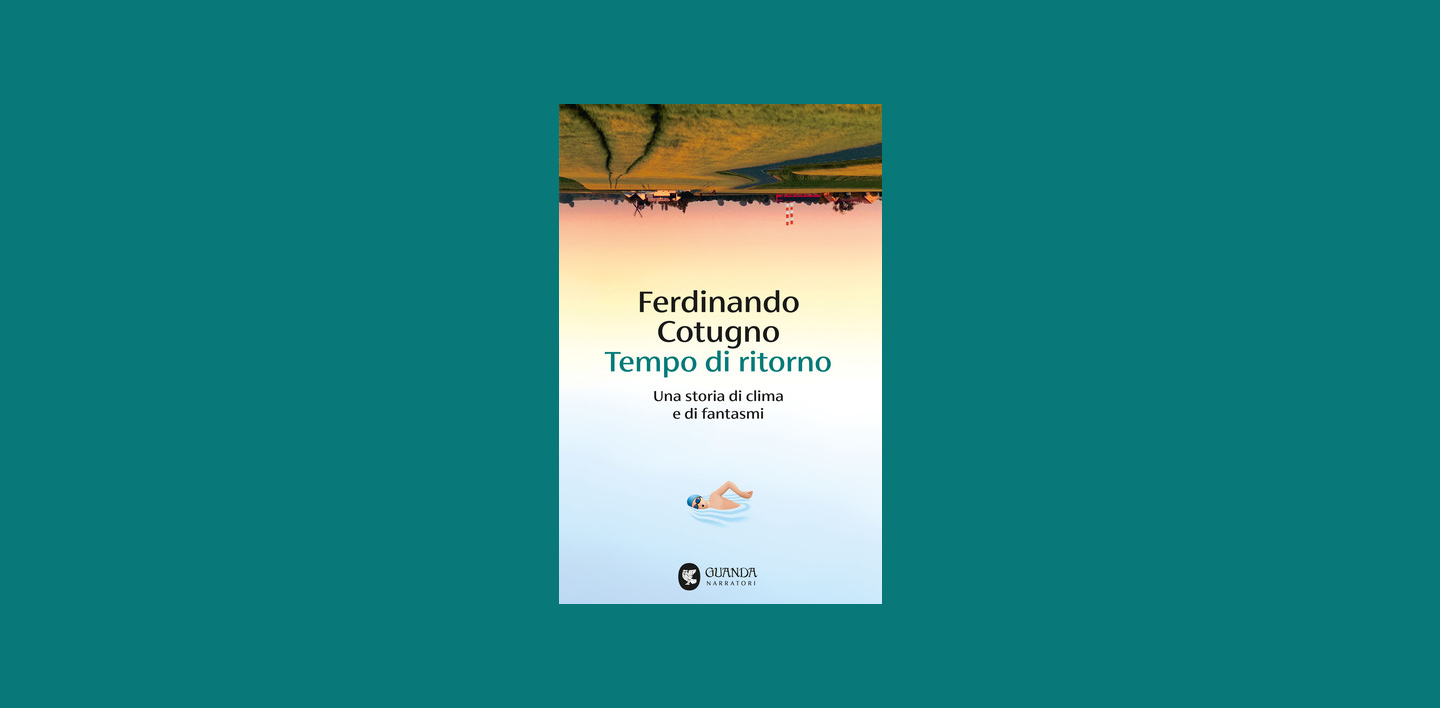
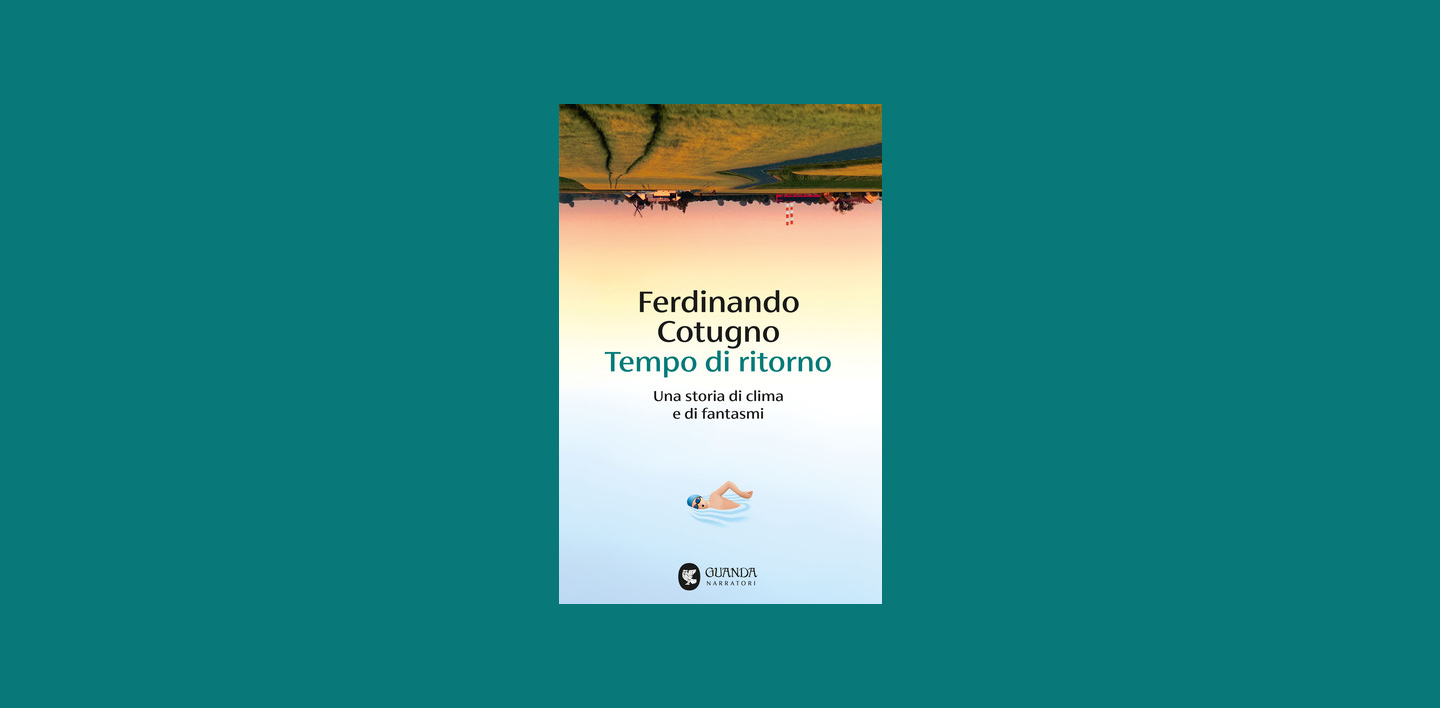
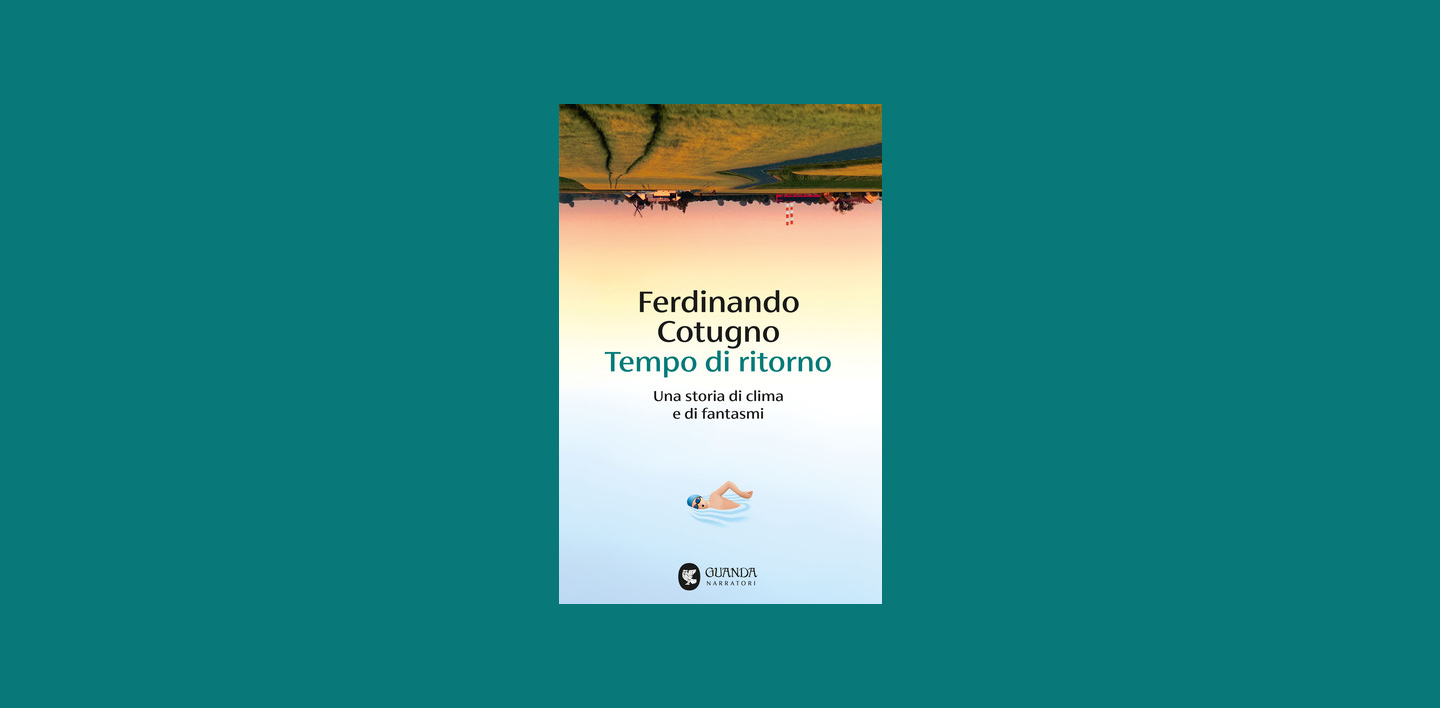
C ome si racconta il cambiamento climatico? Già nel celebre saggio del 2016 La grande cecità, lo scrittore indiano Amitav Ghosh si interrogava sulle responsabilità della letteratura nel mettere adeguatamente in luce le trasformazioni ambientali, psicologiche, culturali e politiche indotte da un fenomeno la cui portata non può che riverberare sui protagonisti di una storia. Questa sfida non è un mero esercizio intellettuale, ma rappresenta uno dei piani fondamentali su cui attivare la risposta collettiva a un problema che ancora oggi tende a essere rimosso dal discorso pubblico. Consideriamo anche soltanto come spesso la questione climatica venga ritratta come un’emergenza puntiforme – si pensi alla metafora della cometa in rotta di collisione col pianeta del popolare Don’t look up del regista Adam McKay ‒ e non come qualcosa in atto da tempo, i cui effetti non sono sempre stati percepiti con la stessa nitidezza da tutte le epoche e latitudini.
Tempo di ritorno. Una storia di clima e di fantasmi (2025), l’ultimo libro del giornalista climatico Ferdinando Cotugno, adotta invece una chiave di lettura efficace grazie a un approccio controintuitivo. Per rendere visibile e comprensibile un fenomeno globale, si concentra sul particolare: la storia della sua famiglia. Tre generazioni (nonni, genitori, figli) che diventano unità di misura del cambiamento climatico.
In statistica, il tempo di ritorno è il tempo medio che corre tra il verificarsi di due eventi di uguale intensità. Il tempo di ritorno è quanto ci mettono a tornare i grandi traumi, o le crisi epilettiche, o gli amori, o gli scudetti, o gli attacchi di panico, o i messaggi che disperatamente aspettiamo, o i temporali, o le ondate di calore, o le alluvioni. Funziona così: immaginate il giorno climaticamente peggiore della vostra vita. Quanto tempo ci vorrà prima vi ricapiti un giorno altrettanto brutto? È questo il tempo di ritorno, regolato dalle leggi del cosmo e della fortuna. La generazione dei miei genitori e quella dei loro genitori ha iniziato ad alterare queste leggi, con la combustione delle fonti fossili di energia.
Per raccontare la crisi climatica Cotugno adotta un approccio controintuitivo ma efficace. Per rendere visibile un fenomeno globale, si concentra sul particolare: la storia della sua famiglia.
Ogni storia familiare è smisurata e contiene l’intera umanità. Abbiamo una sola opportunità di raccontarla, e non dovremmo sprecarla. Io la mia voglio usarla così, per cercare l’inizio della crisi climatica, l’Antropocene familiare.
L’operazione narrativa è molto a fuoco: raccontare di sé e delle generazioni che lo hanno preceduto consente all’autore di connotare emotivamente cause e conseguenze del cambiamento climatico, rendendole più urgenti di quanto la sola restituzione giornalistica o scientifica riescano a fare. Se il problema viene rimosso proprio perché fatichiamo a credere che ci riguardi, è allora attraverso delle storie esemplari a cui molte persone possono facilmente connettersi e riconoscersi che il cambiamento climatico può tornare al centro della nostra attenzione. Tempo di ritorno corrobora la razionalità scientifica lavorando sul percepito umano: ritrae volti e luoghi familiari, rendendo prossima una questione che solitamente finisce per essere distante, o addirittura aliena.
Raccontare di sé e delle generazioni precedenti consente all’autore di connotare emotivamente cause e conseguenze del problema, rendendole più urgenti di quanto la sola restituzione giornalistica o scientifica riescano a fare.
La crisi climatica è una storia che si agisce collettivamente, ma si percepisce individualmente, sulle scale più gestibili del tempo personale e familiare. Nel clima siamo genitori e figli, siamo entrambe le cose, la crisi ha reso sistemico uno dei concetti più privati: l’eredità. Cosa lasciamo? E a chi?
All’ambientalismo serve una storia nuova, che non sia più una storia dell’ambientalismo, che non si chiami nemmeno più ambientalismo, che vada bene anche per Luigi e Ferdinando, che tenga conto della storia contenuta dentro la vecchia patente di guida di mio padre e sappia congedarsene in modo ordinato, che faccia sentire le persone, tutte le persone, viste. Chi non si sente visto, in politica, si ribella, anche se si sta ribellando contro se stesso e il proprio futuro.
Non è una questione di colpa, quanto di responsabilità: se chi ci ha preceduto conserva l’innocenza di non aver potuto scegliere consapevolmente, quelli che vengono dopo non possono chiudere gli occhi.
Sicuramente appartenere alla stessa generazione di Cotugno mi ha aiutato a entrare più facilmente nella sua visione delle cose: quella di chi è nato nei primi anni Ottanta e ha dovuto fare i conti tutta la vita con più di una transizione, in un perenne stato agnostico sospeso tra i ricatti della nostalgia e le illusioni del futuro, rifuggendo consapevolmente da entrambi e in continua ricerca di un’alternativa al proprio modo di vivere che fosse davvero migliorativa. Cambiamento climatico, capitalismo, coscienza di classe, genitorialità, benessere individuale ed eredità collettiva: l’esperimento memoir riesce, e le sue diverse stratificazioni si amalgamano in modo funzionale, senza mai andare a discapito del valore letterario dell’operazione.
Tempo di ritorno recupera vecchie storie per affrontarle con una prospettiva attuale. Raccoglie la sfida di Ghosh ribadendo l’urgenza di pensare a nuove narrazioni, ma dice anche che prima dobbiamo decostruire i criteri sulla base dei quali abbiamo valutato il funzionamento del nostro mondo: la ricchezza anteposta alla felicità, la novità anteposta alla cura. Il lavoro di Cotugno non è il punto di arrivo, ma uno dei tanti validi nuovi punti di partenza che si affacciano sull’orizzonte letterario per provare a immaginare il futuro della nostra società attraverso il potere della narrativa.