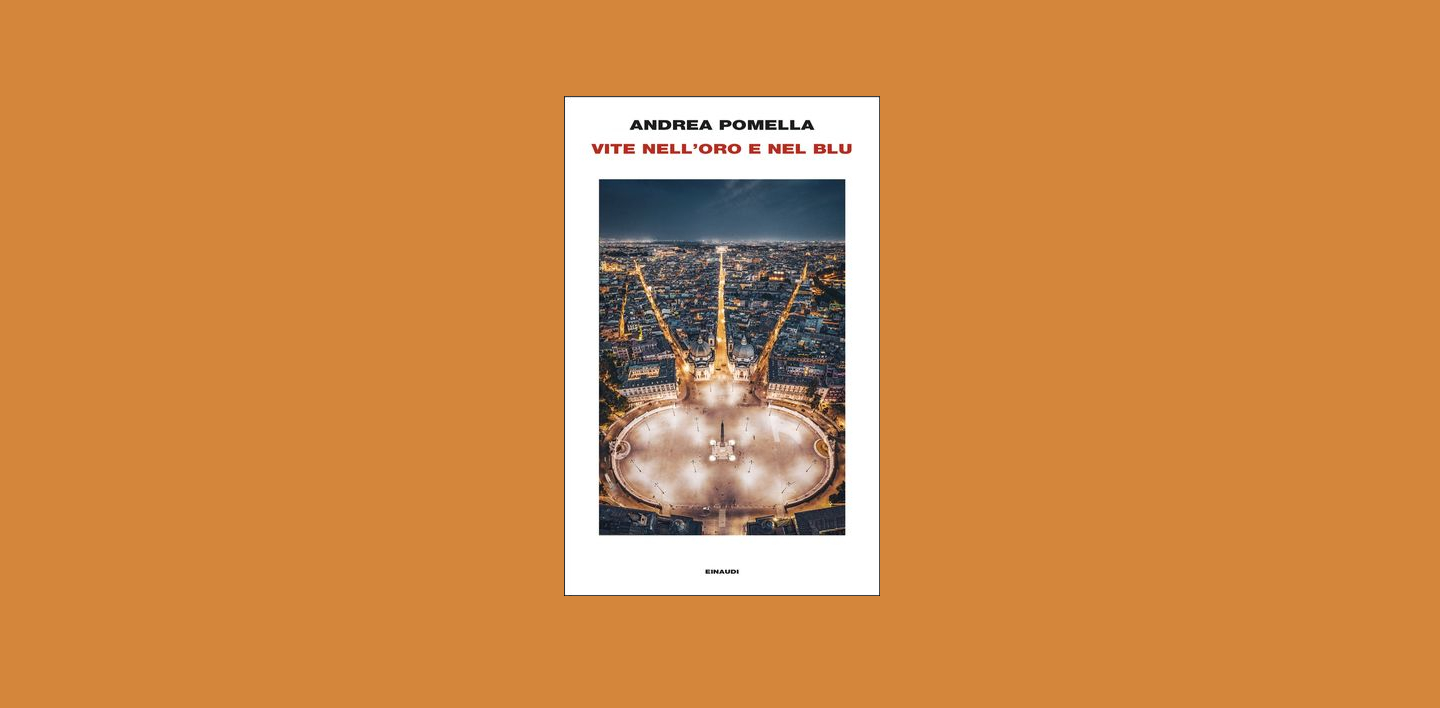
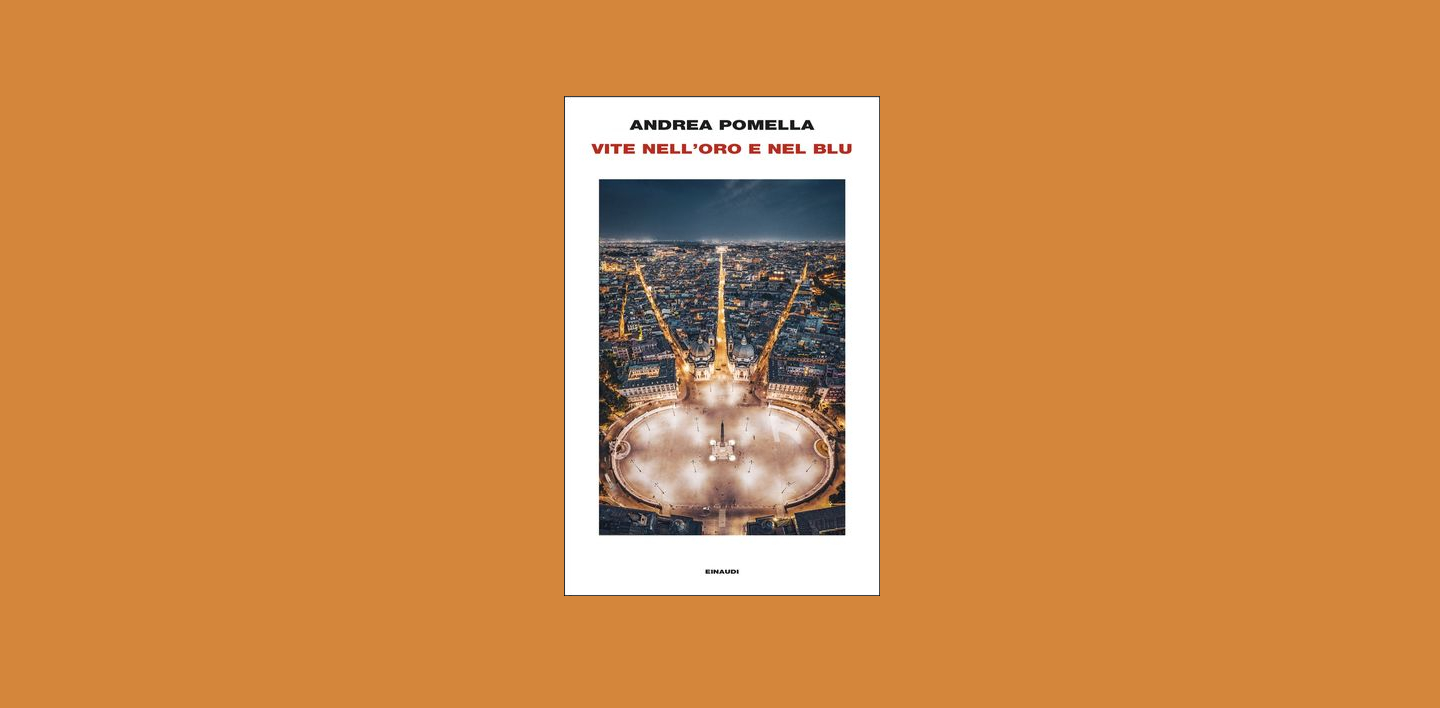
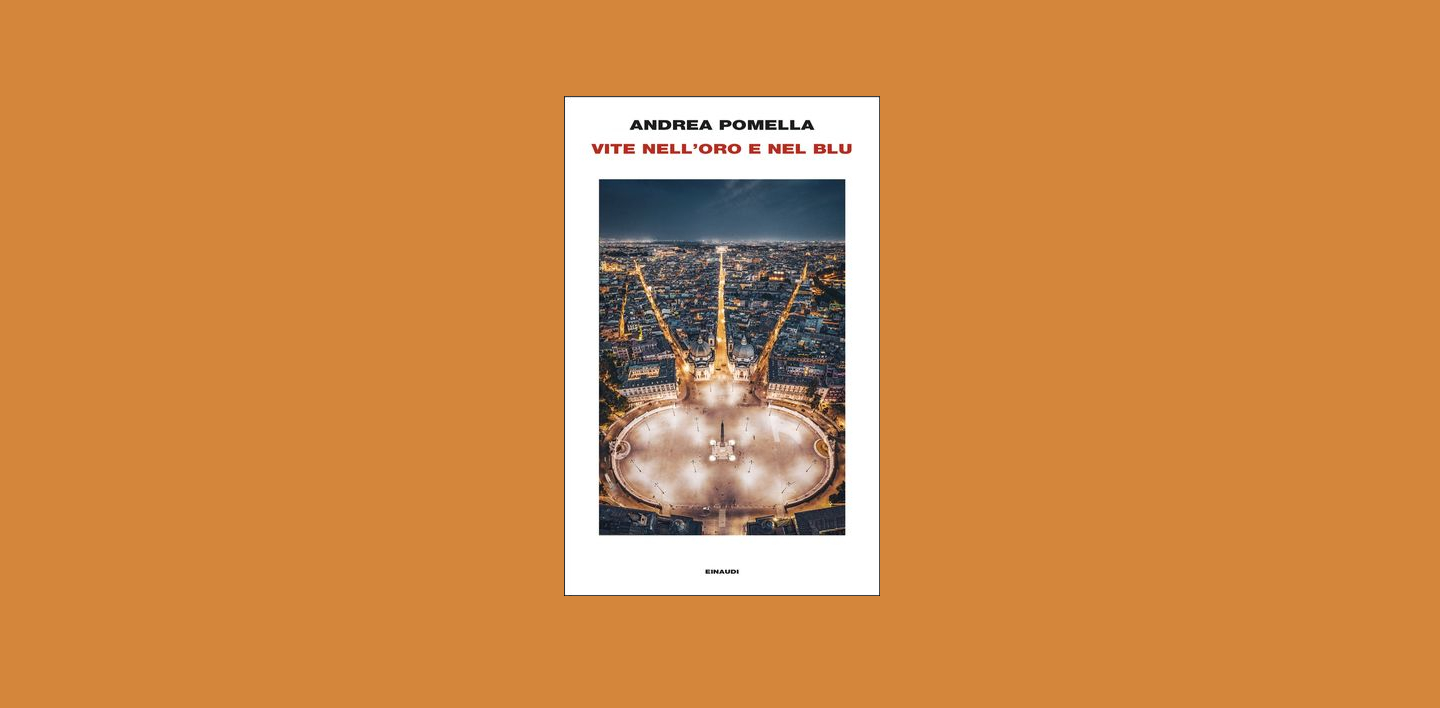
“R
oma negli anni Sessanta era bellissima” dice Nanni Moretti in Caro diario, ma quanto lo è stata, forse non lo capiremo mai per davvero, perché troppi sono i significati che questa città ha saputo generare in quella perenne crasi tra passato e presente che da sempre la caratterizza. Dire “bellissima” è più che altro dare evidenza di un’energia incredibile e forse irreale che era in circolo nel sistema nervoso di una città al tempo elettrica nel suo combattimento tra un passato fascistissimo, “la città più fascista d’Italia” scrive Goffredo Parise in L’odore del sangue, e un presente aperto alla contemporaneità come forse mai più così è stato.
La città del potere nei palazzi dei ministeri e nelle sedi di partito, ma anche la città del cinema, la Hollywood sul Tevere, la città dei pittori e degli artisti che proprio in quegli anni si raccolgono attorno ai tavolini del caffè Rosati in piazza del Popolo, o come meglio dirà Paola Pitagora, almeno inizialmente, più che altro sugli scalini attorno all’obelisco Flaminio in attesa che qualcuno, magari un po’ più fortunato e con una vendita ancora in tasca, potesse offrire agli altri un pasto o un caffè. Quegli artisti provengono dalle borgate e da un centro storico ancora ammuffito e poco ambito, in cui resistono proletari e aristocratici in bolletta. Vengono dal Quadraro, vengono da case in cui il bagno è un lusso se non un sogno. L’arte appare ai loro occhi così come un caso e poi come una necessità per sentirsi liberi e non imbrigliati in una società che si sta facendo ricca e che sta iniziando a imporre regole buone solo per essere trasgredite.
L’Italia del boom economico, che tanto ama definire “miracolo”, è già pronta a venire a patti con la propria storia elevando la piccola borghesia a status e il familismo a diritto di Stato. In tutto questo una generazione inizia a sobbollire e tra loro proprio i pittori che saranno detti “di Piazza del Popolo”. Mario Schifano, i fratelli Francesco Francesco Lo Savio e Tano Festa e infine l’inquieto comunista Franco Angeli: sono loro i protagonisti dell’ultimo romanzo di Andrea Pomella, Vite nell’oro e nel blu (2025). Pomella sceglie le loro vite, parabole a tratti assurde e spesso tragiche, per raccontare di un mondo scomparso in cui la cultura dominava la scena pubblica influenzando atteggiamenti e anticipando mode e comportamenti. L’intuizione viveva nei caffè come nelle lunghissime notti passate a discutere:
Non assomigliare alla propria città è forse uno dei drammi minori di un’esistenza, ma è pur sempre un dramma. Ha fatto molti sforzi per convincersi che Roma fosse il posto giusto per lui. D’altronde sembra esserlo per chiunque: arrivano da ogni città e da ogni nazione, arrivano a fiumi nel bel paesone che dopo secoli, dalla caduta dell’Impero romano d’occidente, sta tornando a essere il centro del mondo. Eppure a Roma, pur essendoci nato, si sente a disagio.
L’Italia del boom economico è già pronta a venire a patti con la propria storia elevando la piccola borghesia a status e il familismo a diritto di Stato. In tutto questo una generazione inizia a sobbollire e tra loro proprio i pittori che saranno detti “di Piazza del Popolo”.
Pomella evita la facile sequela degli aneddoti che pure vengono accennati qua e là nel romanzo e che hanno in parte camuffato le vite degli artisti, in particolare quella di Mario Schifano, genio sfuggente e difficile da inquadrare e definire nella sua stessa quotidianità fatta di riti ossessivi, ma anche e soprattutto, forse, di tradimenti improvvisi. La piazza resta dunque il centro, il punto di partenza attorno al quale far confluire come strade d’accesso le diverse biografie, che solo lì possono realmente ritrovarsi, intrecciarsi e restituire un valore diverso da una fatica assurda, da un dolore infinito e da passioni brucianti come a chiunque dovrebbero sempre spettare.
Perché la lettura che offre Pomella è quella più che altro di un tempo finito e concluso dentro al quale Mario Schifano, come Franco Angeli in particolare, furono i soggetti scatenanti di una contraddizione evidente ‒ ma dalla società borghese italiana sempre negata in nome di una cultura addomesticabile e priva di ogni forma possibile di conflittualità ‒, che voleva dire anche una
capacità di convivere in maniera mobilissima di più strati sociali, dalla borgata a casa Agnelli, da Alberto Moravia ai delinquenti di via di Panico. Una velocità di movimento essenziale dentro alla quale la vita certo non si conserva, ma si consuma danneggiando, ammaccando e lasciando come superstiti.
Un andamento tipico di un Novecento che si libera della tragedia della Seconda guerra mondiale, ma non del suo trauma. Essere reduci e superstiti, ovvero testimoni oculari e spesso complici di un delitto che prima dell’avvento dell’epoca odierna del vittimismo, era ancora percepito fortemente come il segno di una colpa difficile, se non impossibile da rimuovere da sé. E forse solo così si può spiegare ‒ oltre all’infinita noia e tedio contemporaneo ‒ la densità e la vitalità di chi era pronto a spendere in un giorno tutta la propria vita. Giorni che Pomella racconta fin nel cuore di notti spesso tremende e violente, perché figlie di amori travolgenti dentro a cui l’unico vero tradire sarebbe stato l’omettere.
Non è possibile distinguere opera e vita, il dire e il fare, così come l’odio e l’amore di artisti che divengono inevitabilmente e giustamente nel romanzo di Andrea Pomella eroi moderni di un tempo che possiamo solo rimpiangere e desiderare.
Un punto preciso d’equilibrio dentro al quale riconoscere un’amicizia infinita come infantile: “io sono infantile”, scrive su una tela Mario Schifano, una dichiarazione di esistenza che più esatta e potente non poteva essere nella sua infantilità dichiarata e rappresentata, così leggera, fragile, e comica e sentimentale al tempo stesso. Non è possibile distinguere opera e vita, il dire e il fare, così come l’odio e l’amore di artisti che divengono inevitabilmente e giustamente nel romanzo di Andrea Pomella eroi moderni di un tempo che possiamo solo rimpiangere e desiderare, ma dentro al quale probabilmente non avremmo saputo resistere un secondo, troppo deboli e troppo figli della piccola borghesia diffusa che sarà.