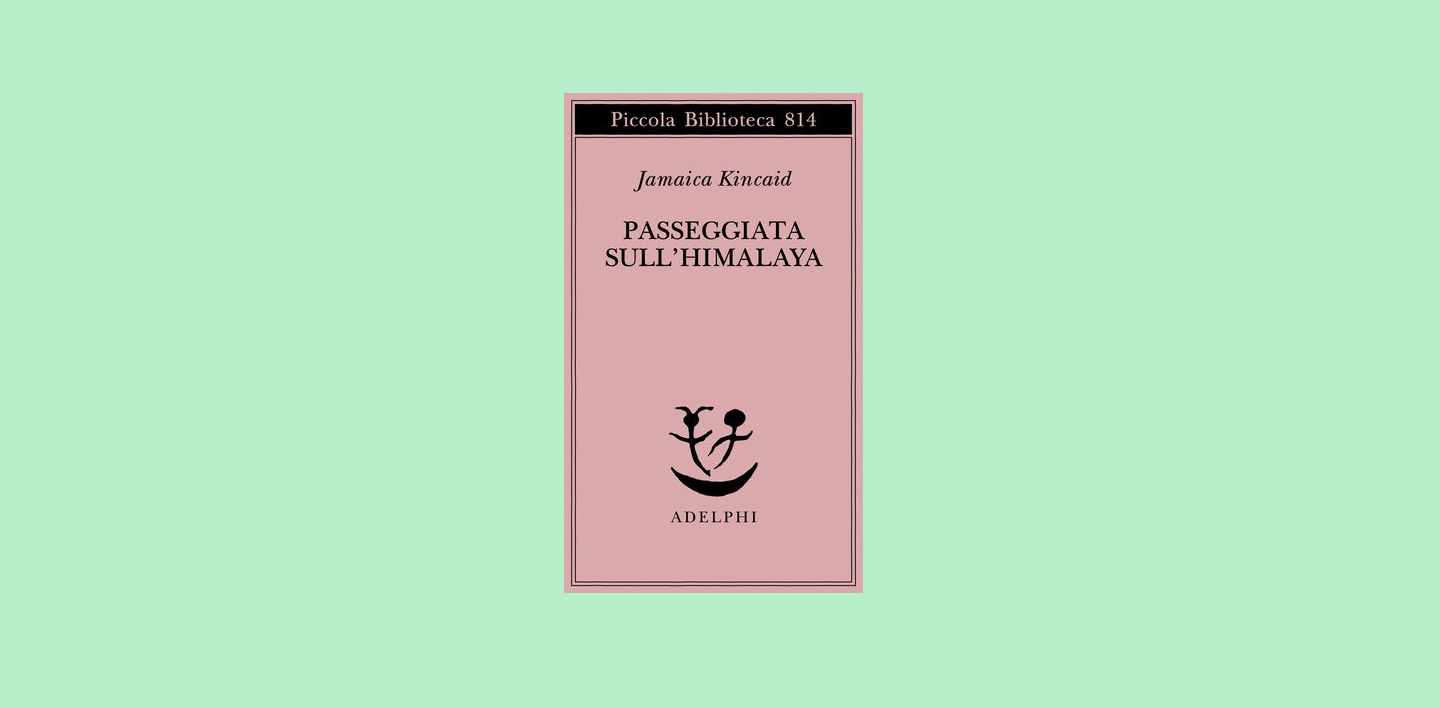
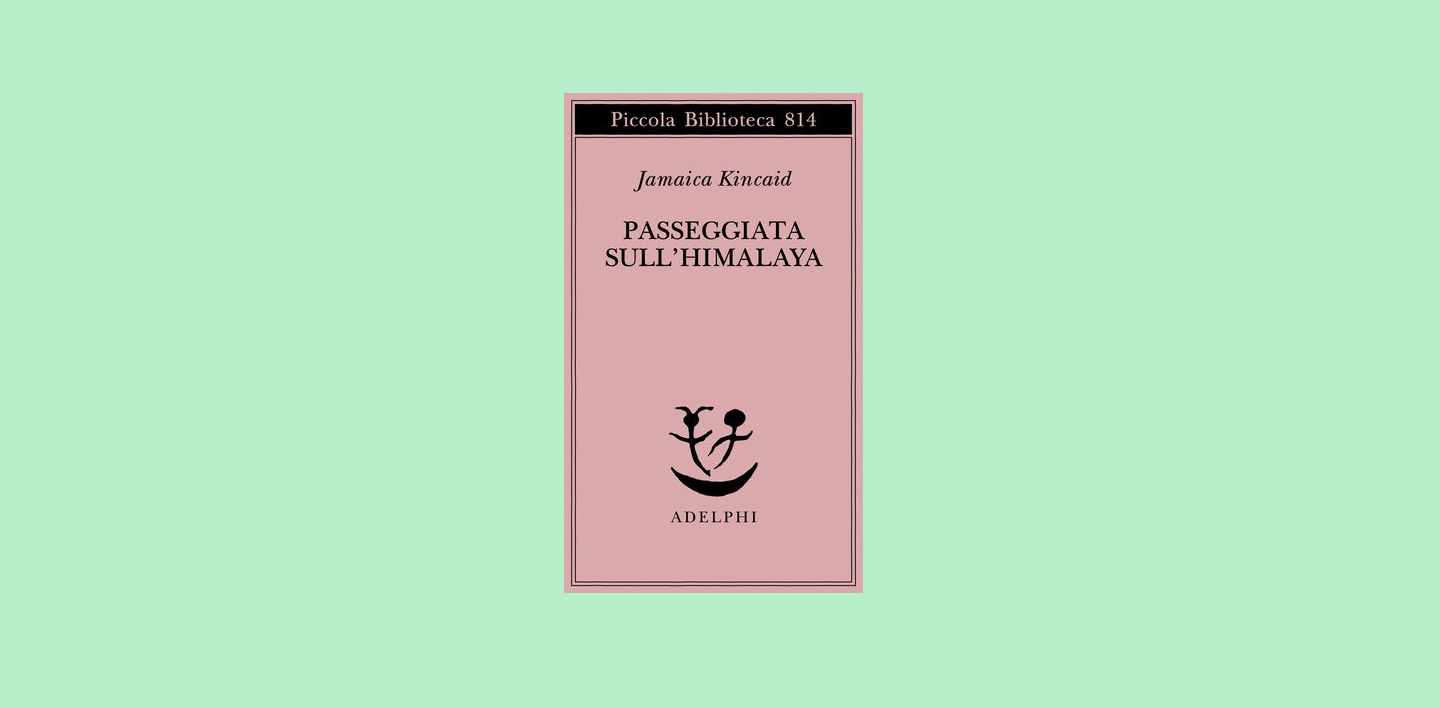
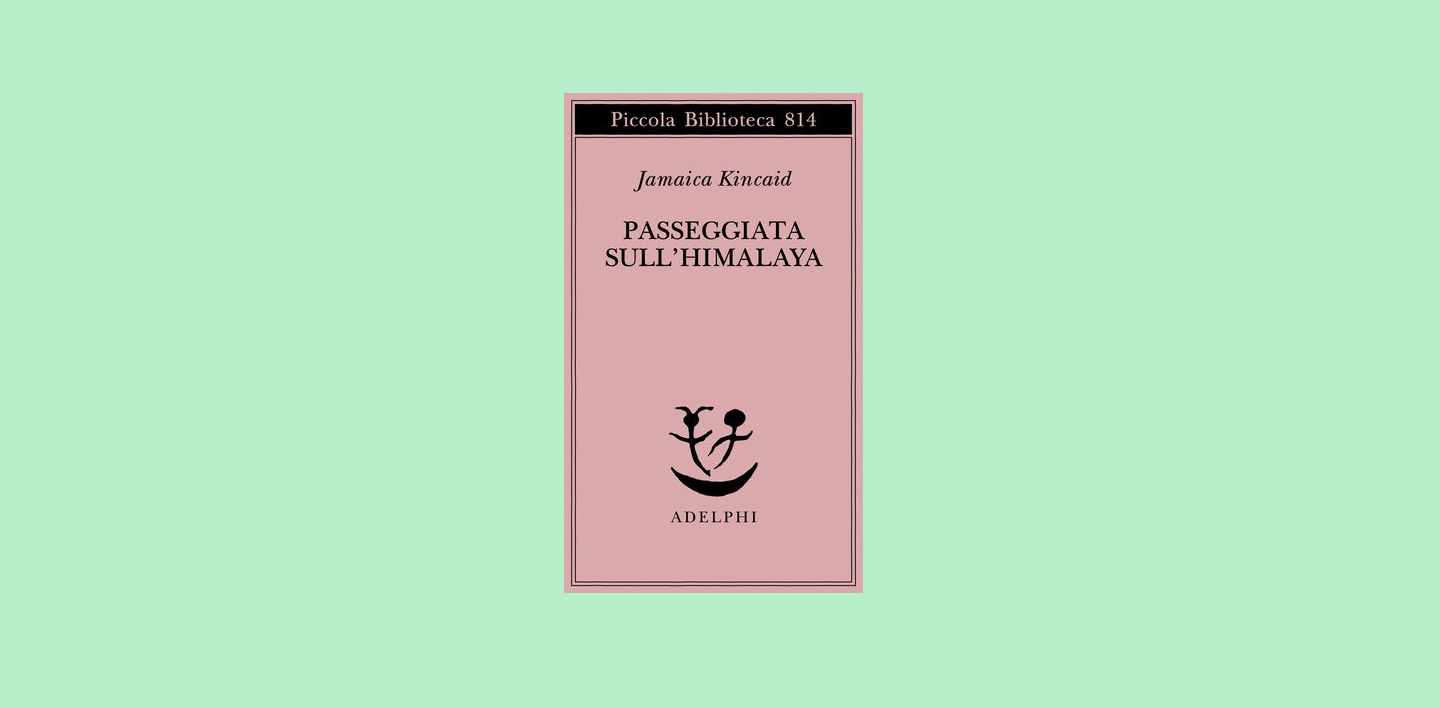
U n giardino come l’inizio di un viaggio, di una ricerca botanica che inevitabilmente finisce per riverberarsi su di sé, sulla propria autobiografia. I giardini vivono dell’ossessione di chi li cura, spesso esaltandola e portando chi se ne fa carico verso una visione mistica. Un gesto che potrebbe apparire ordinario e quasi banale solo a chi non si è mai posto in diretto contatto con il mondo naturale agendo su di sé, cambiandolo e deformandolo a seconda della propria visione e senza l’apporto di alcun filtro intermedio. Agire sulla natura direttamente con le proprie mani e con la propria determinazione. Tuttavia come accade in ogni rapporto diretto con la natura, sia che porti l’essere umano a immergersi in un oceano sia che lo porti sulla cima di una montagna, tutto ciò che si è pensato modificabile e tutto ciò che si è effettivamente modificato del contesto, per rendere possibile l’impresa, si rovescia inevitabilmente su di sé.
Non è dunque casuale che una delle scrittrici che più hanno indagato l’autobiografia a partire dal rapporto con la madre e il senso più profondo della propria identità abbia dato corpo a uno dei più interessanti, curiosi e imprevedibili libri di viaggio. Quasi come fosse una diretta conseguenza di Autobiografia di mia madre pubblicato nel 1995 e di Mio fratello del 1997, Passeggiata sull’Himalaya (2025, nella bella traduzione di Franca Cavagnoli) di Jamaica Kincaid è così interpretabile anche come un terzo potenziale pannello di un’autobiografia. Passeggiata sull’Himalaya ha la profondità di un’analisi prima ancora che di un racconto, di una rivelazione prima ancora che di una lucida decrittazione dei fatti vissuti.
La prima frase di Kincaid è sull’ossessione, quasi una citazione da Derek Jarman, che del suo giardino fece la sua ultima opera. Un giardino immerso nell’infinito deserto di ciottoli di Dungeness in Inghilterra, in un promontorio ‒ per il resto totalmente desertico ‒ sulla costa del Kent. “Il paradiso è l’ossessione dei giardini” avverte Jarman a proposito di quel luogo la cui forza mistica ancora oggi è sentita da chi lo raggiunge ‒ da più parti del mondo ‒ per celebrare il grande artista e regista, come fosse un vero e proprio luogo di culto.
Kinkaid scrive invece che l’ossessione per il giardino anticipa la sua stessa coscienza offrendole uno spazio quasi lisergico d’immersione. Prima ancora che un paradiso in Terra (o nella terra) è dunque un paradiso che prende corpo da e nella propria mente. Un luogo capace di dare forma a colori e profumi in uno spazio splendidamente organizzato e strutturato di piante e fiori: “Ma dov’è il giardino e dove sono io al suo interno? Il ricordo di coltivare delle cose, qualsiasi cosa, fuori non dentro, è rimasto nella mia memoria o comunque si chiami quel filo ossessivo, quella scia invisibile che fa saldamente parte del nostro essere”. E da questa ossessione prende forma naturalmente l’idea di un viaggio in Nepal alla ricerca di semi per il proprio giardino. Quasi una scusa che si rivela una motivazione sostanziale e necessaria al viaggio.
L’ossessione per il giardino anticipa la sua stessa coscienza offrendole uno spazio quasi lisergico d’immersione. E da questa ossessione prende forma naturalmente l’idea di un viaggio in Nepal alla ricerca di semi. Quasi una scusa che si rivela una motivazione sostanziale e necessaria al viaggio.
Il viaggio ‒ o meglio la passeggiata ‒ prende avvio ben prima della partenza, mutando la quotidianità di Jamaica Kincaid con tutte le urgenze da assolvere prima di partire. Incombenze di preparazione alla partenza, comprese non di meno anche quelle tediosamente burocratiche. Un movimento caotico, noioso e stressante che Kincaid vive con inusitato entusiasmo, ma anche con un crescente stato d’ansia. Le pagine si fanno elenchi di cose da procurare, spunte da mettere prima di partire. Il viaggio assume come la forma di una preparazione a una festa che l’autrice sembra saper gestire con la leggerezza necessaria. Queste pagine sembrano così sovrapporsi a quelle di Virginia Woolf ne La signora Dalloway. Tutto potrebbe apparire vacuo, mentre in realtà tutto rivela come queste inezie offrano un senso esistenziale d’urgenza e una necessità non più rimandabile. Una festa, così come una passeggiata, richiedono l’apparecchiare una serie di riti essenziali, poco conta che alcuni siano di tipo pratico e altri meno.
La partenza non è mai messa in dubbio nemmeno quando sul cielo di New York si scatena l’inferno dell’11 settembre e tutto il mondo e gli Stati Uniti vivono giorni di ansia e terrore: “Avevo la sensazione che fosse tutto pronto per la partenza e poi sopraggiunge quel nuovo Stato di Esistenza chiamato ‘Gli avvenimenti dell’11 settembre’. Quanto sono grata alla capacità tutta americana di ridurre molte cose a un’abbreviazione, poiché nello scrivere queste parole, Gli avvenimenti dell’11 settembre, non devo dare una vera e propria spiegazione, una spiegazione dettagliata della ragione per cui feci questo viaggio un anno dopo”.
La partenza è rimandata segnalando anche nella gratitudine verso la capacità americana di sintesi la necessità di visualizzare una ragione interiore che si esprima in un’azione esteriore. Il momento e il tempo del viaggio vivono esattamente come nella cura di un giardino, ovvero in uno spazio interno ancora del tutto invisibile e chiaro, ma certamente sensibile e avvertibile. Kincaid scrive della strenua resistenza che si oppone in genere a questo movimento che dovrebbe essere fluido e quindi rigenerante, ma che spesso vive tremendamente il disagio di un giudizio che forse colpisce esternamente solo lateralmente, ma va poi piano piano, goccia a goccia, a incidere nelle ragioni più profonde e interiori del nostro essere.
Il momento e il tempo del viaggio vivono esattamente come nella cura di un giardino, ovvero in uno spazio interno ancora del tutto invisibile e chiaro, ma certamente sensibile e avvertibile.
Passeggiata sull’Himalaya offre un’analisi accuratissima del sentire che solo uno sforzo inconsueto come quello di raggiungere le più alte vette può rivelare, tanto più a chi nella propria vita tendenzialmente si arrischia al massimo ad attraversare la strada a New York (cosa comunque non da poco). Lo sforzo e la sofferenza che l’impresa produce sul corpo rivelano un sottile piacere che si trasmette agli altri sensi, primo fra tutti alla vista. Lo sguardo, come anche nei precedenti libri di Kincaid ‒ ma qui ancora più potentemente ‒, dilaga sull’infinito orizzonte nepalese:
La persona che viveva in un paesino del Vermont non si era smarrita, la persona che esisteva prima non si era smarrita. Ero seduta a un’altitudine di poco superiore ai milleottocento metri, in uno spiazzo sul fianco di una collina pedemontana dell’Himalaya. Solo sull’Himalaya una simile altezza si chiama collina. In qualsiasi altro luogo questa è l’altezza di una montagna. Ma là dove sedevamo eravamo sul fondo ‒ poiché vedevamo altre vette in alto sopra di noi, in ogni direzione un orizzonte più alto. Si levò la luna, piena e luminosa.
Kincaid non si perde, anzi ritrova in sé il motivo del viaggio, la ricerca dei semi, un’avventura che la deve portare direttamente nel suo giardino nel Vermont. Un testacoda che contiene un’idea vitalissima di viaggio come permanenza costante. Un’inclusione che diviene reale accoglienza, una solidità identitaria che è tale proprio perché frutto di una frammentazione naturale, uno scioglimento che diviene intreccio e svelamento del sé.
Passeggiata sull’Himalaya si discosta dai molti libri di viaggio d’autore oggi sempre più diffusi sugli scaffali delle librerie. Volumi in cui il viaggio assume nel senso della narrazione la forma di un accessorio o di un fondale; qui invece il viaggio con tutta la sua fatica e anche la paura dell’imprevisto risalta nelle pagine; il Nepal è al centro di una riflessione certo tutta interiore all’autrice, ma determinandone fortemente sentimenti e desideri. Jamaica Kincaid non si perde e non si ritrova, ma più semplicemente ritorna. Un movimento spesso sottovalutato, ma assolutamente centrale in ogni viaggio.